 Della gloriosa schermaglia che da sempre oppone il regista all’attore, il cinema di Ingmar Bergman ha offerto esempi e soluzioni cospicui. Purché la si intendesse nell’unica modalità da lui consentita: opposizione, lotta, assenza di dialettica e di confronto. Parecchi di noi sono diventati adulti guardando i film di Bergman, custodendo nel portafoglio dell’inconscio alcune invarianti che ostinatamente quell’opera ci ha tramandato: la luce delle brume nordiche, il chiarore abbacinante delle estati boreali, la drammaturgia estrema e ossessiva dei dialoghi, oltre appunto alla dinastia – e alla sovranità – del volto degli attori. Affrontare Bergman oggi vuol dire sostanzialmente riconoscere – e accogliere – la forza prepotente di una contraddizione: da un lato, il suo universo filmico appare chiuso, serrato, pericolosamente claustrofobico, una sorta di zona riservata dove alloggiano sentimenti affaticati e rovelli psichici insoluti; dall’altro, esso si presenta austero regale maestoso, avvolto nell’aura millenaria delle grandi parole, dei temi definitivi che riguardano la condizione umana, il nostro essere al mondo, l’anelito verso la trascendenza.
Della gloriosa schermaglia che da sempre oppone il regista all’attore, il cinema di Ingmar Bergman ha offerto esempi e soluzioni cospicui. Purché la si intendesse nell’unica modalità da lui consentita: opposizione, lotta, assenza di dialettica e di confronto. Parecchi di noi sono diventati adulti guardando i film di Bergman, custodendo nel portafoglio dell’inconscio alcune invarianti che ostinatamente quell’opera ci ha tramandato: la luce delle brume nordiche, il chiarore abbacinante delle estati boreali, la drammaturgia estrema e ossessiva dei dialoghi, oltre appunto alla dinastia – e alla sovranità – del volto degli attori. Affrontare Bergman oggi vuol dire sostanzialmente riconoscere – e accogliere – la forza prepotente di una contraddizione: da un lato, il suo universo filmico appare chiuso, serrato, pericolosamente claustrofobico, una sorta di zona riservata dove alloggiano sentimenti affaticati e rovelli psichici insoluti; dall’altro, esso si presenta austero regale maestoso, avvolto nell’aura millenaria delle grandi parole, dei temi definitivi che riguardano la condizione umana, il nostro essere al mondo, l’anelito verso la trascendenza.
Temi e arabeschi che l’attore bergmaniano si incarica ogni volta di tradurre in azioni e opere, legandosi e intrecciandosi senza soluzione di continuità alla volontà e voluttà del regista-dominus, esibendo e vantando la propria insostituibilità, al punto che sarebbe lecito porre ai lettori di questo Blog la domanda: avete mai visto un attore di Bergman recitare male oppure apparire “fuori ruolo”?
 Proprio trent’anni addietro (aprile ’84), dopo la fortunata prova di “Fanny e Alexander” – considerato il film testamento – Bergman dava alla luce un’opera apparentemente “minore”, scritta per la televisione, con un titolo dimesso, “Dopo la prova”, (“Après la répetition”, in lingua francese).
Proprio trent’anni addietro (aprile ’84), dopo la fortunata prova di “Fanny e Alexander” – considerato il film testamento – Bergman dava alla luce un’opera apparentemente “minore”, scritta per la televisione, con un titolo dimesso, “Dopo la prova”, (“Après la répetition”, in lingua francese).
Tre personaggi, un unico luogo di ripresa (il proscenio di un teatro), una trama-sceneggiatura che misura 72 minuti, affollata esclusivamente di ombre fantasmi e dialoghi a due voci, quindi fortemente condizionata dalla supremazia dell’attore.
Il regista Henrik Vogler (Erland Josephson), conclusa la giornata di prove al “Royal Dramatic Theatre” di Stoccolma, è rimasto solo sul proscenio, probabilmente desideroso di gustare la tregua, una volta sopiti gesti parole e movimenti dei personaggi, chetata la sua stessa voce, che prefiguriamo ostinata e invadente.
Al posto delle voci, ora, il minaccioso – intimidatorio – silenzio dello spazio-teatro, che consente a noi spettatori di fantasticare sulla dignitosa vetustà di quel luogo, di riconoscere nel colore livido dell’impiantito di legno i mille passi, i mille calpestii delle generazioni di attori, di interpreti, che su quella ribalta hanno cercato dimora.
 Henrik si è addormentato sul copione di scena, sotto la sua testa giace il canovaccio del Sogno di August Strindberg, con tante frecce e annotazioni in rosso, come vedremo quando solleverà il capo (notare che non è la prima volta che mette in scena questa pièce…), ma c’è una parte del suo intelletto che è rimasta sveglia, desta, vigile, la parte che chiamerei – pirandellianamente – del ruminatore di parole e di concetti, l’individuo impegnato a cadenzare con cavillosità la propria esistenza, che non vuol saperne di riposare, di mettersi in mora e in pacificata sospensione.
Henrik si è addormentato sul copione di scena, sotto la sua testa giace il canovaccio del Sogno di August Strindberg, con tante frecce e annotazioni in rosso, come vedremo quando solleverà il capo (notare che non è la prima volta che mette in scena questa pièce…), ma c’è una parte del suo intelletto che è rimasta sveglia, desta, vigile, la parte che chiamerei – pirandellianamente – del ruminatore di parole e di concetti, l’individuo impegnato a cadenzare con cavillosità la propria esistenza, che non vuol saperne di riposare, di mettersi in mora e in pacificata sospensione.
Ed è la “parte” che immediatamente prende il sopravvento avviando ciò che in letteratura si chiama flusso di coscienza o “monologo interiore” e che funziona da conoscenza vigile in grado di suscitare – evocandoli – presenze, fantasmi, visioni, flash-back.
Passano appena 75 secondi e sul proscenio fa ingresso – in concitata irruzione – Anna Egerman (Lena Olin), una delle protagoniste di ruolo nella pièce, ora apparentemente in confusione e in trambusto: “Scusa se ti disturbo ma non trovo più il braccialetto, perdo sempre tutto”.
 Tra i due inizia un lungo dialogo, interrotto o sovrastato qui e là dalle riflessioni “fuori campo” di lui, una sorta di voce carsica che si sovrappone all’imbastitura del discorso, porgendo valutazioni drastiche, giudizi apodittici, evidenziando insomma allo spettatore – qualora ce ne fosse bisogno – che in quell’ambito il potere di concertazione – sia scenico che esistenziale – lo detiene uno soltanto: il regista.
Tra i due inizia un lungo dialogo, interrotto o sovrastato qui e là dalle riflessioni “fuori campo” di lui, una sorta di voce carsica che si sovrappone all’imbastitura del discorso, porgendo valutazioni drastiche, giudizi apodittici, evidenziando insomma allo spettatore – qualora ce ne fosse bisogno – che in quell’ambito il potere di concertazione – sia scenico che esistenziale – lo detiene uno soltanto: il regista.
Per avere un’idea del “tono” interiore utilizzato da Vogler, ecco un esempio pronunciato pochi minuti dopo l’ingresso della giovane Anna: «Noia, distanza, apprensione… e questo gusto acre di ferro sulla lingua. Vorrei che lei sparisse, questa storia del braccialetto è un falso pretesto. Perché non vai via?».
Di contro, alla novizia Anna Egerman, cui Bergman non ha regalato il “flusso di coscienza”, spetta pronunciare battute oneste e virtuose: «Non faccio niente di speciale stasera, sarei pronta a provare con te giorno e notte… se tu lo volessi».
 Una volta precisata la gerarchia dei ruoli, inizia il dialogo tra l’anziano regista e la giovane attrice, di cui riproduco alcuni brevi stralci, basandomi sui sottotitoli dell’edizione francese del dvd, rimaneggiandoli con una lieve cadenza letteraria.
Una volta precisata la gerarchia dei ruoli, inizia il dialogo tra l’anziano regista e la giovane attrice, di cui riproduco alcuni brevi stralci, basandomi sui sottotitoli dell’edizione francese del dvd, rimaneggiandoli con una lieve cadenza letteraria.
Dialogo Uno:
Henrik: Che età hai Anna Egerman?
Anna: Indovina!
H: Avrai l’età della mia figlia più giovane. Ho girato un film con tuo padre… e ricordo che abbiamo avuto una figlia a distanza di otto giorni l’uno dall’altro: hai 23 anni e 3 mesi.
A: Dimmi una cosa: tu e papà vi divertivate parecchio?
H: Una domanda che sembra un rimprovero…
A: Per me papà era un uomo sempre in viaggio e la mamma una donna sempre triste. Lei era davvero un’attrice eccezionale?
H: Sì, vero, mia piccola Anna. Una mamma straordinariamente bella. Affascinante, ricca di talento, appassionata del lavoro. Ha abbandonato le scena per sposare Mikael.
A: Anche tu eri innamorato di lei?
H: Logico. Come tutti.
A: Avete avuto una storia?
H: No. Eravamo bravi a mantenere le distanze. Mikael è stato più coraggioso o più temerario. E guarda che frutto delizioso hanno messo al mondo.
A: Mia madre non ha amato i suoi figli, è morta alcolizzata. Un giorno le ho chiesto perché aveva lasciato il teatro. Mi ha risposto che amava mio padre e non voleva rovinare la sua vita. Che ipocrita!
H: Strano sentirti parlare così di lei.
A: Sono troppo dura?
H: Diciamo che non hai pietà.
A: Dovrei inventarmi una pietà? Mi ci sono voluti anni per riuscire a odiare mia madre e superare un’angoscia che mi rendeva pazza. Ora finalmente la odio e mi sento molto meglio. Per lei ormai il problema non si pone più, la morte lo ha regolato per sempre.
Dialogo Due:
Henrik: Tu vuoi che io ti persuada che sei l’attrice giusta per quel ruolo… è mio dovere farlo ma è anche il segreto del nostro rapporto. Tu hai bisogno che io creda in te e che te ne dia continuamente la dimostrazione. Se risulto convincente con le parole, sia sul piano intellettuale che emozionale, tu finirai per credere in me e di conseguenza in te stessa.
Anna: Perché allora sei così critico? Cambi ogni cosa che faccio, ogni mia timida iniziativa, mi rimproveri tutto… e io piango di disperazione tornando a casa. Io non credo proprio che tu creda nelle mie capacità!
Henrik: Io non credo in te? Non ho sentito niente di più idiota in queste settimane! La verità è che piangi e ti lamenti in continuazione… ti piace da morire commiserarti.
Dialogo Tre:
Anna: La tua strada è cosparsa di cadaveri di attori. Hai fatto un conto di quante sono le tue vittime?
Henrik: Nella vita reale credo di aver ferito parecchie persone, porto anche le tracce del loro corpo…
A: E in teatro?
H: In teatro no! Voglio confidarti una verità “evangelica”: io gli attori li amo. Li amo per quello che sono, per il loro impegno, il loro coraggio, il loro disprezzo della morte. Capisco le loro fughe, le loro smanie, anche la loro franchezza spietata. Mi piace quando tentano di manipolarmi, credendo che io non me ne accorga: sono creduloni e lungimiranti al tempo stesso. Mi sento fin troppo vicino alle loro esistenze inquiete e irrisolte, non potrei ferirli.
A: Non sei mai deluso da loro?
H: No. Il mio vecchio professore di teatro diceva che gli attori si dividono in due categorie: quelli che entrano in scena e quelli che dalla scena escono.
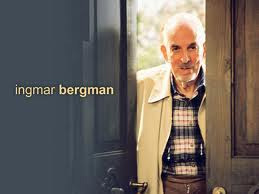 Ecco una drammaturgia schiettamente bergmaniana, della quale potrebbe fare buono o cattivo uso chiunque volesse riproporne la “maniera”, come accadde a Woody Allen nel ‘78 per Interiors.
Ecco una drammaturgia schiettamente bergmaniana, della quale potrebbe fare buono o cattivo uso chiunque volesse riproporne la “maniera”, come accadde a Woody Allen nel ‘78 per Interiors.
Ma il punto, il rovello, che si vuole qui porre in evidenza riguarda la presunta credibilità – oggi – di tale struttura dialogica, che non soltanto palesa senza indugi il “debito” verso il teatro ma svela – ancora una volta – le condizioni strutturali che hanno reso possibile e longevo il cinema di Bergman.
Ciò che Henrik Vogler – il regista pieno di vizi, di disincanto, di malintesi con il medesimo sé – non ha il coraggio di dire alla “sua” attrice, della quale subisce la frizione erotica tentando goffamente di dissimularla con un carico di parole “ragionevoli”, è che quella scena, quel dialogo, quello stare a ridosso delle parole – confermando una drammaturgia che non prevede vie di fuga – sono già avvenuti, innumerevoli volte, e non fanno che confermare il dato “manierista” di Bergman – e di Vogler che è il suo doppio – ossia la “gabbia”, la condizione di costrizione dentro cui il regista è rinchiuso insieme ai suoi attori.
Non c’è luce di redenzione oltre quel proscenio, anche perché il regista Vogler-Bergman non avrebbe tollerato che ci fosse. Lo spazio “reale” di quel palcoscenico non si può oltrepassare, il regista ha piantato presumibilmente un cartello che recita: Vietato vivere fuori di qui!
L’unica scappatoia, di non grande consolazione, rimane quel falsetto che Henrik borbotta con ignavia, riproducendo gli arabeschi della sua mente, elucubrando concetti di cosiffatta schiettezza:
«Perché dico queste cose? Perché queste banali parole? Perché vantare questo simulacro di convinzione? Che bisogno c’è che io mi giustifichi davanti a questa ragazzina che se ne frega delle cose che penso?».
 Dopo 25 minuti e 30 secondi di dialogo serrato, appare il fantasma di Rakel (Ingrid Thulin), un terzo incomodo nella terra dei fantasmi e degli spettri: Rakel, la mamma di Anna, l’attrice drammatica più volte evocata nei racconti della figlia come disperata alcolista… la quale per prima cosa, come primo gesto, si offre candidamente a Henrik:
Dopo 25 minuti e 30 secondi di dialogo serrato, appare il fantasma di Rakel (Ingrid Thulin), un terzo incomodo nella terra dei fantasmi e degli spettri: Rakel, la mamma di Anna, l’attrice drammatica più volte evocata nei racconti della figlia come disperata alcolista… la quale per prima cosa, come primo gesto, si offre candidamente a Henrik:
«Vuoi fare l’amore?»
«Qui?»
«Qui. Non sarebbe la prima volta!»
Svelando definitivamente il patto che tra loro due si era consumato ai tempi del lavoro comune, confermando che la vera “sposa” della scena bergmaniana è appunto il fantasma, questa figurazione eternamente sospesa tra realtà ed evocazione, di cui gli attori devono fare assiduamente esperienza interiore, riverberandola nei loro volti.
Dice Anna Egerman, a proposito di sua madre: «Un giorno le ho detto: “Mamma, smettila di recitare la tua commedia! Non sono un buon pubblico io, per te!”. Mi ha lanciato uno sguardo di odio e ha risposto: “È il solo modo che conosco per esprimermi, non ne conosco altri! Vero o falso che sia, io sono sola e soffro! Cerca di comprendere questo mio stato!”».
E Rakel, quando vuole estorcere la benevolenza di Vogler, sussurra: «Io so leggere sul tuo volto, dietro il tuo volto, dentro il tuo volto. Noi non abbiamo segreti».
Ci interessa poco capire “chi è fantasma a chi”, come si sforzano di fare instancabilmente gli psicoanalisti tormentati dalla forza dell’immagine bergmaniana.
Ci interessa la cifra stilistica che si impone dentro quel contesto, fissata sui primi piani, i campi ravvicinati dei volti, la scansione spasmodica campo-controcampo che riesce a non mostrare mai la corda – al punto da materializzare plasticamente la tensione del dialogo: insomma la potenza di uno stile capace di tenere desti, nella loro immota andatura, personaggi e battute che in altri registi sarebbero divenuti stanche reliquie.
Quanto più ci appare “anacronistico” – soprattutto oggi – quel fantasma sgusciato dalla testa di Vogler, tanto più capiamo che soltanto la forza di un attore che abbia introiettato la genealogia bergmaniana può riuscire a renderlo vivo e credibile.
Un magistero interpretativo che non può darsi senza la natura – coercitiva, dispotica – di quel patto originario intercorso tra il cineasta e i suoi attori.
 Nel 1981, il critico Giovanni Macchia lanciò una formula precisa e vincente per connotare il teatro di Pirandello: lo chiamò “stanza della tortura”. Ecco un autore-profeta da cui Bergman probabilmente mutuò parecchie “ispirazioni” (sebbene poco citato nelle note a margine dei suoi libri…), non esclusi i tre deliziosi racconti dedicati ai “Personaggi” della raccolta Novelle per un anno (Personaggi, Colloqui coi personaggi, Tragedia di un personaggio), oltre al testo che costituisce la più profonda ferita storica inferta al teatro moderno, Sei personaggi in cerca d’autore, che il regista svedese portò più volte sulla scena con i suoi attori.
Nel 1981, il critico Giovanni Macchia lanciò una formula precisa e vincente per connotare il teatro di Pirandello: lo chiamò “stanza della tortura”. Ecco un autore-profeta da cui Bergman probabilmente mutuò parecchie “ispirazioni” (sebbene poco citato nelle note a margine dei suoi libri…), non esclusi i tre deliziosi racconti dedicati ai “Personaggi” della raccolta Novelle per un anno (Personaggi, Colloqui coi personaggi, Tragedia di un personaggio), oltre al testo che costituisce la più profonda ferita storica inferta al teatro moderno, Sei personaggi in cerca d’autore, che il regista svedese portò più volte sulla scena con i suoi attori.
La scena teatrale e cinematografica come “stanza della tortura”: potrebbe risultare una definizione efficace e calzante per focalizzare il nucleo problematico dell’itinerario di Ingmar Bergman?
Attori che sulla scena diventano corpi: corpi offerti, violati, contaminati: corpi che nel taglio dell’inquadratura vivono a ridosso dei loro stessi volti, perciò impossibilitati a farsi “trasparenza”, a “oltrepassarsi”, ciò che avrebbe consentito l’uscita e l’estensione di ciò che si muove “oltre” di essi (come poi accadrà ai disincantati attori del cinema anni ’70).
Corpi che invocano la centralità dell’accadimento, dello sguardo, dello spazio, forgiati nella monotona maniacalità di quella costante militanza teatrale, nelle prove a tavolino celebrate tutti i giorni dell’anno, tra gli scatti d’ira del regista, le sue tremende collere.
 Il cinema di Bergman come officina perpetua del farsi dell’Attore.
Il cinema di Bergman come officina perpetua del farsi dell’Attore.
Guardiamo il caso Ingrid Thulin, le numerose incarnazioni che i film di Bergman le hanno consentito, prima che questo ultimo film sancisse la sua nascita come fantasma (il discorso varrebbe naturalmente per l’intera stirpe bergmaniana: Gunnar Bjornstrand, Liv Ullmann, Harriet Andersson, Bibi Andersson, Erland Josephson, Max von Sydow): è stata Sara per Il posto delle fragole, Cecilia per Alle soglie della vita, Marta in Luci d’inverno, Ester per Il silenzio, Veronica per L’ora del lupo, Karin in Sussurri e grida, Thea per Il rito, Rakel in Dopo la prova, coprendo un arco di anni che scorre dal ’57 all’84.
E di lei, di Rakel, rimane alla fine del colloquio-scontro con Henrik Vogel questa mescolanza di menzogna e verità, di nascondigli e uscite di sicurezza, attraverso cui il suo “volto” transita, componendosi e ricomponendosi tra mille variazioni, come se non fosse mai uscito da quella “scena”.
C’è un istante di assoluta sincerità alla fine dell’estenuante confronto con l’amato e odiato regista, che pare incrinare finanche la boriosa sicurezza di Vogel: è quando Rakel al culmine del diapason drammaturgico, gettando sul piatto tutta la sua “autorevolezza” scenica, grida: «Eccomi nelle tue mani!». «Ed io nelle tue!», risponde Henrik.
 I bergmaniani di lungo corso e di fede duratura sanno che nessun volume di reminiscenze o memorie a firma Bergman –Lanterna magica, edito nel ‘90 – potrà competere con il libro apparso in Svezia vent’anni prima – in Francia nel ’73 – che raccoglie 13 conversazioni con il regista, registrate e annotate da tre giovani appassionati di cinema – Stig Bjorkman, Torsten Manns, Jonas Sima – impazienti di rischiarare l’ampia poetica del maestro: domande a cui Bergman prestò il fianco senza false modestie e reticenze, argomentando con scrupolo la sua visione del teatro del cinema del mondo e, naturalmente, degli attori.
I bergmaniani di lungo corso e di fede duratura sanno che nessun volume di reminiscenze o memorie a firma Bergman –Lanterna magica, edito nel ‘90 – potrà competere con il libro apparso in Svezia vent’anni prima – in Francia nel ’73 – che raccoglie 13 conversazioni con il regista, registrate e annotate da tre giovani appassionati di cinema – Stig Bjorkman, Torsten Manns, Jonas Sima – impazienti di rischiarare l’ampia poetica del maestro: domande a cui Bergman prestò il fianco senza false modestie e reticenze, argomentando con scrupolo la sua visione del teatro del cinema del mondo e, naturalmente, degli attori.
«Gli attori sono troppo spesso nel mirino del regista e della critica, su di loro si addensano eccessive attenzioni e responsabilità. Tocca a loro stare sulla scena o davanti la macchina da presa. Noi altri siamo protetti, possiamo risolvere i nostri errori con una smorfia o una battuta spiritosa. Loro no, non possono farlo. Sono sempre in mostra, sempre visibili, con il loro corpo e il loro volto. Ecco perché mi pare opportuno, moralmente, assumere la loro difesa.
Gli attori con cui non amo lavorare sono quelli che vorrebbero sostituire un tono o una posa da intellettuale alla sensualità e all’immaginazione. A volte trasformano la loro paura, la timidezza, il pudore o semplicemente la mancanza di talento in qualcosa d’altro, per tirarsi fuori dalle difficoltà. Ma presto o tardi ci sbattono il muso!».
 Un accostamento legittimo a Dopo la prova è il film “Persona”, anno ’66, la storia dell’attrice Elizabeth (Liv Ullmann) che si blocca improvvisamente nella parola durante una rappresentazione teatrale dell’”Elettra”, rimanendo immobilizzata e isolata nel silenzio, rifiutando di interagire con il mondo, come se nel mutismo volontario avesse trovato una via d’accesso alla verità delle cose.
Un accostamento legittimo a Dopo la prova è il film “Persona”, anno ’66, la storia dell’attrice Elizabeth (Liv Ullmann) che si blocca improvvisamente nella parola durante una rappresentazione teatrale dell’”Elettra”, rimanendo immobilizzata e isolata nel silenzio, rifiutando di interagire con il mondo, come se nel mutismo volontario avesse trovato una via d’accesso alla verità delle cose.
Ricoverata in una clinica, viene affidata in assistenza all’infermiera Alma (Bibi Andersson), una sconosciuta “gemella” che progressivamente si unisce al suo destino, condividendo e identificandosi in quel mutismo assordante, fino a sovrapporre – e scambiare – con l’ammalata il proprio volto, la propria “figura”, come se volesse suggellare – forse a nome di tutti gli attori – l’appartenenza definitiva a quella scena artistica esclusiva e fatale.
 In conclusione, rimane il rammarico – almeno per chi scrive – di non aver mai potuto spiare una sessione di “prove” tra Bergman e i suoi attori: quel rito di famiglia (Il rito è anche il titolo di un film, anno ‘67), durante il quale si imbastiva meticolosamente, pazientemente – a volte tra insopportabili tensioni – la cerimonia dell’accadere teatrale.
In conclusione, rimane il rammarico – almeno per chi scrive – di non aver mai potuto spiare una sessione di “prove” tra Bergman e i suoi attori: quel rito di famiglia (Il rito è anche il titolo di un film, anno ‘67), durante il quale si imbastiva meticolosamente, pazientemente – a volte tra insopportabili tensioni – la cerimonia dell’accadere teatrale.
Gli attori sapevano che mentre si allestiva una pièce, il loro maestro-regista accudiva in contemporanea, e silenziosamente, un copione cinematografico, che di conseguenza l’estate successiva ciascuno di loro sarebbe stato “arruolato” per mettersi davanti a una macchina da presa. Ma come aveva detto Bibi Andersson tanti anni addietro, “durante le nostre prove i visitatori non sono ammessi!”.
(Novembre 2013)
