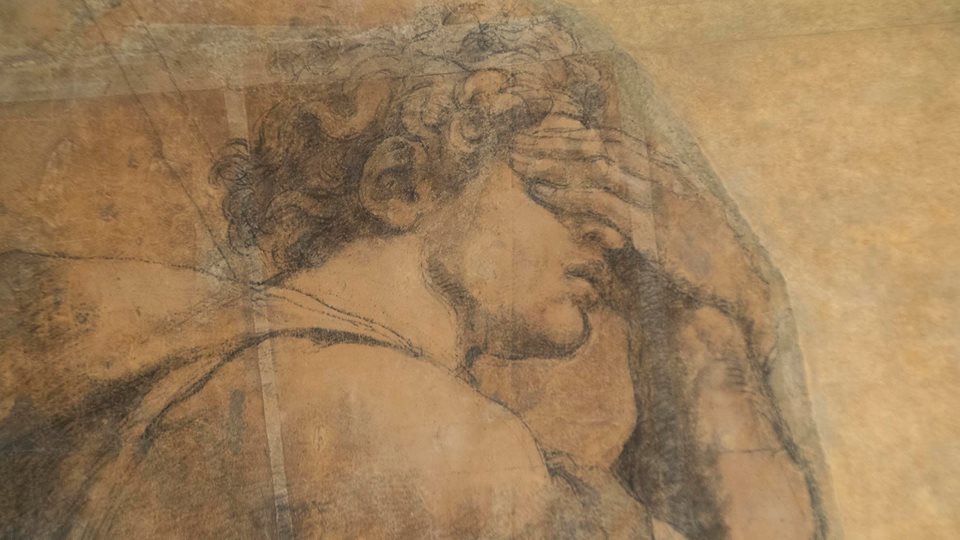
La Guerra è finita, il Tragico può avere inizio. È suonata la campana del Dopoguerra nella landa desolata di un minuscolo borgo dell’Appennino tosco-emiliano chiamato Montelice, dove le vite sono ridotte a parvenze, “gli uomini sono ai pascoli e non tornano prima di notte, le donne fanno legna qua e là, e nevica e piove, e la gente se ne sta giù nelle stalle, a guardare la pioggia e la neve, come i muli e le capre”.
Succede qualcosa a Montelice? Cosa fanno gli abitanti di Montelice? “Beh. Vivono… ecco. Vivono e basta, mi pare. E poi muoiono. Se vi affacciate un momento in strada, tutt’al più riuscirete a trovare una vecchia a soffiar sul fornello. Sempre che abbiate fortuna… O una capra. Magari anche solo una capra”. Chi si prende la briga di narrare, esaltando la concertazione ritmica di ogni frase, è un prete che i parrocchiani chiamano “reverendo” e che oggi ha poco meno di sessant’anni, corporatura alla Falstaff; tanti anni fa anche lui è stato tenutario di giovinezza, in Seminario aveva un nomignolo, “Doctor Hironicus”: da lì gli viene probabilmente il vezzo di sigillare i ragionamenti, seppur lambiccati, dentro alcune locuzioni: “e nient’altro”, “non vi pare?”, “voi cosa avreste fatto?”, “ma cos’altro potevo fare, mi dite?”. «Perché ormai io ero un prete da sagre: ero un prete da sagre e nient’altro: su questo non c’era più dubbio. Per un matrimonio alla buona e dottrina ai ragazzi e metter d’accordo anche sette caprai per un fazzoletto di pascolo non ero poi peggio di un altro: e così se un marito cominciava a usare un po’ troppo la cinghia. Ecco solo il mio pane oramai: altra roba non era per me».
Un prete da sagre… e da funerali: con i vecchi che muoiono a frotte, la Melide che li cuce dentro il lenzuolo, la cerimonia funebre da apparecchiare, c’è da chiamare le “donne che piangono”, e vogliono trecentocinquanta più mangiare e dormire una notte: «Sì, forse non ne vale la pena, gente non dovrebbe mancarne domani. Lavorava anche nei “maggi” o mi sbaglio? / Sì, Giacobbe. E una volta re Carlo di Francia».
In primavera ci sono i “maggi” da allestire, i sei più vecchi pastori del borgo salgono in canonica verso le otto, arrivano dalle torbe ai confini di Bobbio: «Son cinque anni, reverendo, che non facciamo più “maggi” quassù. / Si capisce… La guerra… Perché non provate I Reali di Francia. Anche questo è tutt’altro che male. / Sì. Ma per via delle sciabole? Ce ne vogliono cinque a dir poco anche lì. E poi costumi e corazze. E le donne? Ci sono tre donne in quel “maggio”, e due per di più molto giovani. Chi le trova le giovani, adesso?».
Non c’è più giovinezza a Montelice, non si allevano utopie, anche la pietas va sdilinguendo, la guerra è finita da poco, i corpi dei morti stanno ancora rantolando sottoterra, “dove quattro anni prima i tedeschi avevano bruciato anche i sassi”, e poco ci manca che non si trovi, superstite, “l’Aquilone sui resti”, di cui parlava Arthur Rimbaud in un componimento del 1872.

Difficile nella letteratura italiana del ‘900 rinvenire un percorso che abdicando da volontà e azione si consegna a una deriva di immobilità, conficcando i personaggi dentro una tenebra muta, quando peraltro ci sarebbe, a portata di sguardo e di sensazione, una realtà da rifondare, ci sarebbero parole che vorrebbero riprendere a funzionare, a fare corpo, a stupire, magari per svelare ex novo che cosa si cela, storicamente, dietro la presa d’atto di un Prete che quassù ha attraversato “più di trenta Natali, sapete?”, e che avvolge ogni fatto nella morsa del disincanto.
Eppure sono proprio le parole a costituire una potenza concentrica: se il tragico appare storicamente irredimibile, la parola si fa sempre incantamento, gioco di alchimie, ricamo musicale e sonoro, con l’esuberanza di un poema risolto in cinquanta pagine: «Fu una sera. Sul finire d’ottobre. Me ne venivo giù dalle torbe di monte. Né contento né triste: così. Senza nemmeno un pensiero. Era tardi, era freddo, ero ancora per strada: dovevo scendere a casa, ecco tutto. L’ombra proprio non era ancor scesa: campanacci di pecore e capre si sentivano a tratti qua e là un po’ prima della prata dei pascoli. Proprio l’ora, capite, che la tristezza di vivere sembra venir su assieme al buio e non sapete a chi darne la colpa: brutt’ora. Uno scoiattolo attraversò di corsa la strada, sgusciandomi quasi fra i piedi.
Solo allora, giù in fondo al canale che scorreva un venti metri di sotto, china a lavar biancheria o stracci vecchi o budella o qualcosa di simile, vidi una donna un po’ più vecchia di me. Sulla sessantina, sapete.
In mezzo a tutto quel silenzio e a quel freddo e a quel livido e a quell’immobilità un poco tragica, l’unica cosa viva era lei. Si chinava, e mi pare anche a fatica, affondava gli stracci nell’acqua, li torceva e sbatteva su un sasso; poi li affondava, torceva e sbatteva, e via ancora così. Né lentamente né in fretta, e senza mai alzare la testa.
Mi fermai sopra il ciglio a guardarla. Un sasso scivolò giù, fino in acqua, ma la vecchia nemmeno s’accorse. Solo una volta s’interruppe un momento. Si mise una mano sul fianco, diede un’occhiata alla sua carriola sull’argine e alla capra che frugava tra l’erba: e poi ancora riprese.
Beh, – dissi allora con me, – quando ci si mette sul serio, il mondo sa ben essere triste, però. Ha perfino l’intelligenza per questo: e neanche un uomo ci arriverebbe mai e mai».

Di “racconto perfetto” parlò Eugenio Montale quando Casa d’altri vide finalmente l’aurora editoriale – dicembre 1952 – per volontà di Attilio Bertolucci. Silvio D’Arzo era morto da pochi mesi, annientato da una forma di leucemia all’età di 32 anni.
Non è sfuggito, nelle ricostruzioni offerte da scrupolosi studiosi (da Anna Luce Lenzi a Rodolfo Macchioni Jodi, da Eraldo Affinati a Paolo Lagazzi, a Silvio Perrella), che D’Arzo si riprometteva di tornare sul manoscritto, probabilmente per perfezionare, con l’orecchio dello scrittore-musicista, quel sublime poetico che accarezza sommessamente ogni pagina e la cui prova del nove è presto detta: quando il vibrato tra intelletto e immaginazione è così “perfettamente” orchestrato che di ciò che avete sotto gli occhi non mutereste neppure una virgola.
L’apparizione di Zelinda, del personaggio Zelinda Icci lavandaia, fu un’inattesa sciabolata per la nostra esperienza di lettori, di cui ancora oggi avvertiamo in lontananza il clangore: il narrante Io, il Prete “da sagre e nient’altro” si imbatte nella “più assurda creatura del mondo”: «Padronissimi di riderci sopra, ma anche i sassi a quell’ora eran tristi, e l’erba, ormai di un color quasi viola, era ancora più triste. E lei sempre laggiù, china sopra i lastroni di pietra. Affondava nell’acqua gli stracci, li torceva, sbatteva e via ancora. E senza fretta o lentezza: così e senza mai alzare la testa.
Una cosa facile a dirsi, ma dovevate vederla.
No – dissi fissandola bene. – Non credo di conoscerla, quella: la vecchia non è certo di qui; senza dubbio è un uccello sbrancato. Sempre meglio, a ogni modo, che sia lei a venire da me. Prima o poi vengon tutte, da me. E che cosa potrei dirle, oltre tutto?»

Qui si apre la crepa – morale storica filosofica, la fenditura psico-esistenziale che muta radicalmente il fondale dove il racconto fino a quel momento si specchiava, e dove il lettore avrebbe potuto facilmente ritrovarne la scansione cronologica: il Prete-Io narrante, il protagonista tenutario della narrazione si accorge che ciò che va “componendo”, con la sua scrittura ironica e fintamente ingenua, non sta più in equilibrio, che niente è più distante e distanziato da quell’Io con cui amava esporre le proprie maniacali abitudini di parroco di montagna. Ed è proprio il movimento interno della scrittura, della parola scritta, a generare e svelare la presenza dell’Altro da sé: la Zelinda Icci che ora si afferma come depositaria di un segreto inconfessabile, di una parola che inorridisce:
«Tutte le mattine alzarsi alle cinque e andare giù in fondo alla valle per pigliare gli stracci e fermarsi a mezzogiorno un momento a mangiare olio e pane sopra l’erba di un fosso: e poi venire su fino a monte a pigliar la carriola e andarsene al canale a lavare. Fino alle sei, fino alle sette, e il lunedì fino alle nove di sera. E poi dopo caricare la carriola e tornare su a casa, appena in tempo per mangiare olio e pane e anche un po’ di radicchi, e poi andare a dormire (…) E il giorno dopo fare lo stesso, e anche l’altro giorno, e tutti i giorni del mondo. Perché io questo lo so: questo lo so, lo so bene: tutti i giorni del mondo. E su questo neanche voi potete dire di no (…) Io ho una capra che porto sempre con me: e la mia vita è quella che fa lei, tale e quale. Viene in fondo alla valle, torna su a mezzogiorno, si ferma davanti al fosso con me, e poi la porto al canale, e quando vado a dormire va a dormire anche lei. E anche nel mangiare non c’è gran differenza, perché lei mangia dell’erba, e io radicchi e insalata, e la differenza sta solo nel pane. E poi a momenti io non potrò mangiare più neanche quello… Come me… come me. Ecco che cosa faccio io: una vita da capra. Una vita da capra e nient’altro».
A dispetto di ogni pretenzioso rinascimento letterario di marca neorealista – D’Arzo inizia a scrivere il racconto nel ’46 – l’avvento di Zelinda rende manifesto il profondo reticolo delle cose non dette e non scritte, preordinando un assedio culturale estetico teologico di cui la letteratura italiana serberà duratura memoria. Da appassionato lettore-cultore dell’arte di Henry James, D’Arzo sa bene che nel vortice della parola scritta ciò di cui il lettore attende trepidante, da un momento all’altro, l’irruzione spropositata – fuori dei confini tracciati dall’immaginario – è La belva nella giungla , La figura nel tappeto , L’inquilino fantasma, per dirla con il titolo di tre racconti dello scrittore anglo-americano.
E Zelinda si appropria della narrazione del Prete, senza riguardi per l’Io di cui il Reverendo si crede amministratore unico – convinto che spetti a lui il privilegio di stabilire le regole del gioco – concedendo a quell’Io soltanto l’ingenuo presentimento di ciò che davvero sta per accadere: «Ma un prete di montagna lo sapete anche voi che cos’è: certi mesi dell’anno – per esempio, novembre – ci vogliono un maniscalco, un dottore di quelli appena sbarcati però, e poi un postino e un barbiere per mettere insieme sì e no il lavoro che lui fa da solo».
Il caso Zelinda non è però il lavoretto da sbrigare in mezzo ai pensieri gravi e taciturni che increspano il bilancio di un’esistenza fallimentare. Sradicandolo dall’ironico ruolo di curatore-tuttofare, di avveduto capo venerabile di una comunità di parrocchiani dentro una remota landa dell’Appennino, Zelinda pronuncia – e svela – la domanda fondamentale, restituendo il ministro delle anime al rigore della missione divina. Rammentandogli che la sua è storia di frustrazione e di alienazione, che gli anni del Dopoguerra stanno per consegnarsi alla ferocia di conflitti interminabili, che della cosiddetta pacificazione o normalizzazione non v’è traccia alcuna. Cosa fare? Si può ricomporre, riaffermare, il disperso mondo, quando l’alienazione è già così mostruosa? Può ancora albeggiare la gioia di vivere, la vita come affermazione di sé, se l’alienazione è pronta a ghermire le coscienze e a sgretolarle?

Sappiamo che il curato tiene pronte le valigie (“Allora mi vien sempre di più da pensare ch’è ormai ora di preparare le valigie per me e senza chiasso partir verso casa. Credo d’aver anche il biglietto) ma Zelinda potrebbe ora costituire finalmente un buon motivo per sovvertire la monotona dinastia dei “giorni senza nome”, già così chiamati da D’Arzo nel saggio su James. E Zelinda, la vecchia che torce gli stracci in fondo al canale, attende soltanto un cenno, è comparsa sulla scena per far sì che lui riesca a farle pronunciare la terribile “domanda”. Che inizialmente camuffa, convinto che lui non possa capire: “È vero o no che anche voi… sì, la Chiesa, ammette che due che si sono sposati possono anche dividersi, e uno è libero poi di sposare chi vuole?”, ottenendo che il sempre vispo Falstaff ricambi con una delle migliori battute: “Beh, mi pare che vi siate messa per strada un po’ tardi”… decidendo infine di enunciare per lettera la verità che non può esser detta, di tramutare in parola scritta ciò che l’arcaico pudore le vieta di esibire; tuttavia, una volta consegnata la lettera nelle mani della Perpetua, corre a riprenderla e la getta nello stagno. È il passo falso che il curato attendeva per incalzarla: “Zelinda, quella lettera è mia”, le grida il giorno dopo. “Sono venuto a pigliar la mia lettera. La mia lettera, mi spiego? Perché la lettera era già mia, se volete saperlo, né più né meno che i miei libri e il mio tavolo, e anche un avvocato di città od il pretore mi darebbero tutte le ragioni del mondo”.

“Va bene. E io ve lo dico anche. Ma allora voi vi voltate da un’altra parte e non mi state a guardare più in faccia”.
Il prete esegue (“Ed io feci anche questo. v’assicuro che mi voltai verso il muro, come quando qualcuno si sveste“) ma non ha idea di quale possa essere la richiesta della vecchia lavandaia. Che cosa la vecchia ha terrore di confessare? Perché tanta reticenza, tanto timore… e questi insistiti richiami alla Regola, a quale scopo?
«Voi non potete capire. Io sono stata tra le Serve di Maria, sono andata fino a Loreto in pellegrinaggio, e tutto a piedi fin là: ho fatto quel che Dio dice di fare, e nessuno può dir niente di me. Di grosso non ho mai fatto niente. E io pensavo che adesso un piacere Dio potrebbe anche farmelo, perché io non gli ho mai chiesto niente. Non l’ho mai disturbato tanto così in sessantatré anni a momenti. E non l’ho mai avuto con lui; mai una volta. Un piacere potrebbe anche farmelo, ecco. Per questo io sono venuta da voi quella sera a domandarvi se anche voi, dalla Chiesa, qualche volta non si bada alla regola: e la storia del matrimonio era solo un’astuzia. E per tutta la notte mi ci son vergognata».
Zelinda è convinta che il suo sia una caso “specialissimo”, dinanzi al quale la Legge Divina potrebbe anche non valere, quindi “sospendersi”. Importante è che Dio si faccia da parte, volga lo sguardo altrove, si dichiari assente o comunque si copra gli occhi con la mano. Ed essendo il Prete l’intercessore titolato della Regola, a lui spetterebbe dare il consenso, l’approvazione… “Perché io, senza fare dispetto a nessuno…”. Il Prete ascolta, con la faccia rivolta al muro ma non sa cosa fare né cosa pensare. A cosa servirebbe la deroga, la sospensione della Regola? E quale sarebbe poi questo caso “specialissimo”?
Forse il lettore compassionevole, giunto a questa linea del racconto, percepisce che Zelinda, “senza fare dispetto a nessuno“, sta inoltrandosi nel sentiero delle Domande senza risposta, ossia le domande teologiche – al limitare estremo tra fede possibile e fede impossibile – che proprio il Secondo Dopoguerra poneva all’umanità superstite della Dittatura nazi-fascista e dei Campi di sterminio.
Ma andiamo a vedere, senza indugiare oltre, come evolve la dialettica Prete-Zelinda, dove cerca e trova il punto di risoluzione. Riprende Zelinda:
– Nella lettera c’era scritto che io capivo benissimo quello che dite voi preti, perché guai se non fosse così e il mondo chissà dove andrebbe. Questo io lo capivo da me. Ma siccome il mio era un caso speciale… No, no. Non state a voltare la faccia. Me l’avete promesso… Siccome il mio era proprio un caso speciale, tutto diverso dagli altri, e so che sarà sempre così, e ogni giorno che passa anche peggio (perché questo lo so, questo io proprio lo so, la sola cosa che io so proprio bene…) Non voltate la faccia. Guardate sempre di là per piacere… Allora, senza fare dispetto a nessuno, io chiedevo… No, ma io me l’immagino già quel che voi rispondete.
– Senza fare dispetto a nessuno…
– Ecco, nella lettera c’era scritto se in qualche caso speciale, tutto diverso dagli altri, senza fare dispetto a nessuno, qualcuno potesse avere il permesso di finire un po’ prima.
Mi voltai senza aver capito.
– Anche uccidersi… sì – spiegò lei con una tranquillità da bambina. E si mise a guardarsi gli zoccoli.
Ecco l’arcano mistero venire alla luce: la vecchia vuole suicidarsi, con inusitato ardore vuole spegnere definitivamente le poche tracce di vitalità che ancora le permettono di fare presenza nel mondo. Con linguaggio figurato e con una formula efficacissima, utilizzata nel ’56 da Guido Morselli nel libro Fede e critica, si potrebbe dire che è l’intera teologia ad essere messa “con le spalle al muro” da quella confessione-implorazione. Che cosa farà ora, che cosa dirà il Prete, il Prete Io-narrante, testimone unico della rivelazione della vecchia?
Tutto questo mi prese così all’improvviso che sul momento non mi venne parola. Nessuna. Ma poi no, non fu neanche così: alla bocca mi salirono parole e parole e raccomandazioni e consigli e “per carità” e “cosa dite” e prediche e pagine intere e tutto quel che volete. Tutte cose d’altri, però: cose antiche: e per di più dette mille e una volta. Di mio non una mezza parola: e lì invece ci voleva qualcosa di nuovo e di mio, e tutto il resto era meno che niente.
– Ecco, disse lei dopo un po’, – Lo sapevo che avreste fatto così.
E la cosa più brutta era che lei stette ancora in attesa di qualcosa come un minuto e anche più. Stava lì e continuava a sperare.
– Lo sapevo che avreste fatto così, ripeté con voce appena diversa. – Io l’ho sempre saputo. Fin dal primo momento l’ho detto.
– Zelinda… – cominciai io, ma così goffamente da provare vergogna di tutte le parole del mondo.
– Perché allora l’avete voluto sapere? – disse lei con un po’ di rimprovero. – Voi l’avete voluto sapere, e adesso, ecco, ve ne state così.
E si mosse e sparì dentro casa. E io rimasi lì, sulla strada di monte.
Vengono delle idee, certe volte.

Pensieri smozzicati, parole incompiute. Al “prete da sagre e nient’altro”, all’ironico memorialista di questa “storia assurda”, non rimane che cercare consolazione nel lirismo crepuscolare della scrittura, assolversi delle probabili manchevolezze, respingere sullo sfondo il richiamo all’ordine di cui Zelinda si è resa protagonista: «Mi guardai un po’ d’intorno. Stava per venire la morta stagione, gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila e la Melide li cuce dentro il lenzuolo e io li porto al cimitero di monte, e i bambini che per l’intera stagione se ne stanno dentro le stalle a scaldarsi col fiato dei muli… Un inverno di cinque o sei mesi. E lei cosa avrebbe fatto, la vecchia?
Nelle ossa sentivo l’inverno vicino. Guardai un momento le nuvole che adesso eran più grandi di un prato, e poi mi avviai alla parrocchia. Le nuvole mi venivano dietro. Sempre dietro, come se qualcosa sapessero. Vengono delle idee, certe volte.
Ma che altro potevo fare, mi dite?» .
Giunti alla fine della storia, alle ultime pagine del racconto, con la Zelinda che esce di scena, scompare, si dilegua, lasciandoci nel dubbio – si sarà suicidata? – le domande “originarie” si moltiplicano, i sentieri di lettura si biforcano, si fanno trasversali – l’uno a tangenza dell’altro – e un realismo critico di buone maniere consiglierebbe a questo punto di percorrerli, assegnando ai personaggi-duellanti due differenti statuti letterari e filosofici: a Zelinda la Fede in Cristo Redentore, al Prete la Chiesa e gli affari terreni. Il Prete diventa lo stanco, sfiduciato “amministratore” delle anime vagolanti tra terra e cielo, che adempie gli affari correnti giorno dopo giorno, mentre la vecchia lavandaia raccoglie e rilancia l’antica investitura dell’homo religiosus, legato a Dio “faccia a faccia”.
Di certo non sfugge, al lettore avveduto, il diverso grado di contiguità con Dio, che connota i due personaggi: il Prete-Io narrante evita di nominarlo, di pronunciarne il Nome, limitandosi a pretendere l’obbedienza della Regola; Zelinda, al contrario, ha lo sguardo rivolto unicamente verso l’abisso, trattenendo il grido disperato del cristiano che si trova a supplicare il Dio assente, il Dio nascosto, il Dio… inutile .
Ecco allora profilarsi il reticolo di correspondances, di richiami con la grande tradizione della Theologia Crucis o Teologia della crisi, alla cui sommità stanno i nomi di Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, Sergio Quinzio .
In una delle lettere dal carcere di Tegel, dove era detenuto per mano nazista dal 5 aprile ’43 e dove troverà la morte per impiccagione il 9 aprile ’45, il teologo Dietrich Bonhoeffer scrive: «Ciò che mi preoccupa continuamente è la questione di che cosa sia veramente per noi, oggi, il cristianesimo, o anche chi sia Cristo. È passato il tempo in cui questo lo si poteva dire agli uomini tramite le parole – siano esse parole teologiche oppure pie -; così come è passato il tempo della interiorità e della coscienza, cioè appunto il tempo della religione in generale. Stiamo andando incontro ad un tempo completamente non-religioso; gli uomini, così come ormai sono, semplicemente non possono più essere religiosi».
Riaprendo così il dibattito su che cosa può dirsi Religione in tempo di guerra, nel tempo della crisi: tema su cui non mi avventurerò al momento ma di cui il Blog si occuperà nel futuro prossimo, trattando alcuni aspetti della Theologia Crucis in relazione a due ragguardevoli interpreti: Karl Barth e Sergio Quinzio. E che, tornando al racconto, evidenzia con maggiore nitidezza come questo miracolo di architettura letteraria lasci il lettore con una scia di compiti da assolvere.
Due ultime note, in chiusura. La prima riguarda le Trasposizioni, i tentativi di volgere verso il teatro o verso il cinema la fabula del Prete e di Zelinda, la “storia bellissima ma anche facilmente sprecabile”, come faceva notare il critico Mario Lavagetto. In teatro è da ricordare soprattutto il progetto del compianto regista Giuseppe Bertolucci e dell’attore Antonio Piovanelli: una “rivisitazione” datata 2011, prodotta nell’ambito del Reggio Parma Festival ma riproposta di recente dal Teatro India-Teatro di Roma. Per il cinema, come forse pochi rammentano, Casa d’altri fu pretesto di un breve film in bianco e nero nel lontano ’54, intitolato Questa è la vita, diretto da Alessandro Blasetti, che si avvale dell’interpretazione di Michel Simon nel ruolo del Prete (ruolo nel quale oggi vedrei volentieri Gérard Depardieu ).
L’ultimissima nota riguarda il Lettore-Critico-Scrittore che avrei desiderato capostipite dell’avventura letteraria artistica umana di Silvio D’Arzo, colui che avrebbe potuto esserne lo scopritore per eccellenza, ovvero Giacomo Debenedetti. Che non fece mai alcun cenno a questo racconto: chissà – mi domando – da dove prenderebbero avvio le nostre analisi, oggi, se Debenedetti avesse accordato il suo canto.
(Agosto 2017)

2 Commenti. Nuovo commento
E’ emozionante ciò che non avviene né in terra né in cielo, né nel borgo di Montelice dove Zelinda, la lavandaia, fa la vita che fa la sua capra, né nel cielo, dove dio non c’é. E il prete, io narrante, calato anche lui nel vuoto, scorge Zelinda sotto a lavare i panni nel fiume e ascolta , rivolto contro il muro, la sua rivelazione.
La descrizione del nulla può diventare autentica poesia se uno scrittore è un grande scrittore, e certo Silvio d’Arzo lo è.
‘Tutte cose d’altri, però: cose antiche: e per di più dette mille e una volta. Di mio non una mezza parola: e lì invece ci voleva qualcosa di nuovo e di mio, e tutto il resto era meno che niente.’
Mi domando se D’Arzo non abbia intitolato il suo racconto. ‘Cose d’altri’ e che alla pubblicazione postuma il titolo non sia stato per errore travisato e cambiato in: ‘Casa d’altri’; titolo che in definitiva ha poco senso.