 Chi ha vissuto la pienezza degli Anni Settanta ricorda che ad ogni crocevia delle grandi città d’Europa era apparecchiato un tavolo di ricerca e di discussione. Ciò che oggi viene definito “sperimentalismo” era il nutrimento quotidiano di una generazione di autori e registi che non si stancava mai di interrogarsi sul perché del gesto d’arte.
Chi ha vissuto la pienezza degli Anni Settanta ricorda che ad ogni crocevia delle grandi città d’Europa era apparecchiato un tavolo di ricerca e di discussione. Ciò che oggi viene definito “sperimentalismo” era il nutrimento quotidiano di una generazione di autori e registi che non si stancava mai di interrogarsi sul perché del gesto d’arte.
La prima parola che affiorava sulle labbra era Impegno, la seconda Creatività: due parole che come altre caddero in disuso per l’abuso negativo che ne seguì: indicavano tuttavia la felice appartenenza ad una zona di confine dove l’ardore di conoscenza si gemellava con la convinzione che la tradizione non potesse essere ripetuta, che occorresse plasmare il nuovo su qualsiasi materia venisse a contatto con la realtà socialmente e politicamente in perenne trasformazione.
L’incontro tra Nicolas Klotz e Elisabeth Perceval avvenne in un teatro parigino chiamato “Oblique”. Operavano in due sale differenti, poste su due piani, una sopra l’altra, entrambi impegnati a portare sulla scena gli amori teatrali della propria giovinezza: il primo si cimentava con Wedekind, Danza macabra; la seconda con Il Pellicano di Strindberg.
Dopo il primo giorno di prove, Elisabeth irruppe sul proscenio di Nicolas per protestare: dove provava lei arrivavano le voci degli attori di Nicolas, si udivano rumori di scena che impedivano la concentrazione, i due spettacoli si sovrapponevano, generando disordine e confusione.
Interrogata pochi anni fa (2007) dallo storico e critico Antoine De Baecque in merito a quella lontanissima stagione di prove, Elisabeth dichiarò:
«Se ci penso oggi, quei rumori fuori campo, che arrivavano dalle prove di Nicolas e che invadevano il mio proscenio, costituivano un’esperienza da non interrompere. Erano il rumore di un mondo fuori dal nostro palcoscenico, un lontano “mormorio” che vagava intorno al nostro spettacolo. Ho vissuto anni dopo un’esperienza analoga, durante la pièce “Cantates”, che mettevamo in scena dentro un parcheggio sotterraneo di Marsiglia. Il rumore della città, le sirene dei battelli che lasciavano il porto, si mischiavano al testo degli attori, si intrufolavano tra le musiche e i suoni: scoprivamo così una materia sonora inconsueta e straordinaria».
 Dopo quel primo incontro, Nicolas e Elisabeth non si separeranno più: il loro connubio professionale – insieme alla complicità sentimentale – diverrà la rigorosa imbastitura di un percorso teatrale e cinematografico che merita di essere conosciuto e condiviso.
Dopo quel primo incontro, Nicolas e Elisabeth non si separeranno più: il loro connubio professionale – insieme alla complicità sentimentale – diverrà la rigorosa imbastitura di un percorso teatrale e cinematografico che merita di essere conosciuto e condiviso.
Soprattutto per un motivo che costituisce la ragione primaria di queste riflessioni: gli anni di formazione e di apprendistato della coppia Klotz/Perceval costituiscono un modello di riferimento per chiunque si trovi oggi ad affrontare i dilemmi contenuti nella più elementare e necessaria delle domande: “Perché fare cinema, perché fare teatro?”.
A buon diritto il loro itinerario potrebbe ritenersi il ritratto di una generazione nella quale ritrovarsi, ritrovare noi stessi, condividerne la forza e la perseveranza, per mostrare e dimostrare con maggiore convinzione che ci sono epoche in cui la coscienza individuale si tramuta in coscienza collettiva, immettendosi nella storia da posizioni inedite e forse risolutive.
Affido alla curiosità dei lettori del Blog il desiderio di scoprire o approfondire la costellazione delle loro opere. Si tratta di un itinerario ricco e variamente diversificato: teatro, cinema, documentari, video, internet. Per il quale vige la legge del comune sentire e della comune militanza: i due nomi sono sempre appaiati, uno di seguito all’altro, per far bene risaltare che il percorso non è mai singolo, isolato, ma condiviso e interamente partecipato.
L’intreccio dei motivi comprende teatro, cinema, filosofia, storia, letteratura e musica. Innervati su temi che si inscrivono in una drammaturgia del presente e nel rapporto che questa ha con la memoria. Se il film La blessure (2004) rivela una Francia che ripudia lo straniero-immigrato, la Question humaine (2007) propone un’amara riflessione sul capitalismo “snaturato” dei nostri anni, intrecciando tragedia della Shoah e spirito contemporaneo.
A questi due titoli si aggiunge Paria, girato nel 2000, che inaugura la Trilogia dei Tempi Moderni, così chiamata in diretto riferimento all’ispirazione di Chaplin-Charlot.
Il film più recente, Low Life (2012), indaga la complicità e l’ambiguità della giovinezza dentro un mondo che pare annunciare continuamente la propria catastrofe, un cinema che cerca visioni estreme per opporsi all’omologazione delle immagini e dell’immaginario.
Come detto, lo scopo di queste annotazioni non è l’analisi critica delle opere ma la necessità di identificare nelle scelte e nel percorso compiuto da Nicolas Klotz ed Elisabeth Perceval una prassi di riferimento generazionale, ritrovando un cammino oggi interrotto e rischiarandolo di inedita complessità.
 Faust Salpétrière
Faust Salpétrière
Torniamo agli anni dell’apprendistato, gli anni delle scoperte, così come germogliano nella conversazione con Antoine De Baecque.
Nicolas Klotz: «Elisabeth era la diva, recitava nuda tutte le sere. La prima volta che la vidi era nuda sul palcoscenico di “Danza macabra”. Io ero arrivato al teatro quasi per caso. Al liceo passavo la maggior parte del tempo nella Cinémathèque di Chaillot e nel cineclub “Les Acacias”.
La mia prof di francese, con la quale discutevo animatamente, si era messa in testa di portarmi a teatro, voleva a tutti i costi occuparsi della mia “educazione teatrale”. Ma, come molti cinéphiles, nutrivo un malcelato disprezzo verso il teatro: non sopportavo la lunghezza delle pièces, la recitazione in eccesso e piena di ridondanze degli attori, la moda del “questa sera si va a teatro”.
Una sera la prof di francese mi porta a vedere “La dispute” di Marivaux allestita da Patrice Chéreau. Vidi qualcosa di estremamente fisico, fui affascinato dalla concretezza della rappresentazione: la presenza fisica degli attori, la luce che li avvolgeva e li inglobava, la profondità delle voci.
La prof conosceva Bernard Pautrat, un filosofo di 30 anni che lavorava come drammaturgo per Klaus Michael Grüber. Grazie a Pautrat, entrai nella Compagnia del Faust Salpétrière. Potevo assistere alle prove, alle discussioni nei caffè, alle invenzioni sceniche, alla maniera particolare con cui lo stesso Grüber disponeva le luci. Era la prima volta che vedevo un regista di teatro al lavoro.
Klaus faceva lavorare gli attori nella Cappella della Salpétrière: un luogo vetusto, frequentato dagli spettri di Charcot, di Freud e delle tante donne isteriche che da lì erano passate. Il modo di impadronirsi e di trattare sulla scena il testo di Goethe – in questo luogo fatiscente, stranamente quieto, con la complicità dei suoi amici Bernard Pautrat, i pittori Arroyo e Gilles Aillaud – mi appariva stupefacente.
C’era intorno a Grüber una comunità che lavorava con smisurata ambizione, tentando al contempo di rimanere minimalista nella forma. Un minimalismo per la verità aggressivo e depredante, ispirato da Buster Keaton e da Beckett oltre che dal lirismo epico di Sofocle, Hölderlin e Brecht.
Questa sovrapposizione del contemporaneo e del tragico – che per me all’epoca rappresentava un’enorme scoperta – mi riportava al cinema che amavo, a Tarkovskij per esempio.
Di quei giorni ricordo con precisione Klaus che ordina agli attori di camminare ore e ore senza fermarsi. Allo scopo di raggiungere uno scopo preciso: disfarsi del bisogno di recitare. Klaus gridava in continuazione: concretezza, concretezza! Ciò che rendeva gli attori rabbiosi e insofferenti. Dopo una settimana di prove senza sosta, si sono ammutinati. Klaus li ha apostrofati con rabbia, dicendo che gli attori francesi passano troppo tempo a lamentarsi e a voler “fare la rivoluzione”. Poi è uscito dal teatro, si è rintanato in un caffè, in attesa che gli attori decidessero se continuare le prove o rinunciare allo spettacolo. Quando è tornato, ha trovato gli attori pronti a ricominciare.
Guardandolo lavorare, avevo spesso l’impressione di assistere a un evento di cinema: era invece teatro! È grazie a Klaus che ho appreso l’importanza del tempo della scena e dell’incedere dei corpi nello spazio: due elementi che disegnavano una scena teatrale diversa da quella che eravamo abituati a conoscere.
Faust Salpétrière durava sei ore. Durante le quali eravamo messi di fronte alla nostra mortalità, al nostro scoprirci provvisori, fragili. Potrei parlare ore e ore di Klaus, autore di cui non mi sono mai privato, che ci ha accompagnato anche durante la preparazione del film La Question humaine. Il personaggio di Arie Neumann, interpretato da Lou Castel, è vicino all’umanità di Klaus».
 Il flusso tele-visivo
Il flusso tele-visivo
Più volte, insistentemente ritorna, nelle parole di Nicolas, la questione corpo dell’attore. È un corpo che non affronta la scena teatrale come da precedente codice, con le figure stagliate nel campo medio-lungo. È un corpo che si è fatto “prossimo” alla parola e all’evento testuale, proprio perché riconosce l’appartenenza alla storia del presente: il tempo dell’Adesso, che lo accende e lo muove nell’istante in cui accade, nell’attimo in cui si offre allo sguardo dell’Altro.
Si sta forgiando una generazione che ha voglia di irrompere sulla scena come soggetto storico, proiettando nello spazio teatrale memoria e discorso dell’attualità, radicalizzando la prospettiva storico-politica, non potendo disconoscere insomma la centralità del dibattito ideologico e culturale che si accende poco lontano dello spazio-scena.
La parola a Elisabeth Perceval:
«Io e Nicolas ci siamo incrociati la prima volta all’indomani della morte di Pasolini, 2 novembre 1975. Eravamo tutti sconvolti da quella notizia terribile: Pier Paolo Pasolini era morto assassinato. Si percepiva immediatamente che qualcosa di importante finiva quel giorno, forse proprio per l’inaspettata violenza di quella morte. Pasolini rappresentava un mondo, con la sua morte una cultura intera sarebbe scomparsa.
Nelle “Lettere Luterane”, parlava della sparizione di un modo di vivere, di una lingua, dei valori della cultura popolare. Parlando dei personaggi di Accattone, diceva: “C’è stato un genocidio, si è distrutto culturalmente un popolo, annientati per sempre questi personaggi dalla superficie della terra”.
L’attualità del cinema, il fare cinema, faceva in quegli anni parte del mondo del teatro. Teatro e cinema stavano accanto, viaggiavano insieme, erano parte preminente di ciò che si poteva leggere, vedere, ascoltare. Non soltanto i registi di cui si parlava all’epoca – Vitez, Chéreau, Lavaudant, Boeglin, Vincent – erano affascinati dal cinema, ma ancor di più esistevano forti legami, forti connessioni, tra cinema e teatro, che passavano dai lavori di Pasolini, di Fassbinder, e di cui ciascuno di noi si nutriva.
Quando io e Nicolas ci siamo incontrati, si andava molto al cinema, forse più che a teatro, sebbene fossimo tutti i giorni impegnati su un palcoscenico. All’inizio degli anni ’80 avevamo due fari critici: Serge Daney per il cinema e Jean-Pierre Thibaudat per il teatro. Erano i “passeurs”, le guide che ci facevano passare da una frontiera all’altra, oltre che gli avvistatori delle novità culturali. Ci tenevano svegli, ci insegnavano come decrittare fenomeni disparati: un avvenimento di cronaca, un fatto politico, un film o una regia teatrale.
Serge Daney fu il primo a notare la lenta degradazione delle immagini a vantaggio del “visivo” tout court: il flusso tele-visivo che comportava mediocrità, squallore, disimpegno. E il teatro era il luogo deputato dove i testi incrociavano le roventi questioni politiche, le scelte estetiche: interrogare cioè le “scritture”, i linguaggi, ciò che poteva resistere all’assalto del tele-visivo».
 Koltès, Gabily e il gruppo T’chan’G
Koltès, Gabily e il gruppo T’chan’G
Ecco che si va annunciando quella prospettiva multipla, potente e discorde rispetto agli anni precedenti. Cinema e teatro intersecano le strategie di visione, sicché il teatro anni ’80 e anni ’90 conferirà una sorta di statuto non scritto agli accostamenti programmatici: la scena sarà ripensata da registi-autori come Antoine Vitez, Luc Bondy, Robert Wilson, Patrice Chéreau.
Non sarà più discriminante rivendicare una specifica appartenenza: ci si trova nel deserto delle immagini, sul proscenio di un teatro come di un set cinematografico, urgentemente spronati a coniugare e imporre la forma del presente.
Se c’è una preoccupazione, è riuscire a spostare più avanti la qualità e la prospettiva del dibattito, interrogare la forza teorica che questi due potenti mezzi di espressione raggiungono se “coniugati” all’unisono, se si predispone una forza teorica in grado di declinarli insieme.
Riprendiamo il racconto di Nicolas Klotz:
«Qualcosa di importante, in tal senso, è accaduto con l’esperienza scenica di autori come Bernard-Marie Koltès, Didier-Georges Gabily e Francois Tanguy.
La possibilità di far interagire cinema e teatro durante gli anni ’70 si è ritrovata in questi autori negli anni ’90 oppure è ritornata grazie a loro. Koltès era affascinato dal cinema, il cinema di serie B, i film della serie Kung-fu, che considerava materiali mitologici. Nella sua personalità, come nella sua scrittura, c’era una “tendenza Elia Kazan”: si ritrova James Dean nel personaggio di Charles in Quai Ouest e in Roberto Zucco.
Avevo incrociato Koltès a Lione nel periodo in cui scriveva Salinger per Bruno Boeglin. Cominciava appena a essere rappresentato. Discutevamo ore nei caffè. Ricordo l’estrema dolcezza che emanava da lui, la differenza, lo scarto, tra la violenza della sua drammaturgia e la dolcezza dell’uomo. Quando ho allestito Roberto Zucco, proprio quella dolcezza mi ha ispirato.
Il caso Gabily è diverso. Didier-Georges Gabily era stato impressionato da Godard, ha girato due cortometraggi a lui dedicati. Ha scritto anche un testo, “TDM3-Théatre du Mépris 3”, ispirato al film “Il disprezzo”di Godard. Anche per Francois Tanguy si passa attraverso il cinema di Godard ma anche attraverso Chaplin, Pasolini, Straub e Huillet, oltre che dagli scritti di Deleuze sul cinema.
Autori che inventavano tutto, in grado di creare luoghi e spazi inconsueti, secondo logiche artigianali, ma ogni cosa – testo, scrittura, palcoscenico – passava per una presenza costante del cinema, che significava proiettarsi in permanenza verso altre visioni, che riguardavano sia la parola scenica che la regia.
Il cinema era una presenza costante, irrinunciabile, ma lo era nella direzione del montaggio più che in quella delle luci o della definizione dell’immagine. Del resto, non c’è niente di più deprimente che immaginare il teatro come un tentativo di fare cinema».
Elisabeth Perceval: «Non era infatti la volontà di produrre immagini che aveva il sopravvento, quanto la necessità di fare interagire tre elementi propri alla macchina teatrale: il testo, il corpo dell’attore e la durata. Nel gruppo creato da Gabily e chiamato T’chan’G, c’era tanta voglia di cinema, tanta energia, tanta curiosità, eppure ciò che passava da un palcoscenico all’altro era la scrittura: se e come la scrittura può ancora testimoniare della realtà del mondo. La scrittura come mezzo per dire ciò che non è ancora definibile, che non si può spiegare. Scoprire, una lingua che faccia questo senza rinunciare al tragico: penso a Koltès, ai personaggi di Quai Ouest, ai monologhi di Charles e Fak, quindi alla risonanza di quelle parole con Accattone di Pasolini».
 «Il cinema oggi? Un mestiere da cineoperatori»
«Il cinema oggi? Un mestiere da cineoperatori»
Ecco delinearsi l’originalità del percorso: se Nicolas afferma: Non c’è niente di più deprimente che immaginare il teatro come un tentativo di fare cinema, Elisabeth fa eco ribadendo che il teatro non deve competere con il cinema a livello delle immagini, non deve votarsi alla produzione di immagini. La sfida si gioca ancora sulla parola da trovare, la “lingua” come espressione peculiare della scena.
Argomentazioni che paiono contraddire la vocazione dei palcoscenici affollati di schermi, dove si persegue la proiezione in simultanea, nello sforzo di simulare lo spezzettamento della visione-mondo. Il teatro “scaturisce” da sé, le visioni che produce sono a esso peculiari, come ci insegna Koltès: cercare cinema nel teatro sarebbe ridicola imitazione. È ancora una volta la trama del discorso che si impone, un discorso che deve poi trovare la forma per farsi scena. A quali condizioni?
Nicolas Klotz:
«Negli anni ’80, il cinema è diventato un prodotto da cineoperatori, una pratica individualista, il destino peggiore che potesse capitare. Un cinema che si è ammalato di infezione visiva e il teatro poco dopo ha seguito. Quando la luce, la scenografia, il denaro prendono tutta questa importanza, i registi hanno bisogno di budgets sempre più elevati, oltre che di un consenso mediatico che divora le energie, la rincorsa verso l’audience. I salari così esplodono, insieme alle carriere. Difficile, poi, fare marcia indietro.
Oggi la vita è diventata molto difficile per le compagnie di teatro. La precarietà ha invaso ogni cosa. Gli autori contemporanei, le compagnie, i cineasti, gli attori, i critici, gli spettatori: tutti si ritrovano isolati. Non c’è più storia in comune da parte dei registi e una sana ambizione da parte della critica, che si fa invece sempre più consensuale. Non esistono più luoghi dove si mettono in comune idee, progetti, finalità estetiche.
Il liberalismo distrugge la cultura, stabilisce valori “perimetrali” dentro modelli ripetitivi, quindi divide, separa, elimina i “margini”. Ciascuno sceglie di operare nella propria nicchia, per non deprimersi eccessivamente. Ancora oggi sogneremmo un movimento che nasca dal cinema o dal teatro e che possa iniettare una dose di vitalità collettiva. Ci vorrebbe un po’ di “rivolta”: si dice così? Ogni film e ogni spettacolo potrebbero essere una piccola rivoluzione. Dobbiamo restare svegli, vigilare, lavorare per il domani».
Elisabeth Perceval:
«Il set e il palcoscenico sono luoghi di verità. Nella fase delle riprese, noi vogliamo che le cose si costruiscano con dolcezza, senza che ci si renda conto. È ciò che chiediamo ai tecnici e agli attori. Durante la costruzione di una scena, si prova, si parla, si interviene, ci si interrompe, a volte si scherza, si chiacchiera, mentre Nicolas va e viene tra il controllo camera e gli attori.
Il momento della ripresa – “Motore!” – non cade come una ghigliottina, non separa il tempo della preparazione dal tempo dell’azione. L’attore Mathieu Amalric, quando ha lavorato con noi per La questione humaine, diceva di non aver coscienza di quando avvenisse la ripresa vera e propria.
Ciò che conta è il lavoro dell’attore, insieme all’attore, come a teatro. Tutto accade prima. Sopra un proscenio di teatro come sul set di cinema, la parola attraversa il corpo dell’attore e diventa l’azione stessa. Ciò che dice il personaggio, nell’istante in cui lo dice, è azione.
Noi partiamo dal presupposto che il mondo sia prima di tutto una enorme macchina che produce solitudine e che la finzione – cinema, teatro – introduca gli individui in una comunità, in qualcosa di pregnante che è il tempo di una ripresa, di un film, il tempo di una rappresentazione teatrale».
 Nicolas Klotz:
Nicolas Klotz:
«Io mi sento a disagio quando gli attori tendono a imitare un gergo spontaneo, la cosiddetta parlata naturale. Il “naturale” oggi è dappertutto: in televisione, nei telefilm, nelle serie televisive, nei talk-show, su Internet, sul proprio telefono cellulare.
Al cinema come a teatro noi cerchiamo l’assenza degli attori, ciò che rimane quando si elimina il bisogno di creare significati, di dire qualcosa a tutti i costi. A questo serve il palcoscenico, le prove: levare, disfare, finché non appaia quella presenza che la caméra può filmare o la scena del teatro rivelare.
Ci interessa lavorare sul corpo degli attori come presenza documentaria e sulla parola come elemento di finzione. La presenza e la parola hanno infranto la quarta parete del vecchio teatro, dove gli attori parlavano tra loro fingendo di non sapere che un pubblico di spettatori li stava osservando. La tragedia greca, come il cinema muto, non hanno mai tentato di dissimulare la realtà di questa relazione frontale tra presenza, parola e pubblico. È la grande forza di Brecht, come di Ford, di Lang, di Ozu, di Bresson, di Godard.
Quando preparavo “L’intruso”, dicevo agli attori che l’importante era prendersi la parola, ma non nel momento prescritto, quando arrivava il proprio turno, ma quando si creava la necessità di parlare. Identica cosa valeva per i movimenti sulla scena. Uno spostamento, il cambiamento di una posizione nello spazio della scena per occuparne un’altra prende senso per l’attore se diventa vitale. Spesso, in teatro, i movimenti sulla scena sono fatti per dare l’impressione che qualcosa stia accadendo, per evitare che gli spettatori precipitino nella noia. La noia, così frequente al teatro, è una prova importante sia per il regista che per gli attori e gli spettatori.
Come guardare il “Faust Salpétrière” di Grüber, “Les Cheyennes” di Ford o “Ces rencontres avec eux” di Straub, se la paura di annoiarsi paralizza la sensibilità? La noia è una prova indispensabile che dobbiamo attraversare per ampliare l’orizzonte creativo, per andare oltre, conquistare una posizione maggiore. Chaplin non aveva timore di girare una scena cento volte, finché non avesse raggiunto ciò che cercava».
Elisabeth Perceval:
«Il set di un film, quando è vuoto, prima che la troupe arrivi, prima dell’arrivo degli attori, somiglia a uno spazio che attende. Un luogo che non esiste fin quando non è abitato, fin tanto che non accada la recitazione. Al contrario, il palcoscenico di un teatro è sempre gremito di presenza, di prove, è uno spazio vivo anche se è vuoto, esiste autonomamente come spazio. È sufficiente che entri un personaggio, che attraversi la scena, ed ecco che si accende un ritmo, ecco che qualcosa si compie.
Quando giriamo un film, sono sempre parecchio nervosa, impaziente, soprattutto nei lunghi intervalli, mentre si posizionano le luci. È una fase che condivido poco, è il periodo in cui Nicolas decide la posizione della macchina da presa. Noi lavoriamo insieme, a stretto contatto, durante la preparazione delle inquadrature e delle scene con gli attori. Ma lo facciamo con discrezione. Anche se abbiamo discusso poco una determinata scena, Nicolas è molto intuitivo, aperto a ciò che il luogo in quel momento gli suggerisce. Ci parliamo a bassa voce, nell’orecchio, spesso discutiamo in tre, insieme all’attore.
Poi, appena Nicolas si installa alla caméra e sparisce sotto il manto nero, io preferisco uscire dal set, raramente rimango a guardare la ripresa. Preferisco ascoltare il testo e le voci degli attori in cuffia. Conclusa la ripresa, scambiamo le impressioni, a volte non siamo d’accordo su quale sia la scena meglio riuscita. Io spesso propongo di discutere minuziosamente una parola o un silenzio. Sono sensibile al modo in cui un attore “respira” il testo, come inventa una sua propria punteggiatura».
 Una postilla (anzi, due)
Una postilla (anzi, due)
Arresto qui il caleidoscopio di temi e suggestioni per proporre due riflessioni a margine.
La prima riguarda ciò che una parte di me chiamerebbe senza pudore lo stato di opposizione permanente. Ovvero, le condizioni sociali culturali politiche, quindi “autorali”, dentro cui siamo chiamati a perseguire la costruzione di un’idea – leggi: estetica culturale politica – che contempli nel proprio progettarsi la memoria e l’urgenza del tempo presente.
Archeologia del sapere e rumore del mondo legati indissolubilmente, fatti viaggiare all’unisono, come se la Scena teatrale o cinematografica fosse ogni volta una profonda interrogazione su ciò che l’intelletto critico ci prescrive.
Che si risolve nella domanda più volte sottaciuta: possono il teatro o il cinema d’autore non interrogarsi minuziosamente su quel nucleo di questioni che investono sempre e comunque l’esperienza del presente? Se il set o il palcoscenico sono, come dice Elisabeth Perceval, “forme di verità”, si può sfuggire il “dietro le quinte”?
Ciò mi appare ancora più urgente se analizzo in profondità l’opera di un autore-veggente come Samuel Beckett, nei cui manufatti trovo fissato in bella copia ciò che da decenni pare ormai ineludibile: il soggetto Uomo-Personaggio non è più a sé identico e non è più in sé concluso. È quindi altro anche da ciò che la scena ci mostra e che per sua natura dovrebbe costituirsi come ontologia dell’essere distinto.
Eppure il catalogo degli allestimenti beckettiani si nutre ancora oggi di profonde ingenuità, riporta i Personaggi sulla scena come se fossero ancora i Personaggi della “prima volta”, della prima rappresentazione, come se fossero ancora legittimati ad abitare quei luoghi nelle medesime condizioni in cui li volle l’autore.
Perpetuando così l’illusione che quel mondo – il mondo di Aspettando Godot e dintorni – sia ancora possibile, ripetibile, ripristinabile. Ma così non è: Beckett è un “segnale” dello stato finale del farsi teatro, è la freccia che indica la dissoluzione avvenuta, il ruggito insensato di personaggi alla fine della storia, convocati sulla scena per spiattellare l’incredibile “massacro” che si è compiuto.
Si può ri-cominciare, certo, anzi si deve, ma a condizione che la nuova scena sappia integrare il prima della Scena fino a… escluderlo (oltrepassarlo).
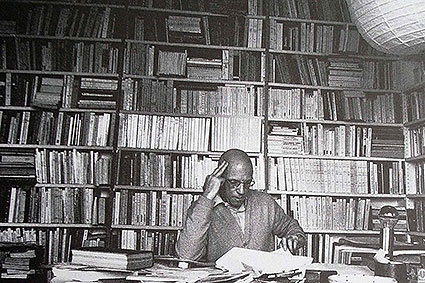 La seconda riflessione origina da una nostalgia, accesasi proprio oggi, guardando il Calendario: 25 giugno. Trent’anni fa, 25 giugno 1984, moriva all’Hopital de la Salpétrière – sagace casualità vuole che questo nome sia comparso poco fa! – Michel Foucault.
La seconda riflessione origina da una nostalgia, accesasi proprio oggi, guardando il Calendario: 25 giugno. Trent’anni fa, 25 giugno 1984, moriva all’Hopital de la Salpétrière – sagace casualità vuole che questo nome sia comparso poco fa! – Michel Foucault.
Moriva a 58 anni, dopo un ricovero che pareva doversi risolvere in fretta, come ricordano gli amici intimi che andarono a visitarlo e con i quali chiacchierava, scherzava, curioso soprattutto di conoscere la sorte del terzo volume della sua Histoire de la sexualité, che aveva visto la luce in quei giorni.
Fu improvvisa e inattesa quella notizia, caduta nel mezzo del pomeriggio tramite uno spaccio di agenzia: “Il filosofo Michel Foucault è morto”. In molti, tra lo sgomento e l’incredulità, chiedevano: di che cosa è morto? Tumore al cervello? Sclerosi multipla? I giornali non davano risposte, alimentando il mistero. A lungo la parola maledetta non venne pronunciata: Aids.
Nel suo Diario intimo – uscito postumo – nel mese di novembre dell’anno prima, l’autore de Le parole e le cose aveva annotato: «So di avere l’Aids, ma la mia nevrosi mi consente di dimenticarlo».
