
Forse nessuno, oggi, volendo esibire nella scrittura o sulla scena una sua ipotetica visione del mondo, si azzarderebbe a proporre un Personaggio-Uomo provvisto di un fondamento pieno e sistematico, il “Tutto organico e concluso” che Nietzsche celebrava nel Caso Wagner (1888); prevarrebbe di contro l’individuo de-storificato, debole e parcellizzato, il Viandante che rincorre luoghi di spaesamento, di frattura, il reduce dell’esistenza inquieta, sottoposto a una temporalità inafferrabile ed enigmatica, che si nutre di marginalità, a tutti gli effetti portatore di décadence, perciò valido messaggero della malattia d’Occidente, suo indiscusso interprete.
Al punto che qualora fossimo colti, in un pomeriggio di domenica, per scherzoso idillio, dal gusto di mettere a confronto due modelli spiccatamente antitetici di scrittura romanzesca novecentesca, come Albert Camus e Thomas Mann, la scelta cadrebbe sul primo se il criterio di giudizio fosse lo spirito del tempo, la conclamata precarietà del soggetto storico, la sua inattendibilità, la sua estraneità, a dispetto dell’ostinata coesione e organicità del secondo, il quale non faceva mistero di affiancare alla costruzione narrativa un cospicuo patrimonio di Note a margine, che qualsiasi lettore avveduto avrebbe potuto separare opportunamente dal tronco romanzesco e leggere come “secondo testo”, a vantaggio proprio di quella presunta unità dell’essere nel mondo e nella storia che l’altro versante – l’orizzonte Camus – considera invece irrimediabilmente “perduta”.
Nella strategia delle forme simboliche, al di là di parole divenute moneta corrente della spirale ermeneutica – disincanto, perduta unità, frammentarietà, parcellizzazione – permane la profonda e irresoluta crisi del Soggetto – l’Io assoluto della tradizione romantica – il suo disfacimento, dislocamento o sfaldamento, al punto che si renderebbe urgente, per consentire viepiù il libero gioco delle coscienze creative, rammentarne ogni volta l’avvenuto decesso – l’inabissamento, il dileguarsi – auspicando al tempo stesso la sua ri-nascita o ri-generazione. Che inizierebbe, beninteso, dalla promessa di non eludere mai più la domanda fondamentale: che cosa, io autore, produco, esibisco sulla Scena teatrale letteraria cinematografica pittorica, che cosa costituisce per me oggetto di rappresentazione, una volta accertato che il presunto Soggetto è de-caduto, “dissolto”, relegato nel “dissolvimento” del suo ruolo? (E dal cui limbo egli ha tuttavia continuato a inviare segnali di fumo, a palesarsi sotto svariate consuetudini, non percependo che così facendo continuava – e continua – a insistere sulla propria inaffidabilità nonché sulla pochezza di strumenti di cui dispone).
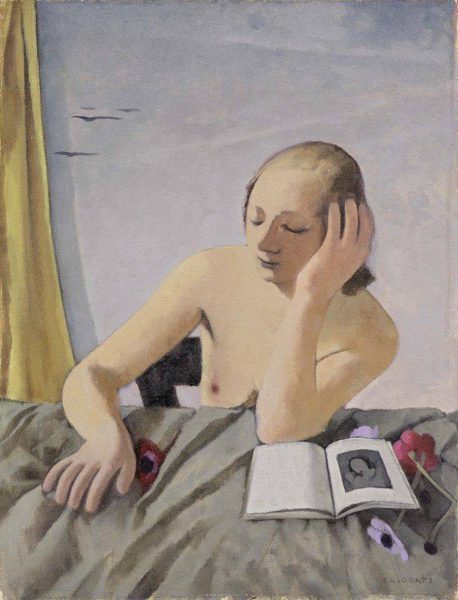
Tra gli ultimi relitti umani che abbiamo visto transitare sulla scena teatrale e sulla pagina sperimentale di alcuni romanzi, rimangono indimenticabili le figure-parvenza di Samuel Beckett, autentici depositari della presunta “nullificazione” dell’Io-Personaggio, sopra cui si è opportunamente distesa la potente scrittura riflessiva di Theodor W. Adorno, che nel saggio del ’61, ormai canonizzato, (Tentativo di capire Finale di partita), invoca appunto la disarticolazione dell’unità della persona – del nesso psicologico, razionale – privilegiando nella tela del Discorso i lucidi, limpidi e apodittici sermoni di Hamm e Clov:
HAMM Ora ti racconto. Lui arriva strisciando per terra…
CLOV: Chi?
HAMM: Come?
CLOV Lui chi?
HAMM Ma andiamo! Ancora un altro.
CLOV Ah, quello! Non ne ero sicuro.
HAMM Strisciando per terra a implorare del pane per il suo bambino. gli offrono un posto da giardiniere. prima di a… (Clov ride). Che c’è da ridere?
CLOV Un posto da giardiniere!
HAMM È questo che ti fa ridere?
CLOV Dev’essere questo.
HAMM Non sarà piuttosto il pane?
CLOV O il bambino.
(Pausa)
HAMM Effettivamente sono cose buffe. Vuoi che facciamo una bella risata a crepapelle insieme?
CLOV (dopo aver riflettuto) Non potrei più ridere a crepapelle, oggi.
HAMM (dopo aver riflettuto) Nemmeno io.
«Non c’è più una legge della forma drammatica – scriveva Adorno – è mutato l’a-priori drammatico». Un fattore che ha scompigliato la forma “fin dentro la sua compagine linguistica”, risultando ancor ‘oggi il connotato sostanziale di ciò che i registi avrebbero dovuto perseguire e trasportare sulla Scena: il perturbamento della struttura Lingua-Parola, che è altra cosa dal celebrato “assurdo” o “non sense” con cui il teatro di Beckett è stato classificato. (Anche perché il “non sense” non è la catastrofe del senso nullificato ma è una innocua assenza temporanea, che rimane ancora saldamente all’interno della compagine “senso”: tutt’altro insomma da ciò che qui è posto sotto esame).
Mettersi “al cospetto della catastrofe permanente”: ecco l’invocazione che il teatro, la scrittura scenica, non dovrebbero mai trascurare, ben sapendo, oggi più di ieri, che di ogni occasione teatrale, di ogni movenza sulla scena, non rimane che… una ridicola imitazione. Se il teatro più colto, più avveduto del Secondo Dopoguerra non ha fatto che concepire e proporre modelli da “imitare” – si pensi a Carmelo Bene, sopra ogni altro – il drammaturgo venuto dall’Irlanda ha silenziato anche questa illusione, disprezzando la parola “sublime” da declinare con la bocca enfiata di “verità”, svelando all’autore-regista che quei precetti sono destinati alla “ridicolaggine”, alla pancia piena di un Falstaff nascosto dietro le quinte.
Sulla scena beckettiana ogni brezza di esistenza si è scoperta davvero dis-umana, rescissa dall’umano, invalidata, finalmente emancipata dall’ossessione delle battute da ripetere disperatamente ogni sera, spogliandosi dei colletti inamidati delle proprie ossessioni quotidiane, dalle voci pervicacemente e fintamente sporche degli attori: l’armamentario delle “compagnie teatrali”, sempre pieno di buone intenzioni, è andato in malora, la scena è da ri-costruire e proprio lo spettatore che ritroverà il desiderio di andare a teatro, a dispetto della partita di calcio di metà settimana o della desolante saga televisiva a puntate, non avrà nemmeno il tempo di togliersi il pastrano e accoccolarsi tra le luci della sala che si troverà a fare i conti con la domanda fondamentale: questa sera, questa scena, chi la percorrerà?
Adorno paventava una soluzione primitiva, che potesse corrispondere alle condizioni del minuto successivo alla catastrofe, quando le figure da far muovere e agitare sul proscenio semibuio sono già talmente mutilate da somigliare a “mosche che si contraggono dopo che lo schiacciamosche le ha già mezzo spappolate”. Alla stregua dei “concetti”, dell’apparato declamatorio di cui gli Attori gloriosamente si nutrono: rimarrebbero come guardaroba della scena, messi lì per caso o trovati alla rinfusa, di cui lo spettatore può fare incetta, scegliendoli magari per il “colore”, per la tinta “affettiva” (ritrovando il cuore pulsante, il marchio di antiche stagioni teatrali):
CLOV Ti lascio
HAMM No!
CLOV A che servo io?
HAMM A darmi la battuta (Pausa) Ho portato avanti la mia storia. (Pausa) L’ho portata avanti di parecchio. (Pausa) Domandami dove sono arrivato.
CLOV Oh, a proposito, e la tua storia?
HAMM (molto sorpreso) Che storia?
CLOV Quella che ti racconti da sempre.
HAMM Ah, vuoi dire il mio romanzo?
CLOV Appunto.

Occorre perciò che il teatro ri-stabilisca il suo nome “effettivo”, additando la miseria della filosofia scenica venuta dopo i grandi scismatici che hanno divelto il “cielo di carta” sul finire del Secolo XIX e i primi decenni del Novecento: Henrik Ibsen, Anton Čechov, Luigi Pirandello, Antonin Artaud. E rammentare agli autori-registi dei nostri anni che rimane in piedi una sola chance, una sola fiamma da sperimentare, a cui potremmo dare, con impertinente retrogusto romantico, il nome di “inattingibile”: mettere a soggetto-oggetto di “rappresentazione” ciò che può essere visto e udito soltanto in quel momento, nell’immanenza “terrorizzante” della Scena che genera la “frattura”, la “ferita” dello spettatore pensante, il quid che trascende ogni ostinato e minuzioso fermento delle forme per fare irruzione nella nudità del “Così è” o del “Com’è che lo so già ma non l’ho ancora sentito?”.
In una parola, il Tragico, il tragicus delle origini: «Sì, sperduti… ci veda “sperduti”, va bene… Ma nel senso, veda, che l’autore che ci creò vivi, non volle poi, o non poté materialmente, metterci al mondo dell’arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche della morte», dirà il Personaggio-Padre dei Sei Personaggi in cerca d’autore, quasi preannunciando il rombo funesto che sospende il movimento degli attori ne I Giganti della montagna o forse riecheggiando la cantilena demente di Ljubov’ Andreevna nel Giardino dei ciliegi: Il mio bambino è morto, è affogato… Perché? Perché, amico mio? Di là c’è Anja che dorme. ed io sto parlando forte, faccio rumore… Come state, Petja? Come mai siete diventato così brutto? Perché siete così invecchiato?
(Apro fuggevolmente una parentesi, sulla eco del cechoviano Giardino dei ciliegi. Ho letto che una nuova versione di quest’opera verrà messa in scena da Alessandro Serra, regista-autore che di recente ha tentato – avvalendosi dell’apporto linguistico di Giovanni Carroni – una riabilitazione del Tragico come epos figurativo, nello spettacolo Macbettu (2016-2017), prodotto dal Teatro di Sardegna, progetto di lunga gestazione, nato tra i suoni-metafora dei Carnevali della Barbagia, tra le maschere clamanti e assordanti di interminabili processioni, poi divenuto campo di battaglia permanente, inquieta fucina di corpi teatrali da restituire alla scena, con precise avvertenze: che il calco shakespeariano non si può riprodurre a oltranza, che la centralità della Scena non risiede in una “idea” di regia che si preoccupi di scomporre gli elementi dell’in-folio per riconnetterli e ritrovarli dentro “inedite” tracce figurative. Si tratta piuttosto di ri-modellare una Lingua – la “limba” barbaricina – sapendo che appena pronunciata, appena gettata fuori, riporterà alla luce l’elemento tragico-arcaico, restituendo il “primitivo” del gesto ancora incompiuto, del grido sospeso. Ma per arrivarci occorre percorrere un itinerario critico che ritrovi e rinnovi il rapporto Mito/Filologia, di contro alla tentazione, più volte rincorsa dai registi, di privilegiare la sostanza etica e storica della tragedia. Una drammaturgia che si appropria e rilancia le questioni del Mito, “centralizzando” il ruolo dell’Attore, convocato sulla scena non più per ri-modellare le battute di un copione ma per pronunciare e rivelare la natura inconscia di quelle parole, attestando e imponendo la propria identità scenica come “contenuto” della rappresentazione: attore “intuitivo”, addestrato a organizzare con il proprio corpo movenze esasperate, “cabbalistiche”, contrapponendosi al “moderno” della tradizione, all’attore “storicizzato” da modelli usurati. E a cui del resto non rimane estranea la lezione del Teatro dei manichini. Secondo Libro della Genesi di Bruno Schulz, già indagata da Serra nel 2009).
Da dove ri-cominciare, dunque? Dal Soggetto “de-contestualizzato”, che lotta per situarsi fuori del “contesto” di appartenenza, ostenta un’intransigente vocazione nichilista, si smarrisce volontariamente negli spazi incommensurabili delle Città metropolitane, sperando che la sospirata e conclamata disappartenenza sia visibile palese tangibile, al riparo di regole e concetti. Nella New York di John Dos Passos (Manhattan Transfer, 1925) o di Alain Robbe-Grillet (Progetto per una rivoluzione a New York, 1970) le tracce di estraneità, di scomposizione, di sgretolamento si affermano dentro la convenzione dei corpi frantumati, che si ritrovano nei medesimi crocicchi metropolitani, storicamente dispersi, impossibilitati a riconoscersi “organici”, anzi convintamente protesi a farsi invadere da una “moltitudine di segni il cui insieme costituisce la mitologia del mondo dove vivo, qualcosa come l’inconscio collettivo della società” (Robbe-Grillet).
Argomenti che percorrono e tormentano al contempo la musica novecentesca – Ravel, Shostakovic, Stravinsky, Luigi Nono – mentre il cinema degli anni ’60 e ’70, trovando complicità negli espedienti della décadence, si esalta nella lezione di stile di Jean-Luc Godard (Pierrot le fou, La femme mariée, Deux ou trois choses que je sais d’elle, Made in U.S.A., Week-end) e nell’opera prima di Jean Eustache, La maman et la putain.
Si tratta tuttavia di tracciati che, nell’ottica prefigurata, si muovono ancora all’interno di deviazioni riconoscibili, dove è possibile identificare analiticamente il limite dell’azzardo, la linea divisoria, mentre per Beckett la “de-contestualizzazione” è soltanto l’ultimo inganno, il raggiro manifesto di un percorso intellettuale a cui ci si oppone praticando ostinatamente lo smantellamento inevitabile fatale ineluttabile sia delle “figure” che delle “immagini”, riproducendo il fallimento “disgustoso” cui soggiace ogni essere contaminato dal “sapere”, come i vecchi genitori di Hamm imprigionati nel bacino dell’immondizia, che con-dividono e ri-evocano le azioni superstiti concesse al loro ultimo respiro.

Ma è possibile predisporre, approntare un luogo teatrale che sia luogo dell’accadere del ni-ente, quindi nuovo inizio dell’evento “teatro”? Nel saggio Che cos’è metafisica? (1929), Martin Heidegger conchiude il “niente” dentro una determinata definizione: «Il niente è la negazione completa della totalità dell’ente (…) Occorre che sia prima data la totalità dell’ente, affinché, semplicemente come tale, questa possa cadere sotto la negazione, nella quale poi il niente stesso dovrebbe annunciarsi».
Annuncio è parola teatrale, parola beckettiana – e non perché si rivela pretesto di qualcosa che non può accadere ma perché permane nella condizione precedente, dove si dà un niente che “è più originario del ‘non’ e della negazione”.
«Già al primo contatto – scrive Heidegger – la domanda mostra qualcosa di insolito. Nel porcela, infatti, noi già dall’inizio assumiamo il niente come qualcosa che “è” così e così, cioè lo trattiamo come un ente. Eppure il niente differisce proprio da esso in modo assoluto. Domandare del niente, chiedere che cos’è, e come è, significa tradurre l’oggetto della domanda nel suo contrario. La domanda si priva essa stessa del suo oggetto proprio».
Si rivelerebbero vani gli sforzi di rinvenire tracce esplicite di Heidegger in Beckett e viceversa. L’indice dei Nomi della biografia scritta da Deirdre Bair nel ‘78 non contempla richiami al pensatore di Marpurgo così come il Dictionnaire Heidegger, edito nel 2013, non fa alcuna menzione dell’Irlandese. Eppure, entrambi sono alla ricerca dell’analogo punta di caduta, che prevede appunto non l’interrogazione “sul” niente (come abbiamo creduto da spettatori ingenui di Aspettando Godot) ma l’interrogazione del niente, prendere in carico la responsabilità di interrogare il Niente.
«Se il niente, comunque ciò avvenga, dev’essere – esso stesso – interrogato, allora bisogna che esso sia prima dato. Noi dobbiamo poterlo incontrare. Dove cerchiamo il niente? Come lo troviamo? Per trovare qualcosa, non dobbiamo forse già sapere in generale che c’è? Certamente! Innanzitutto e per lo più l’uomo è in grado di cercare solo se presuppone la presenza di quel che cerca. Ora, però, quel che cerca è il niente. Ma c’è in fondo un cercare senza quella presupposizione, un cercare cui corrisponda un puro trovare?».
Potrebbe trattarsi appunto della scintilla filosofica dell’esperimento beckettiano: il continuo, persistente avvento del “niente” come soggetto privilegiato della rappresentazione, che avviene nell’unico spazio dove può darsi la “totalità” del gesto di rappresentazione, lo spazio del Teatro, della Scena theatrum mundi.
Per alcuni grandi autori precedenti a Beckett era consueto che la realtà oggetto della rappresentazione fosse finalizzata ad una presunta o presumibile “unità” della drammaturgia e dei personaggi, sforzo necessario per non cadere sotto il giogo della realtà frantumata e dispersa: che per Beckett è invece il punto di partenza.
Spetta ancora ad Heidegger illuminare il cavillo teorico-concettuale che ne scaturisce: «Ma per quanto frantumata possa apparire la vita quotidiana, nondimeno essa mantiene ancor sempre l’ente, anche se nell’ombra, in un’unità del “tutto”. Anche quando, e proprio quando, non siamo particolarmente occupati dalle cose e da noi stessi, ci soprassale questo “tutto”, per esempio nella noia autentica (…) La noia profonda, che va e viene nelle profondità dell’esserci come una nebbia silenziosa, accomuna tutte le cose, tutti gli uomini, e con loro noi stessi in una strana indifferenza. Questa noia rivela l’ente nella sua totalità.
Un’altra possibilità di una tale rivelazione si nasconde nella gioia che nasce in presenza dell’esserci – e non della mera persona – di un essere amato. Questo essere in uno stato d’animo, per cui si “è” così o così, ci consente, quando ne siamo pervasi, di sentirci situati in mezzo all’ente nella sua totalità. Il sentirsi situati (Befindlickeit) proprio dello stato d’animo in cui ci si trova non solo svela a suo modo l’ente nella sua totalità, ma questo svelamento, lungi dall’essere un mero accidente, è al tempo stesso l’accadimento fondamentale del nostro esser-ci» (versione di Franco Volpi, sottolineature mie).
Rielaborando queste parole nella linea di discorso ipotizzata, suonerebbero così: il teatro si offre come luogo in cui avviene lo svelamento dello stato di pienezza e di molteplicità del nostro esser-ci, il luogo in cui ci si sente situati “in mezzo all’ente nella sua totalità“, quindi “l’accadimento fondamentale”. Ma per raggiungere questo stato occorre valicare la linea divisoria che contempla il “niente”: «Eppure proprio quando gli stati d’animo ci conducono dinanzi all’ente nella sua totalità, ci nascondono il niente che noi cerchiamo». Da cui la domanda: «Accade nell’esserci dell’uomo un simile stato d’animo in grado di portarlo dinanzi al niente stesso?». Risposta: «Questo accadere è possibile e, benché assai di rado, è pure reale, solo per degli attimi, nello stato d’animo fondamentale dell’angoscia (Angst) (…) Nell’angoscia noi diciamo “uno è spaesato”. Ma dinanzi a che cosa v’è lo spaesamento e cosa vuol dire quell’”uno”? Non possiamo dire dinanzi a che cosa “uno è spaesato”, perché lo è nell’insieme. Tutte le cose e noi stessi affondiamo in una sorta di indifferenza. Questo, tuttavia, non nel senso che le cose si dileguino, ma nel senso che nel loro allontanarsi come tale le cose si rivolgono a noi (…) L’angoscia rivela il niente (…) Nell’angoscia il niente viene incontro insieme alla totalità dell’ente (…) Nell’angoscia, l’ente nella sua totalità vacilla (…) Nell’angoscia non ha luogo un annientamento di tutto l’ente in sé, né, tanto meno, una negazione da parte nostra dell’ente nella sua totalità, per guadagnare alla fine il niente (…) Il niente ci viene incontro già prima, ci viene incontro “insieme” all’ente nella sua totalità che si dilegua».
Il “niente” di Heidegger è dunque strettamente annodato al tema dell’angoscia, è l’angoscia che fa affiorare l’ente nella sua nudità essenziale: «Solo nella notte chiara del niente dell’angoscia sorge quell’originaria apertura dell’ente come tale, per cui esso è ente e non niente».
Dal “niente” che Beckett ha spalancato origina una scena che si offre come epifania, come l’accadere di un presente-evento percorso da un tempo altro, alterato, separato dalla cronologia, un tempo immanente che traccia una netta discontinuità rispetto ai consueti meccanismi – meccanicismi – della scena moderna, negativamente responsabile di professare il “nuovo” esclusivamente come variante spettacolare. Sicché limitarsi a riprodurre testi, nell’infinita ripetizione della parola “scolpita”, disattende l’occasione “teatro”, disattende la nozione di “tempo” teatrale, che parafrasando Emmanuel Lévinas sarebbe “il lasso dell’irrecuperabile”: ciò che forse aveva visto Georges Pitöeff, trovandosi a mettere in scena i Sei Personaggi di Pirandello nel ’23, due anni dopo la “prima” di Roma al Teatro Valle: li aveva fatti “discendere” dall’alto, dentro un montacarichi azionato da un congegno meccanico, “depositandoli” sul proscenio, offrendo la variante dell’evento–parusìa – l’essere presso di noi della teologia cristiana – innescando nella figura del Personaggio-Padre il corpo e la voce del Cristo compianto, sulle ceneri della storia che seguiva alla devastazione del Primo Conflitto mondiale.
Le conclusioni cui perviene Heidegger potrebbero far da prologo al “destino” della ricerca teatrale: «Solo nella notte chiara del niente dell’angoscia sorge quell’originaria apertura dell’ente come tale per cui esso è ente – e non niente (…) Solo sul fondamento dello stupore, ossia dell’evidenza del niente, sorge il “perché?”, e solo in quanto il perché è possibile come tale, noi possiamo domandare dei fondamenti e fondare in modo determinato. Solo perché possiamo domandare e fondare, è assegnato alla nostra esistenza il destino della ricerca».
Se ponessimo accanto alla parola filosofia la parola teatro, il finale heideggeriano apparirebbe così: «La filosofia (il teatro) si mette in moto soltanto attraverso un particolare salto della propria esistenza dentro le possibilità fondamentali dell’esserci nella sua totalità; quindi il lasciarsi andare al niente, cioè il liberarsi dagli idoli che ciascuno ha e con i quali è solito evadere; infine il lasciare librare sino in fondo questo essere sospesi, affinché esso ritorni costantemente alla domanda fondamentale della metafisica, a cui il niente stesso costringe: Perché è in generale l’ente e non piuttosto il niente?».

Del motivo della inseparabilità tra essere e nulla – che potrebbe costituire, nell’ipotesi qui cercata, l’origine filosofica del teatro di Beckett – scrive Luigi Pareyson in un saggio del ‘92 intitolato La domanda fondamentale. Perché l’essere piuttosto che il nulla?: «Essere e nulla sono coinvolti nella loro inseparabilità anzi nella loro quasi coincidenza». E prosegue: «L’affinità di essere e nulla, per cui di entrambi si può dire insieme che “non sono” e che “ci sono”, mostra la necessità di rifiutare tanto la metafisica quanto il nichilismo. Infatti allo stesso modo che l’essere non dev’essere metafisicamente inteso come essente, così il nulla non dev’essere nichilisticamente inteso come il “nulla negativo”. Il discorso che qui si fa sul nulla non è ispirato allo spirito di negazione che si pone al servizio della distruzione e mina ogni volontà costruttiva. Com’è frettoloso e quindi precario il discorso che ravvisa il fondamento di tutto l’essente in un preteso essente di tipo superiore, altrettanto lo è il discorso che, interpretando il nulla come il puro negativo, conclude che “tutto è nulla, sì che non vale la pena né di vivere né di morire”. Il nulla è la negazione (Verneinung) non l’annientamento (Vernichtung) del complesso degli essenti (…) Il nulla di cui qui si parla “è” altrettanto come “è” l’essere: non lo si può definire come il mero negativo, poiché ha altrettanto essenza che l’essere».
E poche righe prima, riportando un passaggio di Che cos’è metafisica?, dove è detto “Il nulla, in quanto altro dall’essente, è il velo dell’essere”, Pareyson precisa: “naturalmente il velo occultante, rivelante dell’essere”. Il teatro di Beckett come “velo dell’essere” consente ogni volta allo spettatore la meraviglia di scoprire che c’è l’essere – la Scena – piuttosto che il Niente. Un “non”, quindi, che rimane in bilico tra resistenza e dissoluzione, tra il rimanere ancora nell’inerzia della testimonianza postuma o lo sparire definitivamente e conseguentemente. La Scena beckettiana segnala questa linea di confine, oltre la quale si compie la ri-appropriazione oppure lo smantellamento dell’essente, dell’Attore sulla Scena. Come recitano le ultime righe de L’Innominabile: «Bisogna continuare, e io continuo».
Liberarsi dagli idoli che ciascuno ha, lasciare librare fino in fondo questo essere sospesi: che il sipario dovesse chiudersi definitivamente, sprangato dai lucchetti, mentre dietro il tendone ancora blaterano e ciondolano vanamente i “ragionatori” di Pirandello o le contorte acrobazie della scena filosofica francese – da Camus a Sartre a Lacan – è appunto la “missione” che Beckett porta in dote al Secolo Ventesimo: non devono più restare sulla scena del Teatro-Mondo segni di riconoscimento, tracce di idealismo, barlumi di Idee, forme di “dialettica” che possano impadronirsi dei personaggi o delle situazioni: la realtà deve farsi inconoscibile, fredda e raggelata, nessuna appartenenza consanguinea è ancora ammessa. La storia del Novecento ha trasfigurato i connotati della vita collettiva, sul corpo della polis sono rinvenibili marcate lacerazioni e della vecchia scena rimangono larve che a fatica, senza convinzione, si scambiano le ultime informazioni:
HAMM: Ho conosciuto un pazzo che credeva che la fine del mondo ci fosse già stata. Dipingeva. Gli volevo bene. Andavo a trovarlo, al manicomio. Lo prendevo per la mano e lo tiravo davanti alla finestra. Ma guarda! Là. Tutto quel grano che spunta! E là! Guarda! Le vele dei pescherecci! Tutta questa bellezza (Pausa). Lui liberava la mano e tornava nel suo angolo. Spaventato. Aveva visto solo ceneri. (Pausa). Lui solo era sopravvissuto. (Pausa). Dimenticato. (Pausa). Sembra che questi casi non siano… non fossero così… rari.
CLOV: Un pazzo? Quando è stato?
HAMM: Oh, altri tempi, altri tempi. Tu non eri ancora di questo mondo.
CLOV: La belle époque.
HAMM: Gli volevo bene. Dipingeva.
CLOV: Ci sono tante cose terribili.
HAMM: No, no, non ce ne sono più tante.

Il resto è commedia, da replicare all’infinito, per i registi che verranno dopo la catastrofe e si diletteranno a trovare l’attrice “giusta” per Winnie di Giorni felici (il titolo inglese, Happy days, in francese diventa Oh, les beaux jours, che in italiano sarebbe Oh, i giorni belli), persuasi ogni volta che trovarla interrata con un parasole sopra la testa, il corpetto attillato, “ben conservata, preferibilmente bionda, grassottella, braccia e spalle nude, seno generoso, giro di perle”, gli occhi ancora frementi di vita vissuta, avrebbe potuto replicare il tragico sgomento di chi, una sola volta, una sola sera, una sola notte dell’anno 1962 – complice l’attrice Madeleine Renaud – aveva osato ritrovarsi dentro quella voragine aperta tra le viscere della terra.
Winnie di Giorni felici è una Immagine-Epifania, al pari della sedia a rotelle di Hamm in Finale di partita o le ceste dell’immondizia da dove affiorano le teste di Nagg e Nell. E ancora: il registratore di Krapp, la bocca di Non Io, il rumore dei passi strascicati dei coniugi Rooney in Tutti quelli che cadono, l’ossessivo rumore del mare di Ceneri, la donna seduta che ascolta la sua voce registrata in Dondolo, le scarpe di Estragone o il ramo spoglio dell’albero di Godot.
Le parole che circolano ai bordi delle Immagini-Epifania, nel confuso biascicare e blaterare, devono infine apparire “prive di fondamento”. Sono le “parole” della filosofia e Finale di partita, come scriveva Adorno, è la miseria della filosofia. Se già la Trilogia ultimata nel ’53 (Molloy, Malone muore, L’Innominabile), nei sussulti infiniti di decretata afflizione, aveva provveduto a spazzare via interi modelli di vita letteraria – il monologo interiore, il flusso di coscienza, l’Io diviso – il teatro si preoccupa di fare tabula rasa delle declinazioni essenza-esistenza che il Novecento filosofico ha mandato allo sbaraglio. Così Godot, Hamm, Krapp – e prima di loro Molloy, Malone – diventano prototipo di ciò che non si può più scrivere né rappresentare, li si colloca una sola volta nella penombra di un proscenio, li si rende attori di una emersione unica, di una sola recita, li si costringe a constatare che “l’Io è identico anche nelle sue alterazioni” (Lévinas) e poi, da quel momento, si replica indefinitamente la finzione di avere ancora qualcosa “da portare sulla scena”.
HAMM: E poi parlare, presto, delle parole, come il bambino solitario che si mette in diversi, in due, in tre, per essere insieme, e parlare insieme, nella notte. (Pausa). Un istante dopo l’altro, pluf, pluf, come i chicchi di miglio di… (cercando)… di quel vecchio greco, e tutta la vita uno aspetta che questo gli formi una vita. (Pausa. Sta per continuare, vi rinuncia. Pausa). Ah, esserci, esserci!
Diventa perciò increscioso ascoltare attori e attrici che rivendicano emotivamente la “proprietà” di quei Testi, assaporando la madeleine della dizione inquieta, concentrati e “calati” e identificati, non prestando fede al fatto che dopo Beckett ogni ribattitura, ogni indugio, ogni gonfiamento di parola decreta soltanto l’insopportabile retorica del “fare teatro” (per niente oltrepassata, va precisato, dal cosiddetto teatro gestuale o corporale, dove il delirio della “danza” scenica raddoppia, se possibile, lo strepito del “convenzionale”).
Combinazioni paradossali hanno fatto sì, insomma, che il geniale sovvertitore delle forme teatrali del ‘900 sia stato al contempo l’esecutore testamentario del lascito romantico-ottocentesco, colui che ne ha predisposto il silenzio alla maniera di Lord Chandos, avvertendo i vetusti naviganti-registi che non sarebbe stato oltremodo consentito di inondare la Scena di ampollosità letterarie o filosofiche, di veri o falsi “naturalismi”, di parole combinate in mille maniere, anzi, d’ora in avanti chi farà teatro dovrà sapere che di parole ne saranno ammesse al più “una o due”, come è nella consuetudine della Donna sulla sedia a dondolo: “Ancóra”.
(A tal proposito, dischiudendo una parentesi futuribile, il teatro di Beckett avrebbe potuto porsi a modello di una ipotetica, doverosa Scena futura che nella lingua di Heidegger si chiamerebbe Altro Inizio o Altro Cominciamento, con riferimento appunto ad un Testo scritto tra il ’36 e il ’38 in cui “prende forma un universo speculativo nuovo e sorprendente” (F. Volpi) – “il più importante di una serie di trattati inediti del secondo Heidegger“, “la sua seconda opera capitale” – un testo a tutt’oggi poco commentato dagli studiosi, che attende di essere “svelato” nella sua vigorosa sistematicità teoretica: Contributi alla filosofia. Sull’evento. Di cosa si tratta? Traduco integralmente dal francese le parole di Philippe Arjakovsky, autore della voce “Autre commencement” del Dictionnaire Heidegger: «Pensare l’inizio per la “prima” volta – pensare il cominciamento in se stesso (e non di ciò che è iniziato a partire da esso) – pensare il cominciamento dicendosi anche – nel punto limite – che non è ancora veramente iniziato, insomma pensare quello che Heidegger ha chiamato, echeggiando con forza il termine Ereignis, die Anfangnis des Anfangs, “l’incipienza del cominciamento”. In tutta evidenza, “l’altro” inizio sta in opposizione al “primo” inizio; tuttavia sarebbe un grave errore ritenere che si tratti di due “inizi” differenti. L’inizio è singolare. Di conseguenza, “l’altro” inizio non è del tutto da intendere nel senso del secondo inizio, ancor meno di un nuovo inizio, peggio ancora di un ennesimo ri-cominciamento. Bisogna intendere “altro” nel senso di un avverbio, cioè di una modalità: l’altro inizio non è puramente e semplicemente che l’altra maniera di entrare in cominciamento – l’altrimenti del cominciamento. Heidegger lo enuncia con precisione nella lettera ad Hannah Arendt del 19 aprile 1972: “L’altro cominciamento non è un secondo cominciamento, ma il primo e unico cominciamento, secondo un’altra modalità”. Heidegger quindi non oppone il primo e l’altro cominciamento, se non altro perché è questo “altro” cominciamento che consente di vedere per la prima volta l’unicità del primo e unico inizio»).

Ancora due annotazioni per concludere questa sezione. La prima del regista-attore Roger Blin: «Beckett esigeva che io e Jean Martin porgessimo certi brani del testo come uno strumento che suona delle note musicali, riproducendo fedelmente la stessa nota. Per esempio, io dovevo chiamare Clov diverse volte durante lo spettacolo e Beckett concepiva questo richiamo come una nota dello spartito che dovevo riprodurre senza preoccuparmi del posto di questa nota nell’evoluzione psicologica del personaggio»; la seconda del “cronista” critico teatrale-scrittore Roberto De Monticelli, datata 4 luglio 1958 e riferita alla serata “unica” che prevedeva Finale di partita e Atto senza parole – regia di Roger Blin, attori lo stesso Blin e Jean Martin – dove si trovano prefigurati i connotati storico-estetici del regno beckettiano che verrà: «Siamo sul versante che guarda verso la notte, non c’è che il buio da questa parte, il buio nel vuoto (…) Fuori da questa stanza è l’”altro inferno”, il deserto; ma il deserto dove tutto è già stato consumato e bruciato, poiché alle domande di Hamm, Clov, lo schiavo-figlio, risponde: “Non c’è più natura”, e se l’altro, con apparente banalità, gli chiede che ora è, ribatte: “Non esiste più tempo” (…) Cosa accade? Non può accadere nulla, evidentemente. Nel dramma precedente di Samuel Beckett c’era, unico baleno di speranza, l’attesa dell’invisibile Godot. Questo Godot che non arriva mai è diventato quasi un simbolo nell’angoscia del mondo contemporaneo, in cui gli uomini si avviano rapidamente a prendere i connotati indefiniti, fatti di sabbia sporca, di questi personaggi, di Hamm, di Clov, dei due tronconi agonizzanti nei secchi di lamiera. Qui, invece, non c’è nessuna attesa, la partita è chiusa e mentre i due vecchi muoiono, sgranocchiando l’ultimo biscotto, nei bidoni il cui coperchio è stato riabbassato per sempre, Clov se ne va, ha visto qualcosa che si muove fuori, nel deserto, non sa se uomo, donna o bestia; ma che importanza ha? Tanto, fuori di lì è la morte; come la morte è dentro, fra quei muri grigi, dove rimane soltanto Hamm, ad aspettare la fine, mettendosi, sulla faccia senza sguardo, sudario miserabile, un fazzoletto macchiato di sangue».
Ecco: percorrendo la sensazione della “faccia senza sguardo”, il “sudario miserabile” di Clov, i cui occhi hanno visto o ai cui occhi è parso di vedere qualcosa che si muove fuori, nel deserto, ho immaginato di veder riflesso lo sguardo di Tonio Kröger, di Gustav von Aschenbach, di Hans Castorp o quello più sfuggente e spiritato di Adrian Leverkühn, insomma dei grandi eroi-personaggio dell’impresa letteraria che porta il sigillo Thomas Mann. Senza poter tuttavia vantare alcuna “relazione” attiva tra i due “campioni” del ‘900, entrambi Premio Nobel per la letteratura – Mann 1929, Beckett 1969 ; come se una deliberata volontà avesse sussurrato loro di ignorarsi consapevolmente, ben sapendo, entrambi, che il nome Beckett non avrebbe certo sfigurato tra due richiami come Baudelaire e Beethoven, nell’Indice dei Nomi che attraversa il volume Nobiltà dello spirito. Ho anche fantasticato che Krapp facesse ritorno sul proscenio stringendo sottobraccio l’Ultimo Nastro e consentisse l’ascolto di un suo inedito Monologo-Colloquio con il Diavolo, divulgando inaspettatamente una riscrittura per voce sola dell’indimenticabile Capitolo XXV del Doctor Faustus.
Circostanze inverosimili, che servono tuttavia a mettere in relazione due criteri di esistenza artistico-letteraria: uno, Beckett, teso a conchiudere e concludere nel silenzio qualsiasi ulteriore “martirio” della lingua e delle forme ad essa rispondenti (culminato nella scelta finale di creare “immagini” trascendenti, di distillare una “trascendenza” delle immagini rappresentate, immagini che quindi non trattengono e non stringono oltremodo “concetti”); l’altro, Mann, il titano della parola, della parola critica, dello smisurato commento-intrattenimento, che alla maniera di Sisifo prende su di sé il compito, l’impiego, l’ufficio, di cercare e creare “realtà”, le realtà-mondo, descrivendole ostinatamente in ogni ipotetica traccia o corrispondenza, penetrando nella tremenda molteplicità che le percorre, nel dettaglio mostruoso dei rimandi, delle interrogazioni, aggredendole nel corpo vivo della Lingua-linguaggio dentro cui si avvolgono e si proteggono e che mai nessuno potrà considerare “esaurita”.
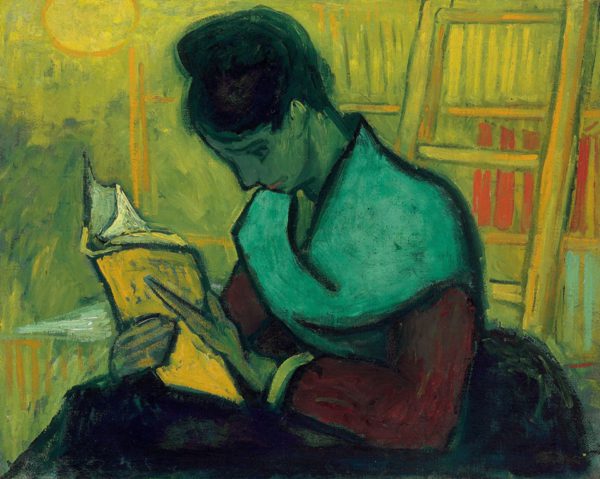
Lo dimostra la Thomas Mann Renaissance di questi anni, il minuzioso lavoro critico-analitico che a partire dal 2010 Luca Crescenzi sta compiendo sull’intero corpus dell’odissea manniana, sotto la guida e la supervisione di Renata Colorni, responsabile della collana I meridiani Mondadori nonché protagonista della nuova traduzione/versione in lingua italiana – dopo decenni di paziente attesa dalla prima edizione Dall’Oglio apparsa nel ’32 per le cure di Bice Giachetti-Sorteni – del grandissimo romanzo del ’24, con il nuovo titolo La montagna magica, a sostituzione del titolo che nella nostra formazione era rimasto durevolmente impresso : La montagna incantata.
Comprendiamo meglio oggi, rispetto ad alcuni decenni fa, che Thomas Mann aveva preso su di sé il compito immane di mostrare, attraverso l’epica di personaggi e racconti sospesi tra realtà e mito, che su di noi, abitatori dell’Occidente europeo, gravava il presentimento di una totalità disgregata che presto avrebbe inghiottito le utopie di erudizione cultura trasformazione. Che a noi, provetti Hans Castorp, competeva quel cammino iniziatico del farsi individui dell’età della ragione nel Secolo XX, predisponendo le armi della consapevolezza impavida e dolorosa, della dialettica irrinunciabile, sguainata con ardore di fronte ad ogni barlume di conoscenza, disponendoci conseguentemente alla responsabilità – suprema consapevolezza – del fare arte e divenire artisti.
Quel Novecento che trova appunto ne La Montagna magica (1924) il primo, monumentale suggello, con l’investitura a personaggio-protagonista di “un giovane uomo come tanti altri”, il giovane ingegnere Hans Castorp, nichilista inconsapevole, chiamato a percorrere l’ascesa verso le “regioni estreme” di Davos-Platz e del Sanatorio Internazionale Berghof, nel Cantone svizzero dei Grigioni (Ci sono voluti ben cinquemila piedi di arrampicata per arrivare qui da voi…), per cospargere di correnti iniziatiche il proprio apprendistato, il proprio accrescimento morale e spirituale, avendo già alle spalle due modelli nei quali riconoscere la discendenza di scrittura, il giovanissimo Tonio Kröger (1903) e l’attempato Gustav von Aschenbach di Morte a Venezia (1912), entrambi impegnati a “rovellare” e “questionare”, a evidenziare dubbi e supplizi circa la presunta supremazia dell’arte su altre forme di esistenza sensibile.
Sanno bene i lettori di Thomas Mann che la sorte dei personaggi messi in campo dallo scrittore di Lubecca non è poi tanto dissimile dalla sorte medesima dell’Autore: Thomas Mann ha tratteggiato con spietata veridicità la condizione dell’Artista-Genio del Secolo XX, le cui tappe, i cui stadi di crescita e di evoluzione conviene rammentare: 1901, I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia; 1903 Tonio Kröger, Tristano; 1912: Morte a Venezia; 1918: Considerazioni di un impolitico; 1924: La montagna magica; 1933-1943: Giuseppe e i suoi fratelli; 1947: Doctor Faustus.
A ciascuna di queste opere, poi, è risolutivo aggiungere, affiancare, integrare l’elemento che Claudio Magris ha chiamato la custodia, ovvero il sistematico, imprescindibile corredo critico, il catalogo di saggi interventi conferenze prolusioni, composto dallo scrittore lungo l’arco di sei decenni, un apparato letterario-strategico indispensabile per risalire all’origine fenomenologica di ciascuna Opera. Un libro che non per niente vanta un titolo perentorio e illimitato: Nobiltà dello spirito. A cui guardare come breviario o compendio dell’intera avventura intellettuale del ‘900, come exemplum di una critica d’arte condotta nella più minuziosa vigilanza e nelle cui pagine si palesa con forza e costanza lo statuto di epigonalità del genio artistico.
Chissà quante volte Mann avrà riletto l’Aforisma 148 del Primo Libro di Umano troppo umano dove i poeti sono indicati come “alleviatori della vita” («Per poter far ciò, devono essere essi stessi rivolti all’indietro: sicché possono essere utilizzati come ponti per epoche e concezioni affatto remote e per religioni e civiltà morenti o morte») e la cui conclusione suona: Essi sono propriamente, sempre e necessariamente epigoni.
Se “epigoni” furono chiamati nella mitologia greca i figli dei Sette Prìncipi che riproposero a distanza di dieci anni la guerra contro Tebe per vendicare la morte dei loro padri, quindi i “nati dopo”, i “continuatori”, Mann è per eccellenza l’epigono “tedesco-tebano” del Secolo XX, l’ideatore – storicamente oltre che letterariamente – del Romanzo intellettuale del ‘900. Che, com’è noto, affida al Lettore il dilemma della doppia “verità” da perseguire: “spirito e arte, lirica e critica, immediatezza poetica e consapevolezza filosofica” (G. Baioni), che l’autore definirà nelle Considerazioni di un impolitico “una mescolanza di elementi in apparenza eterogenei: malinconia e critica, intimità e scepsi, Storm e Nietzsche, stato d’animo e estro intellettualistico”. Insomma il problema Arte/Vita oppure Vita-Arte-Morte che scivolando nella profondità del corpus estetico letterario, sostenuto dalla lucida e spietata ambizione della coscienza critica, plasma l’individuo storico-romantico, consegnandolo ad un destino di gloria duratura.
Noi, individui del Secolo XX, siamo stati gli eletti destinatari di quella gemma di arte poetica che è il “finale” del Tonio Kröger, la Lettera a Lisaweta – scritta un anno dopo la Lettera di Lord Chandos firmata Hugo von Hofmannstahl – che non avendo esaurito o smorzato lo spirito lungimirante che la attraversa, si presta ancora oggi a costituire un ingresso privilegiato al “far-si” della poesia-letteratura: «Io sto tra due mondi, in nessuno sono di casa, e per tale motivo mi trovo in difficoltà. Voi artisti mi chiamate borghese, e i borghesi sono tentati d’arrestarmi… Non so quale delle due cose mi mortifichi più amaramente. I borghesi sono stupidi; ma voi adoratori della bellezza, che mi chiamate flemmatico e senza ambizioni, dovreste considerare che esiste una vocazione artistica così profonda, così determinata fin dall’inizio e per destino da non trovare ambizione più dolce e più delicata di quella per le delizie della mediocrità. Li ammiro io i tipi orgogliosi e freddi che vanno in cerca d’avventure sul sentiero della grande bellezza demoniaca e disprezzano l’uomo… ma non li invidio (…) Quanto io ho fatto non è nulla, non è molto, è pressapoco niente. Farò qualcosa di meglio, Lisaweta, è una promessa. Mentre scrivo sento il fremito del mare che arriva fino a me e chiudo gli occhi. Scruto in un mondo in embrione, appena abbozzato e spettrale, che chiede di ricevere ordine e forma, scruto dentro un brulichio d’ombre di figure umane, che mi fanno segno di ammaliarle e redimerle: alcune tragiche, alcune ridicole, e anche figure che sono l’una e l’altra cosa insieme… e a queste sono particolarmente affezionato. Ma il mio amore più profondo e più segreto è per i biondi, per quelli dagli occhi azzurri, per i felici puri, i luminosamente vivi, i fortunati, gli amabili e i mediocri. Non biasimi questo amore, Lisaweta; è buono ed è fecondo. Di desiderio è fatto, di nostalgia e d’invidia malinconica, d’un pochino di disprezzo e d’una grande beatitudine casta». (Ho riportato in lingua italiana questo passaggio intrecciando il contributo di due traduttori: Salvatore Tito Villari e Enrico Filippini).
Una “casta beatitudine” che oltre a rimarcare, a sottolineare l’interrogativo profondo e insanabile tra Arte e Vita, ci consegna al dilemma della “cosa giusta da fare” o della “cosa giusta da perseguire”, quindi al tema-discorso dell’essenza – Essenz – l’essenzialità, “l’opera come realtà operante della coscienza stessa”, tema su cui i nostri discorsi critico-teorici a volte si arenano per arrendevolezza, tema che dissimula – non foss’altro nella zona inconscia – la domanda d’obbligo per chiunque tenti l’avventura della creatività – si tratti di letteratura di teatro di cinema: come posso condurre la mia “sintesi” nell’essenziale (del mio essente), che cosa mi conduce all’essenziale, come posso far scaturire un essenziale dal mio progetto, come fare in modo che il mio atto creativo raggiunga l’essenziarsi – considerando che “l’essenziarsi” sta qui per il dispiegarsi dell’essere?
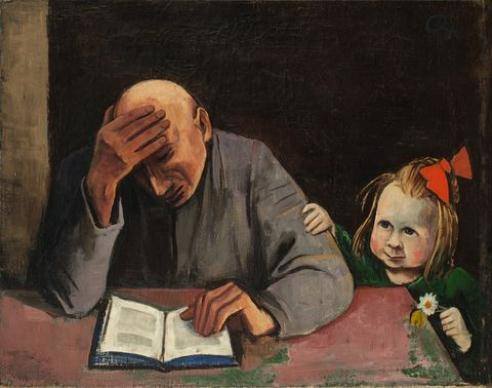
Siamo così rientrati nel territorio e nella lingua di Heidegger, dove probabilmente il gesto di Mann equivarrebbe alla prospettiva del Wesen e del Wesung, dell’essenza o dell’essenziarsi di un pensiero di scrittura, il farsi essenza, che poi, con uno spostamento, un déplacement non privo di vertigine, avvicinerebbe il temine essenza alla parola verità, allungando così una sequenza di significati che culmina nello statuto di essenza come “atrio” – atrium – dell’essere, che come ci spiega Franςois Fédier in latino indica il cuore di una “dimora”, così nella lingua francese la locuzione “savoir les êtres”, applicata ad una casa o a una villa, significa conoscere la disposizione interna di certi luoghi, conoscerla fino a “entrer dans une telle familiarité avec elle qu’au sein de ces lieux dont on sait les êtres, on finit soi-meme par ‘y-etre’, c’est-à-dire gagner sue eux une vue d’ensemble comprenant jusqu’aux relations qui se tissent entre les lieux et la manière dont il sont habités”. Una “costellazione” di significati e di appartenenze – riferita alla parola Essenza-Essence-Wesen – che a noi rimarca, ove ve ne fosse ancora bisogno, che la creazione non è “intuizione”, non è “idea” o “idea forte”, ma è un concetto fondativo che non possiamo che cercare e invocare ogni volta che ci disponiamo a quella necessità.
Nella conferenza L’origine dell’opera d’arte, tenuta il 13 novembre 1935 e ripetuta l’anno seguente a Zurigo su invito degli studenti dell’Università, Heidegger espone due argomenti: L’opera e la verità e La verità e l’arte, affrontando la domanda: Che cosa è verità e in che modo può accadere verità? Scrive Heidegger: «Attraverso il tempio, il Dio presenzia nel tempio. Questo presenziare del Dio è entro sé la distensione e delimitazione del recinto come spazio sacro. Ma il tempio e il suo recinto non si librano nell’indeterminato. L’opera-tempio è ciò che innanzitutto compagina e, insieme, raccoglie attorno a sé l’unità di quelle rotte e relazioni in cui nascita e morte, sciagura e benedizione, vittoria e sconfitta, perseveranza e rovina, procurano all’essere umano la figura del suo destino».
E nella parte finale, muovendo verso le conclusioni, il filosofo ribadisce alcuni argomenti: «In Occidente l’arte è accaduta per la prima volta nella Grecità. Allora è stato messo in opera, in maniera paradigmatica, ciò che da lì in poi vuol dire “essere”. L’essente nella sua interezza, così inauguralmente aperto, è stato poi tramutato nell’essente nel senso di creatura di Dio. Ciò è accaduto nel Medioevo. Questo essente è stato a sua volta tramutato all’inizio e nel corso dell’Età moderna. L’essente è divenuto l’oggetto dominabile e interamente perscrutabile mediante calcoli. Ogni volta ha fatto irruzione un mondo nuovo ed essenziale. Ogni volta l’apertità dell’essente è dovuta essere diretta e instaurata nell’essente stesso mediante la fissazione – impostazione – della verità nella postura della figura. Ogni volta è accaduta l’inascosità dell’essente. L’inascosità si mette in opera, l’arte conduce a compimento questo mettere».
Concetti che andrebbero proiettati e riproiettati più volte, estraendo da ogni parola la densità che a loro “compete” (e la traduzione accurata di Vincenzo Cicero, per l’edizione Bompiani del 2002, ne rinvigorisce la tensione ermeneutica). I concetti-chiave sono: apertità dell’essente; fiss(impost)azione della verità nella postura della figura; inascosità dell’essente. (“La verità è l’inascosità dell’essente in quanto essente. La verità è la verità dell’Essere”). Dove i concetti di “inascosità” o “inascoso” indicano ciò che esce dal nascondimento e la cui messa in opera, la cui determinazione, consentirebbero all’arte di raggiungere il compimento. (In una posteriore “Aggiunta”, Heidegger chiarirà che “impostare e fissare la verità non può in alcun modo essere in contrasto con il lasciar accadere”, dove il “lasciare” non è una passività ma un supremo agire, un “operare” e “volere”, «l’estatico lasciarsi immettere dell’uomo esistente entro l’inascosità dell’Essere»).
Continuiamo a leggere: «Sempre, quando accade arte – ossia quando un principio è – nella storia avviene un urto: principia storia, o principia di nuovo. “Storia” non indica qui la serie temporale di dati avvenimenti più o meno importanti (…) L’arte è il mettere in opera della verità. In questa proposizione si nasconde una equivocità essenziata, in base alla quale la verità è a un tempo il soggetto e l’oggetto del mettere. Ma soggetto e oggetto sono qui nomi inadeguati. Essi impediscono di pensare questa essenza equivoca. L’arte è storica ed è, in quanto storica, il creante verecondimento della verità nell’opera. L’arte accade come poesia. La poesia è istituzione nel triplice senso di donazione, fondazione e principio. L’arte è, in quanto istituzione, essenzialmente storica. Ciò non significa soltanto: l’arte ha una storia nel senso estrinseco secondo cui essa, con il mutare dei tempi, fa la sua comparsa, si trasforma e perisce insieme a molte altre cose, offrendo così mutevoli aspetti alla storiografia. L’arte è storia nel senso essenziale che: essa fonda storia (…) L’origine dell’opera d’arte – cioè, a un tempo, dei creanti e dei verecondenti (il che vuol dire: l’origine dell’Esserci storico di un popolo) – è l’arte. E questo poiché l’arte, nella sua essenza, è una origine: una modalità eminente in cui verità diviene essente, cioè storica».
E ancora: «Fin quasi dallo stesso periodo in cui ha inizio una considerazione esplicita dell’arte e degli artisti, questo modo di considerare viene chiamato estetico. L’estetica prende l’opera d’arte come un oggetto, e precisamente come l’oggetto del percepire sensibile in senso lato. Oggi questo percepire viene chiamato: vivere esperienze. A fornire ragguagli sull’essenza dell’arte dev’essere il modo in cui l’uomo vive l’esperienza dell’arte. L’esperienza vissuta è la fonte paradigmatica non solo per il godimento artistico, ma anche per la creazione artistica. Tutto è esperienza vissuta. Forse, però, l’esperienza vissuta è l’elemento in cui l’arte muore. Questo morire procede così lentamente da aver bisogno di alcuni secoli».(Da notare che nella edizione del 1960, uscita presso l’editore Reclam, compare un’annotazione che così conclude: «Ma quello che più di ogni altra cosa importa è che dal vivere esperienze si giunga nell’Esser-ci, e questo vuol dire: raggiungere un “elemento” totalmente diverso per il “divenire” dell’arte»).
Si parla dell’arte come un valore eterno, ma: «Se ne parla in quel linguaggio che in tutte le cose essenziali non parla con rigore, giacché teme che parlare con rigore significhi, in fine: pensare. Quale angoscia è oggi maggiore di quella davanti al pensare? Il parlare di opere immortali e di valore eterno dell’arte ha un tenore e una consistenza? Oppure questi sono ormai modi di dire pensati solo a metà, propri di un tempo in cui la grande arte, insieme alla sua essenza, si è ritirata dall’uomo?».
Considerazioni che impressionano per la lungimiranza della prospettiva e per come si riverberano nell’Oggi, il respiro profetico che le ravviva, a partire dalla nozione di “esperienza” (Forse l’esperienza vissuta è l’elemento in cui l’arte muore) che nella significazione di Heidegger mette in gioco, chiama in causa il nostro criterio “moderno” di porci dinanzi all’opera di creazione (svelando spesso l’inanità, la pochezza, l’insufficienza di ciò che abbiamo messo in campo…).
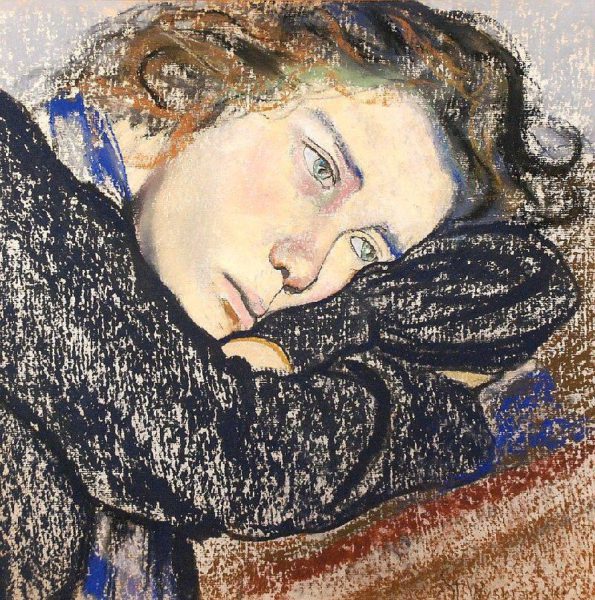
Per proseguire al meglio lungo tale corrente di studio e di elaborazione, occorre abbordare un Corso di Lezioni che Heidegger tenne presso l’Università di Friburgo, in Brisgovia, nel semestre invernale ‘51-52, con il titolo Che cosa significa pensare. Inizia con questo postulato: «Può darsi che l’uomo voglia pensare, ma non ne sia in grado (…) L’uomo è in grado di pensare nella misura in cui ne ha la possibilità (Möglichkeit). Solo che questa possibilità non ci garantisce ancora che noi ne siamo capaci (…) Per essere capaci del pensiero, dobbiamo impararlo. Che cosa significa imparare? L’uomo impara nella misura in cui porta il suo fare e non fare a corrispondere a ciò che di volta in volta gli viene detto di essenziale. Il pensiero lo impariamo prestando attenzione a ciò che è da considerare (…) Chiameremo d’ora in poi quel che sempre rimane da considerare: das Bedenklichste, il più considerevole. Che cos’è il più considerevole? Come si misura nella nostra epoca preoccupante (bedenkliche)? Il più considerevole è che noi ancora non pensiamo; continuiamo ancora a non pensare, benché la situazione del mondo diventi sempre più preoccupante».
Il non-pensiero, il “non pensare”, di cui Heidegger vuole qui tracciare la definizione-guida, non è imparentabile con la dedizione, l’intensità o lo sforzo con cui tentiamo sovente di considerare le cose del nostro agire quotidiano; nemmeno è la negligenza, facilmente superabile. Che cos’è allora? «Che noi ancora non pensiamo in nessun modo è dovuto soltanto al fatto che l’uomo non si dedichi ancora in misura sufficiente a ciò che per natura richiederebbe di essere preso in considerazione, perché esso resta nella sua essenza ciò che va pensato. Che noi ancora non pensiamo deriva piuttosto dal fatto che quello stesso che va pensato si distoglie dall’uomo, già da lungo tempo si è distolto».
Quindi: l’uomo ancora non pensa, e non pensa perché “ciò che va pensato si allontana da lui”, “ciò che va pensato si distoglie dall’uomo, gli si sottrae”. Ma: «Com’è mai possibile venir a sapere qualcosa che da sempre si sottrae o anche solo dargli un nome? Ciò che si sottrae rifiuta la sua venuta (Aunkunft). Ma il sottrarsi non è un semplice niente. Esso è evento (Ereignis)». Se capiamo bene, leggendo altri passaggi negli interstizi del Testo, il più considerevole si distoglie da noi, anzi si è distolto dall’uomo sin dall’inizio. Tuttavia, “ciò che in tal modo si sottrae, mantiene e dispiega la propria impareggiabile vicinanza”. Che vorrebbe dire essere/rimanere vicini incessantemente a ciò che si sottrae, a ciò che si è distolto da noi in un remoto inizio: rimanere “in marcia verso di esso, diretti verso le enigmatiche e quindi mutevoli vicinanze del suo richiamo”.
«Socrate durante la vita e fino alla morte, non ha fatto altro che porsi nella direzione di questa marcia e mantenersi in essa. Per questa ragione è il più puro dei pensatori dell’Occidente, quello che non ha scritto nulla. Giacché chi comincia a scrivere a partire dal pensiero, deve inevitabilmente essere simile a quegli uomini che trovano rifugio dal vento nel vento stesso». E poche righe dopo: «Quando l’uomo è in marcia verso ciò che si sottrae, egli indica la direzione verso ciò che si sottrae. In questa marcia noi siamo un segno. Ma nel contempo indichiamo qualcosa che non è tradotto nella lingua che noi parliamo, che non lo è ancora. Rimane privo di interpretazione. Siamo un segno che nulla indica. Hölderlin dice nel frammento di un inno intitolato con il nome Mnemosyne (Memoria): Un segno noi siamo, che nulla indica / Senza dolore, e quasi / Abbiamo dimenticato la lingua in terra straniera».
Tanti barlumi di scienza del dire, di conoscenza, il percorso tortuoso e meraviglioso di una lingua, un linguaggio, che si modella e si trasforma, lasciandoci nel fondo dell’orizzonte con quel monito “insopportabile”: Un segno noi siamo, che nulla indica! Verrebbe da dire che soltanto alla grande, grandissima letteratura è dato di rimanere in ascolto e in assonanza con siffatti cammini di trasformazione. E Thomas Mann e Beckett paiono modelli esemplari: quel “pensiero più considerevole” sembrerebbe accordato con la genesi del loro “pensare e poetare”, per usare ancora una formula heideggeriana.
Continuando a leggere: nella Lezione Terza Heidegger affronta il nodo del “tempo preoccupante” (aveva detto: Continuiamo ancora a non pensare, benché la situazione del mondo diventi sempre più preoccupante…), e prosegue: «Un’asserzione che parla di un tempo preoccupante, anzi di ciò che in esso è da tenere nella massima considerazione, è già sin dall’inizio determinata da un tono negativo. Essa tiene conto soltanto dei tratti avversi ed oscuri dell’epoca. Essa si rivolge alle apparenze infime, quelle che traggono spunto dal negativo, le apparenze nichilistiche. Essa cerca il loro nucleo costitutivo necessariamente in una carenza; secondo la nostra frase, nel fatto che manca il pensiero. È sufficientemente nota la diffusione di questo tono quando si giudica la nostra epoca. La generazione precedente parlava di “tramonto dell’Occidente”. Oggi si parla di “perdita del centro”. Ovunque si insegue e si immagina la decadenza, la distruzione, il minaccioso annullamento del mondo. Ovunque è nato un genere particolare di romanzo che solo in tale regressione e decadenza trova i suoi materiali (…) Non solo si scopre che il mondo sarebbe privo di connessione, ma anche che esso starebbe rotolando verso il nulla dell’assurdo. Nietzsche, lontano da tutto ciò e guardando le cose da un punto di vista superiore, già negli anni Ottanta del secolo scorso, dice queste semplici parole, semplici perché pensate: “Il deserto cresce”. Il che vuol dire: l’inaridimento è in espansione. L’inaridimento non è la distruzione. L’inaridimento è più inquietante della distruzione (…) L’inaridimento è l’eliminazione di Mnemosyne, eliminazione che si sta svolgendo a pieno ritmo. La sentenza “il deserto cresce” non proviene dagli stessi luoghi da cui provengono le correnti condanne della nostra epoca. Nietzsche diceva “il deserto cresce” quasi settant’anni fa. Egli aggiunge: Guai a colui che favorisce (birgt) i deserti!».
Se esiste una forma testamentaria della décadence, da declinare in parallelo con il ritratto dell’artista-borghese che esibisce la “frattura, la separazione di pubblico e cenacolo, isolando da una parte il gregge o la mandria elettorale del pubblico dei filistei e dall’altra il cenacolo o la conventicola degli esteti e degli iniziati” (G. Baioni), è Thomas Mann che l’ha dispiegata, raggiungendo l’apice nella maestosa “scommessa” dell’anno ’47 – il romanzo Doctor Faustus – l’opera-congedo, lungo la quale i parametri dell’arte critica pervengono al più alto stadio di elaborazione e perfezionamento. Se per Heidegger Nietzsche è colui che porta a compimento la metafisica d’Occidente, Mann diventa a tutti gli effetti colui che conduce a soluzione la “dottrina” di décadence dentro cui l’Occidente ha avviluppato il proprio destino. E Heidegger avrebbe potuto a buon diritto dedicare a Mann la consistenza dell’espressione che riconobbe a Hölderlin poeta: «Il detto della poesia e il detto del pensiero non sono mai uguali; a volte però sono la stessa cosa, quando cioè l’abisso che separa poesia e pensiero si spalanca in tutta la sua chiarezza e decisione. Il che può accadere se la poesia è alta e il pensiero è profondo».
Nel leggendario Capitolo Sesto de La montagna magica, dove Hans Castorp si inerpica con gli sci in alta montagna, disponendosi a fronteggiare una tempesta di neve che si tramuta nella perdita del sé, nell’ansimo della Morte che si avvicina per ghermirlo… si compie quel sogno-incubo dove si trovano mescolate scene primitive e arcadiche con atroci banchetti di sangue, offerte sacrificali di straziante coartazione dentro un Tempio dell’orrore, mentre all’esterno nascono immagini di un’umanità fiorente, posseduta da una estatica rigenerazione… una trama notturna ed enigmatica che, sebbene Mann non lo abbia mai spiegato, somiglia al baluginio del nuovo mondo che si affaccia in Dostoevskij nel racconto Il Sogno di un uomo ridicolo (1877) e che prima ancora era stato de La tempesta di Shakespeare… ebbene, in questa sezione intitolata Neve il Lettore si trova messo di fronte a queste parole, che preferisco porgere nelle due versioni/traduzioni fino ad oggi tentate, iniziando da Bice Giachetti-Sorteni:
«Morte o vita, malattia, salute, spirito e natura. Sono queste forse antitesi? Io domando: sono questioni queste? No, non lo sono, e non è neppure una questione quella della loro signorilità. La morte compie le sue marachelle nel campo della vita; non vi sarebbe vita senza di esse e nel mezzo, tra i capricci della morte e la ragione, sta la condizione morale dell’homo Dei, come la sua condizione sociale sta fra la comunità mistica e l’individualismo infido, Lo vedo io, qui, dalla mia colonna. In questa condizione la creatura deve avere con se stessa rapporti finemente cortesi ed affettuosamente rispettosi, perché essa soltanto è signorile, mentre le antitesi non lo sono. L’uomo è il signore delle antitesi, esse esistono per mezzo suo, egli è quindi più signorile di loro. Più signorile della morte, troppo signorile per essa, questa è la libertà della sua intelligenza. Più signorile della vita, troppo signorile per essa, questa è la pietà del suo cuore».
Seconda versione, Renata Colorni:
«Morte o vita… malattia, salute… spirito e natura. Sono antitesi queste? Mi domando: sono problemi questi? No, non sono problemi, e anche la questione della loro nobiltà non è una questione. La diserzione della morte è nella vita, non ci sarebbe vita senza di essa, e in mezzo si pone la condizione dell’Homo Dei – nel mezzo fra diserzione e ragione – e pure il suo stato si trova tra la comunità mistica e la più futile individualità. Questo vedo io dalla mia colonna. E in questa condizione l’Homo Dei deve avere con se stesso un rapporto fine, galante e affabilmente ossequioso… poiché lui solo è nobile, non le antitesi. L’uomo è signore delle antitesi, queste esistono grazie a lui, e dunque è più nobile di loro. Più nobile della morte, troppo nobile per essa… è questa la libertà della sua mente. Più nobile della vita, troppo nobile per essa… è questa la devozione del suo cuore».

La scrittura come esperienza-essenza della problematicità, azione intellettuale e concettuale che si nutre della scepsi culturale sedimentata e acquisita, che quindi “spiattella” senza più inibizioni il decalogo di ciò che l’arte “è”, di ciò che consente, delle “condizioni” attraverso le quali è consentito agirla… insomma, per dirla con Adorno, che di Thomas Mann fu mèntore e consigliere privilegiato per la scrittura del Doctor Faustus, concepire l’arte come “esperienza di qualcosa che lo spirito non avrebbe in anticipo né dal mondo né da se stesso”.
Ecco perché proprio oggi, nei nostri giorni, nel nostro presente, il miglior precetto da seguire consiste nel non temere e non scansare la “paura” che la frequentazione sistematica del fenomeno Thomas Mann assicura a chiunque osi affrontarlo, “la natura eccezionale, forse mostruosa, di questo immenso scrittore”, come sussurrava con sgomento lo studioso Franco Rella in un libro del 2012: quella “paura”, quella “mostruosità”, occorre, per sublime paradosso, farle nostre, suscitarle come voci intime e propedeutiche al lavoro che ci attende, sentirle vibrare nel fondo della nostra storicizzata coscienza di lettori.
Oggi, qualora ci trovassimo a ripercorrere nei panni di novelli Hans Castorp il viaggio in ascesa verso il Sanatorio di Davos, non porteremmo con noi il libro sugli Oceani, Ocean Steamships, che tra l’altro il vero Castorp abbandona “negletto sul sedile“, sfogliandolo svogliatamente, ma quella Lettera sull’Umanismo di Martin Heidegger, che il filosofo indirizzò nell’autunno del ’46 allo studioso francese Jean Beaufret, dove è scritto che “Existentia resta il nome che si dà alla realizzazione di ciò che una cosa è quando appare nella sua idea“.
Proprio Adorno, in Dialettica negativa, nel ’66, dipingeva la condizione della viandanza intellettuale con queste parole: “L’ente non c’è immediatamente ma solo in quanto è passato attraverso il concetto. Si dovrebbe iniziare dal concetto non dalla mera datità”. E Giacomo Debenedetti, quindici anni prima, nello scritto Confronto col diavolo, invocava a proposito del Faustus e della Recherche proustiana una letteratura che esibisse la “leggenda delle idee in forma di romanzo”, riconoscendo “la deplorevole e positiva fecondità spirituale della malattia e della morte”. Del resto, la convinzione finale pronunciata da Adrian Leverkühn un momento prima che la pazzia lo sommerga, è tracciata in tre righe: «Questa è l’epoca in cui non è più possibile compiere un’opera per vie normali, nei limiti della pietà e del raziocinio, e l’arte è divenuta impossibile senza il sussidio del Demonio e il fuoco infernale sotto il paiolo».
Anche Thomas Mann, al pari del suo Personaggio, affiderebbe a parole siffatte la sua ricerca? Sì, se il “diavolo” prendesse in carico la frattura tra il mondo storico e “il mondo delle immagini dominabili coi mezzi espressivi“. «Un divorzio ormai irreparabile tra la matrice inconscia collegata col senso delle cose, e gli strumenti consapevoli con cui è dato di manifestarsi. L’intelligenza, il mondo della cultura, hanno ormai preso atto di un deperire del linguaggio di ieri: sfruttarlo ancora sarebbe tale ingenuità che, dopo quel verdetto dell’intelligenza, più propriamente dovrebbe chiamarsi malafede. L’artista allora si costruisce linguaggi nuovi; ma questi gli paiono, a loro volta, prodotti di intelligenza; e l’intelligenza per lui, ancora romantico, non basta a garantire la poesia, è essa stessa malafede».
Inesorabile profezia dei nostri anni, diremmo noi, senza troppe sottigliezze. Anche perché se il grado di elaborazione della materia letteraria – e musicale in questo caso – è di livello così alto, trattandosi di Thomas Mann, il Lettore-Osservatore non può che tollerare il trabocchetto dei mille “inganni”, dei mille sentieri “devianti” dentro cui lo scrittore lo conduce, nel perenne libero gioco di simulazioni e dissimulazioni (a partire dal Personaggio che parla in prima persona e che si preannuncia a tutti gli effetti come l’amico e biografo ufficiale di Adrian: quel Serenus Zeitblom che, come dimostrato nello squisito esercizio critico di Luca Crescenzi è, in verità, un solenne impostore) . Per il Faustus, come ha dimostrato la critica più accorta degli ultimi decenni, le occasioni di déplacement sono davvero soverchianti, visto che in ballo c’è niente meno che “la modificazione genetica del concetto di arte” (G. Manzoni), l’essenza-sopravvivenza di ciò che chiamiamo “arte”, sulla scia delle parole di Heidegger citate precedentemente: “un tempo in cui la grande arte, insieme alla sua essenza, si è ritirata dall’uomo“.
Da tale prospettiva diventa pressoché legittimo intrecciare e intersecare alcuni passaggi cruciali del romanzo, sì da raggiungere con occhi guardinghi il fatale Capitolo XXV – il Colloquio di Adrian Leverkühn con il Diavolo Sammael – tentando finanche una nuova prospettiva di lettura per quella incredibile “trama”. Che si nutre soprattutto del decalogo delle tre M Malattia Musica Morte, a partire da quel motivo che rivela, ove ce ne fosse bisogno, che il Diavolo Sammael e Thomas Mann costituiscono la medesima unità pensante: «Le proibitive difficoltà dell’opera sono profondamente annidate nell’opera stessa. Il movimento storico del materiale musicale si è rivoltato contro l’opera in sé conchiusa. Il materiale si contrae nel tempo e rifiuta la distensione nel tempo – che è lo spazio dell’opera musicale – lasciandolo vuoto. Ma non per impotenza, non per incapacità di costruzione formale. Bensì per lo spietato imperativo della densità, che proibisce il superfluo, nega la frase, demolisce l’ordinamento e si rivolge contro l’estensione temporale che è la forma vitale dell’opera. Opera, tempo e apparenza sono una cosa sola e insieme soggiacciono alla critica. Quest’ultima non tollera più né apparenza né gioco, e neppure tollera la finzione, l’autonoma sovranità della forma che censura, suddivide in ruoli e traduce in immagini le passioni e il dolore dell’uomo. La sola cosa ancora ammissibile è l’espressione autentica e non manierata, l’espressione naturale e non trasfigurata del dolore nel suo momento reale. L’impotenza e la miseria di questo dolore sono cresciute al punto che non è più possibile alcun gioco con la sua apparenza». (La traduzione/versione dei passi citati del romanzo Doctor Faustus appartiene a Luca Crescenzi).
Dunque, ripercorriamo i concetti: lo spietato imperativo della densità, la proibizione del superfluo, la critica che non tollera più né apparenza né gioco, e non tollera neppure la finzione, perché si rivela “deviante” e traduce in immagini le passioni e il dolore… per cui la sola cosa ancora ammissibile rimane l’espressione autentica e non manierata: insomma, pare già rivolto a noi, tale decalogo di precetti, a noi che siamo bombardati da immagini – lo straziante manierismo delle “immagini” – noi che non facciamo che “scaricare” immagini nel display del telefono cellulare o sullo schermo del personal computer.
E più avanti: «Tu mi vedi e dunque, per te, esisto. Vale la pena chiedersi se esisto per davvero? Non è forse vero ciò che sortisce un effetto, e non sono verità l’esperienza e il sentimento? Per tutti i diavoli, ciò che ti innalza, ciò che accresce il tuo senso di forza, di potenza e di supremazia, quello è la verità, fosse anche dieci volte menzogna se vista dalla prospettiva della virtù. Voglio dire che una non verità capace di accrescere la forza tiene testa a qualsiasi verità inutilmente virtuosa. E voglio dire, ancora, che la malattia creatrice, dispensatrice di genio – la malattia che, alta in sella, supera gli ostacoli e, colma di audace ebbrezza, salta di roccia in roccia – è mille volte più cara alla vita della salute che ciabatta in pantofole. Non ho mai sentito nulla di più stupido del detto secondo cui dal malato non possono che venire cose malate. La vita non è schizzinosa e della morale non sa un accidente. Afferra l’audace prodotto della malattia, lo divora, lo digerisce e se infine lo assimila, quello diventa salute. Dinanzi al dato di fatto costituito dall’efficacia per la vita, mio buon amico, qualsiasi distinzione fra salute e malattia scompare».
La malattia creatrice, la malattia dispensatrice di genio… Qui viene voglia di chiamare in soccorso Ferruccio Masini, l’intellettuale italiano che ha lungamente studiato le Avanguardie del ‘900, oltre che fornire un contributo decisivo alla conoscenza dell’opera di Nietzsche. Se Adrian Leverkühn è sotto molti aspetti un calco-epigono del filosofo di Ecce Homo, condividendo in senso pieno la dannazione biografica e l’istinto all’auto-superamento, Masini non poteva che privilegiare il lato profondo della suggestione, individuando nella figura del Compositore la comparsa di un mito moderno… “che sotto nomi diversi avrà lunga vita nelle avanguardie di questo secolo: quello della strumentazione intellettuale della malattia, dello sfruttamento spregiudicatamente temerario delle virtualità dialettiche della decadenza”. Una malattia che ha come nutrimento sostanziale il “pessimismo della forza” e il nichilismo attivo, nonché l’intellettuale inclinazione al problematico dell’esistenza: «La malattia, dunque, è quel ‘negativo’ che rende possibile il ribaltamento dello stato sano, normale, inchiodato alla necessità di non potere mai essere diversi da quel che si è, paralizzati, in definitiva, dall’obbedienza all’autorità (la condizione servile del cammello “che porta tutti i pesi”). Un ribaltamento nello stato precario, instabile, fluido, inevitabilmente problematico delle possibilità, dove appunto il progetto dell’esperimentare si dà come possibilità di vivere ‘per’ le possibilità, per quell’infinita avventura dell’esperire in cui si colloca la vicissitudine prometeica dell’uomo della conoscenza».
Parrebbe di intendere che per ascendere alla vetta dell’Arte ci sia bisogno di un “drastico cambio di funzione”: esaltare il gesto che sperimenta, celebrare il ‘negativo’ come principio di un “nuovo infinito” di possibilità, soprattutto escludendo… «il pericolo che lo spirito si perda e per così dire si innamori delle sue stesse vie e resti fisso, inebriato in un punto qualsiasi». La grande perfidia del Diavolo mostra qui la sua autorevolezza. Forse il primo ad aver sperimentato il terrore di “restare fisso e inebriato in un punto qualsiasi” è proprio Thomas Mann. Potremmo ipotizzare che se il Diavolo fosse al suo servizio, avrebbe con molte probabilità consigliato all’autore de I Buddenbrook di divorziare dalle figure affettivamente – morbosamente – prossime alla sua ispirazione: in primis Hanno Buddenbrook e poi a seguire Tonio Kröger e Gustav von Aschenbach.
Se in un sussulto di orgoglio “infernale”, Sammael può rammentare al compositore Leverkühn che “il Diavolo capirà pur qualcosa di musica“, a Thomas Mann un inquieto spiritello provvisto di sagacia letteraria avrà probabilmente confidato che quel meraviglioso affresco di decadenza/décadence – in virtù del quale aveva allevato e stregato una moltitudine di Lettori – poteva aver ormai esaurito la “centralità”, non trovarsi più nelle condizioni storico-estetiche di fronteggiare la tempesta del “moderno”, il cosiddetto “spirito del tempo”. E che quindi quelle fascinose figure, foderate di tormentata, precaria e contemplativa coscienza di Sé, sarebbero state costrette ad abdicare e a riconoscere la propria inammissibilità.
Il Diavolo, da canto suo, è bene addestrato a prevenire gli interrogativi o i grandi dubbi su cui la musica di Adrian, e di conseguenza il “patto”, rischierebbero di arenarsi: «Se la creazione non tollera più l’autenticità, com’è possibile lavorare? Tuttavia le cose stanno proprio così, amico mio, il capolavoro, l’immagine compiuta in se stessa, appartiene all’arte tradizionale, mentre l’arte emancipata la rinnega. Tutto nasce dal fatto che a voi non è dato assolutamente il diritto di disporre dell’insieme di combinazioni sonore utilizzate in passato. Impossibile l’accordo di settima diminuita, impossibile certe note di passaggio cromatiche (…) Tutto dipende dall’orizzonte tecnico. L’accordo di settima diminuita è giusto e pieno di espressione all’inizio dell’op. 111. Corrisponde al livello tecnico generale di Beethoven – non è vero? -, alla tensione tra l’estrema dissonanza a lui possibile e la consonanza. Il principio della tonalità e la sua concezione dinamica conferiscono all’accordo il suo peso specifico. Tale peso, però, esso l’ha perduto nel corso di un processo storico che nessuno può invertire. Ascolta quell’accordo estinto: persino nella sua erraticità esso rappresenta una situazione tecnica generale in contraddizione con quella reale.»
Cosa possa determinare – di rivoluzionario e di idealizzante – “l’orizzonte tecnico”, e come si rivitalizza un accordo “estinto” ma “errante” o vagabondo, come l’accordo di settima diminuita della Sonata in do minore di Beethoven – una Sonata in due movimenti che promette ancora oggi ai musicologi, ai compositori, soprattutto agli interpreti, l’enigma del terzo tempo mancante – Mann lo ha messo in luce nel capitolo XXII, in un colloquio tra Adrian e l’amico Zeitblom, dove entrano in diretto confronto e risonanza la “soggettività” dell’artista con i vincoli “oggettivi” che essa – paradossalmente – si impone per sfuggire alla sterilità, alla minaccia di paralisi, al blocco della produttività: «Sarebbe tragico – esclama Zeitblom – se dalla libertà dovesse derivare l’infecondità. La libertà si conquista sempre nella speranza di generare energie produttive!»
«Questo è vero – risponde Leverkuhn – E per un po’ soddisfa le aspettative che in essa riponiamo. Ma libertà è solo un altro modo per definire la soggettività che, un bel giorno, smette di sopportarsi, dispera delle proprie possibilità creative e cerca protezione e sicurezza nell’oggettività. La libertà tende sempre al capovolgimento dialettico. Molto presto si riconosce nell’obbedienza a un vincolo, nella subordinazione a una legge, a una regola, a un obbligo, a un sistema; in tutto ciò si realizza ma, con tutto ciò, non smette di essere libertà (…) Nell’arte la soggettività e l’oggettività si intrecciano fino a rendersi indistinguibili, l’una scaturisce dall’altra e ne assume il carattere, la soggettività si converte in oggettività e viene dal genio ridestata alla spontaneità o, come diciamo noi, dinamizzata».
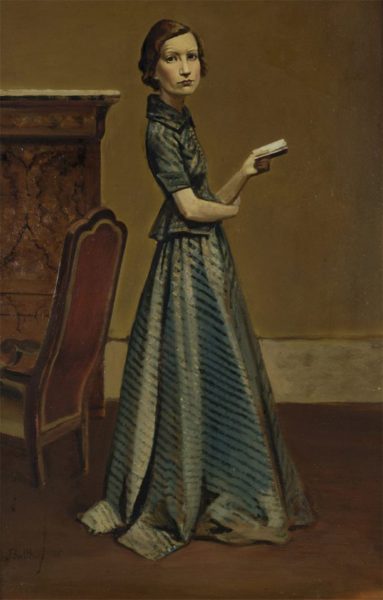
Dialoghi che alludono senza infingimenti alla piattaforma critico-programmatica lungo la quale Adrian Leverkühn svilupperà le proprie composizioni “infernali”, che culmineranno nella Cantata sinfonica Lamento Doctori Fausti, opera nella quale, prendendo a prestito le sue parole, si realizza “l’identità sostanziale della massima beatitudine col massimo orrore”. Si tratta, com’è noto, del medesimo sentiero, estetico e sonoro, lungo il quale si è inerpicato il compositore Arnold Schönberg nei primi decenni del XX Secolo e che ha condotto nel 1923 alla definizione della Dodecafonia, sistema di composizione musicale da cui Mann trarrà pressoché per intero le teorie musicali del Personaggio-Compositore. Tuttavia, il Faustus non sarebbe stato possibile senza la consulenza assidua e rigorosa di Adorno, senza la prodigiosa sintesi contenuta nel libro Filosofia della musica moderna, dedicato al sistema critico-musicale di Schönberg e Stravinskij.
Nello Scritto autobiografico Genesi del Doctor Faustus, lo scrittore racconta: «Sentivo chiaramente che per realizzare il mio scopo avevo bisogno di un aiuto dall’esterno, di un consigliere che fosse, da una parte, un istruttore informato di ciò che mi proponevo di fare con la mia opera poetica e dall’altra una persona capace di immedesimarsi nelle mie fantasie…». E prosegue: «Ero tanto più disposto ad accettare quell’aiuto in quanto la musica – nella misura in cui il romanzo la assume come proprio argomento – era solo un elemento evidente che stava per qualcos’altro, il paradigma di una realtà più universale, il mezzo per parlare della situazione dell’arte in generale, della civiltà, e addirittura dell’uomo e dello spirito stesso della nostra epoca, che è un’epoca critica fino al midollo».
Si è fatta spasmodica, per il “mago” Thomas Mann, l’urgenza di connettersi con lo stile “tardo” di Beethoven – lo Spätstil – la fase “ultima” che percorre le Cinque Sonate del congedo – op. 101, 106, 109, 110, 111 – dove arriva a soluzione un processo di elaborazione intellettuale che Adorno chiamerà desensibilizzazione del materiale musicale, che vuol dire “distacco”, divorzio, da un “sensibile” musicale inteso come ornamento, gioco, parodia, quindi parvenza, apparenza, oltre che resa alla convenzionalità dell’approccio artistico. Non più l’esibizione di commoventi reliquie verso cui ostentare il compiacimento del commiato ma il “gesto impetuoso” di una soggettività imparentata con la morte che “libera le masse di materia cui prima dava forma“, risolvendole “nella nuda rappresentazione di se stesse”.
Già il sapiente e balbuziente Wendell Kretzschmar, il maestro del Capitolo VIII che inconsapevolmente prepara Leverkühn al Patto con il Diavolo, aveva tenuto una Conferenza intitolata La musica e l’occhio, congetturando la musica come arte rivolta al senso della vista, “cosa che ottiene già solo perché viene scritta, per mezzo della notazione, della scrittura musicale, la quale fin dai tempi degli antichi neumi, che fissavano approssimativamente il moto sonoro per mezzo di linee e punti, era stata continuamente praticata, e con crescente attenzione“, con la conseguenza che “certi modi di dire presenti nel gergo dei musicisti non provenivano affatto dalla sfera acustica, bensì da quella visuale delle note scritte”. «Forse, disse Kretzschmar, il più profondo desiderio della musica è quello di non essere udita affatto, e neppure vista o sentita bensì, se possibile, di essere percepita e contemplata in un aldilà dei sensi e, persino, dell’anima, entro un puro dominio spirituale. Ma essendo legata ai sensi essa deve aspirare a una fortissima e, anzi, ammaliante sensualità, come una Kundry che non desideri quello che fa e cinga tuttavia con le morbide braccia del piacere la nuca del folle».
(Parentesi. Presumo che queste righe non siano passate inosservate allo sguardo del pianista-interprete Glenn Gould, che forse più volte avrà evocato, la Kundry del Parsifal, anelando la presenza del Wagner redentore… del resto, l’immagine del musicista che cinge la nuca del “fantasma-folle” potrebbe valere come illuminazione-presagio di ogni solista).
Se facciamo ritorno al quesito della “variazione” e di come nel sistema dodecafonico essa diventi “centrale”, nel senso di estendere lo sviluppo basato sulla variazione a tutta la composizione, scopriamo che il fenomeno musicale non si presenta più come un fatto di evoluzione: «Il lavoro tematico diviene un semplice lavoro preliminare del compositore, e la variazione non compare più: essa è tutto e nulla ad un tempo. Il procedimento variativo viene retrocesso nel materiale, e lo preforma prima che incominci la composizione propriamente detta. A questo allude Schönberg quando chiama la struttura dodecafonica delle sue opere mature una sua “faccenda privata”. La musica diventa il risultato dei processi a cui il materiale è stato sottoposto ma che essa non permette più di distinguere: così diviene statica».
Lavoro “preliminare” del Compositore, lavoro “pre-formato”: parrebbe di essere entrati nella zona della razionalità e del dominio assoluti, oltre che in un fantomatico regno dell’esattezza. Conviene scoprire ragguagli ulteriori: «Non si deve fraintendere la tecnica dodecafonica come una “tecnica di composizione”, quale ad esempio quella dell’impressionismo: tutti i tentativi di sfruttarla come tale conducono all’assurdo. Essa è paragonabile più ad una disposizione dei colori sulla tavolozza che ad un vero e proprio procedimento pittorico; l’azione compositiva incomincia in verità soltanto quando la disposizione dei dodici suoni è pronta. Per questo con la dodecafonia scriver musica non diventa più facile ma più difficile. Essa richiede che ogni pezzo, sia esso un tempo singolo o un intero lavoro in più tempi, venga derivato da una “figura fondamentale” o “serie”. Con questo si intende un ordinamento determinato di volta in volta dei dodici suoni disponibili nel sistema temperato, come ad esempio do diesis, la, si, sol, la bem., fa diesis, si bem., re, mi, mi bem., do, fa, che è la serie della prima composizione dodecafonica pubblicata da Schönberg. Ogni suono in tutta la composizione è determinato da questa “serie”: non esistono più note “libere”». (La composizione che Adorno porta ad esempio è il Quinto dei Cinque Studi per pianoforte, opera 23, pubblicata nell’anno ’23).

Poteva Thomas Mann, nelle vesti di Adrian Leverkühn rimanere indifferente a tale sovversione dell’ordito strutturale? Il dialogo tra il compositore e l’amico-biografo Zeitblom, desunto letteralmente dalle analisi di Adorno, aggiunge elementi di ulteriore inquietudine anziché risolverli. Dice Adrian: «Una composizione potrebbe anche utilizzare come materiale di partenza due o più serie, alla maniera delle fughe doppie e triple. Decisivo è che ogni nota, senza alcuna eccezione, abbia il suo valore posizionale nella serie o in una delle sue derivazioni. Questo garantirebbe quella che io chiamo indifferenza di armonia e melodia.»
«Un quadrato magico – replica Zeitblom -. Ma speri anche tu che tutto questo si possa udire?»
Leverkühn: «Udire? Non ricordi quella conferenza di pubblico interesse che ci venne tenuta un giorno, in cui risultò che in musica non si deve affatto udire tutto? Se quando parli di “udire” intendi che il singolo deve sentire esattamente quali mezzi vengono impiegati per conseguire l’ordine più alto e rigoroso – un ordine e una legalità astrologici e cosmici -, no, questo non sarà in grado di udirlo. Ma l’ordine in sé lo si udirà o lo si udirebbe, e la sua percezione riserverebbe un piacere estetico ancora ignoto.»
Zeitblom: «É molto strano il tuo modo di descrivere questa cosa, finisce per essere una specie di composizione antecedente alla composizione. Tutto il materiale dovrebbe già essere disposto e organizzato al momento di cominciare il lavoro vero e proprio, cosicché viene da chiedersi quale sia il lavoro vero e proprio. L’elaborazione del materiale avviene, infatti, per variazione, ma la produttività della variazione stessa, che si potrebbe definire l’autentica composizione, sarebbe rimessa al materiale – insieme alla libertà del compositore. Il quale non sarebbe più libero già nel momento in cui si mettesse all’opera.»
Leverkühn: «Sarebbe costretto da un dovere di ordine autoimposto, quindi sarebbe libero.»
Zeitblom: «Be’, la dialettica della libertà è insondabile. Ma nel dar forma all’armonia non lo si potrebbe considerare libero. La costruzione degli accordi non sarebbe affidata al caso e alla cieca fatalità?»
Leverkühn: «Di’ piuttosto: alla costellazione. La dignità polifonica di ogni nota che compone l’accordo sarebbe garantita dalla costellazione. I risultati storici, l’emancipazione della dissonanza dalla sua risoluzione, l’assolutizzarsi della dissonanza medesima quale si trova in certi passaggi del tardo Wagner, giustificherebbero qualsiasi accostamento di suoni possa essere legittimato dal sistema».
Quadrato magico, Costellazione, Ordine alto e rigoroso… L’artista-compositore cerca una formula credibile che possa sottrarlo al destino della convenzione-ripetizione dentro cui il “materiale musicale” si è inabissato. Il Diavolo lo aveva detto: l’arte emancipata rinnega il capolavoro, l’opera compiuta appartiene all’arte tradizionale, il rischio è quindi la perpetua inibizione, la paralisi, l’impotenza. A meno che… non intervenga un “Lui”, un daimon provvisto di lucidità e di pieni poteri: «Siamo d’accordo, siamo in affari – l’hai attestato col sangue promettendoti a noi e nel nostro nome battezzandoti – questa mia visita vale solo di confermazione. Acquisti da noi tempo, tempo geniale, tempo esaltante, ventaquattr’anni esatti ab dato recessi, che ti poniamo come termine ultimativo. Trascorsi e passati che siano questi anni incalcolabili – e anche se un tempo consimile s’equivale a un’eternità – verremo a prenderti. Di contro vogliamo esserti, per questo intervallo, sottomessi e obbedienti in tutto, e l’inferno t’arriderà purché tu rinunci a tutto quanto ha vita, alle schiere del cielo e alli esseri umani, poiché così dev’essere.
Io (investito da un soffio estremamente freddo): Che cosa? Questa è nuova. Che significa questa clausola?
Lui: Rinuncia, vuol dire rinuncia. Che altro dovrebbe significare? Pensi forse che la gelosia alberghi solo nelle sfere superne e non anche nell’abisso? A noi ti sei promesso, gentile creatura creata, con noi sei fidanzato. Non dovrai amare nessuno».
Ma per quanto Adrian mostri indignazione e protesti vibratamente contro il Diavolo che lo vuole privare della voluttà d’amore, in cuor suo sa bene che l’unica forma d’amore che gli appartiene, di cui è “affidatario”, di cui è provvisto storicamente e culturalmente, è l’arte, intesa come arte critica: l’arte che per rimediare alla perdita di totalità narra se stessa, mette in musica se stessa, esibendo il proprio destino, finanche accogliendo come idea regolativa la possibilità che si riveli un’arte “prescritta”, imprigionata nella camicia di forza di un “sistema”… come la dodecafonia.
Di certo, Thomas Mann, Heidegger, Beckett, in ultimo Leverkühn, conoscevano a menadito le sublimi paraboli-allegorie di Zarathustra, soprattutto quella che dona estaticità al poeta veggente: «Io passo in mezzo agli uomini come in mezzo a frammenti dell’avvenire: di quell’avvenire che io contemplo. E il senso di tutto il mio operare è che io immagini come un poeta e ricomponga in uno ciò che è frammento ed enigma e orrida casualità…». La lezione dei Maestri non si arresta: l’arte critica lavora con metodo.
(Ottobre 2018)
