Dobbiamo affrettarci a raccogliere il pretesto della cifra-anniversario che riguarda Roberto de Monticelli – 30 anni dalla morte – se non altro per riconoscere, ancor meglio ancor di più, i meandri-labirinti di una machine critique culturale e teatrale, che lungi dall’apparire esangue o desueta, o ancor meno fuori scena del nostro Oggi, occhieggia sorniona e lungimirante, con quel misto di caparbietà e di sontuosa eleganza che l’ha sempre distinta, per rammentarci che non abbiamo ancora svolto fino in fondo i compiti che ci ha trasmesso e perciò reclama di essere ri-percorsa per intero.

Dove “per intero” arriva a comprendere i molteplici piani, le molteplici stagioni del suo tormento di scrittore: dall’ansia del critico “ufficiale”, costretto a presiedere le sedute notturne della scena teatrale milanese per i lettori del giorno dopo – La Patria, Epoca, Il Giorno, il Corriere della Sera – allo stratega implacabile che predispone le armi segrete di una scena critica senza la quale oggi non comprenderemmo ascese cadute trionfi e débacles di registi e attori che per alcuni nostri indimenticabili anni hanno costituito mito generazionale.
A cui va aggiunto, come elemento problematico e distintivo, il romanzo di formazione, L’educazione teatrale, uscito nell’86, da considerare il libro assiduamente incompiuto, l’opera interminabile che De Monticelli accudisce con lena minuziosa, modellando ogni dettaglio, nella convinzione che sostenere un’ambizione eccessiva – dove l’eccesso potrebbe esser dato dalla mole di rimandi e riferimenti che quell’opera presuppone – sia indispensabile alla definizione complessiva del suo portrait intellettuale.
Sicché non sorprende che nei pochi riferimenti bibliografici che si sono palesati dopo la sua morte, la tentazione fosse di privilegiare quel Titolo, offrendo l’impressione che i rivoli sparsi e differentemente organizzati della sua pratica quotidiana di scrittura trovassero ispirazione apicale proprio nel romanzo della maturità: epilogo o finale di partita pienamente “letterario”.
Ma sarebbe un faux pas e porterebbe ad allontanare dalla scena, o lasciar affiorare in posizione gregaria, il vero protagonista-mattatore dei tormenti demonticelliani: il critico della cultura, lo scrupoloso e analitico indagatore, che pur non trascurando il “mandato” ricevuto da Wilhelm Meister (“vagabondaggio e avventura, itinerario nel labirinto dell’immaginazione e apprendistato”), accudisce con metodo e pazienza, giorno dopo giorno, spettacolo dopo spettacolo, il racconto storico di oltre trenta lunghi anni, trenta lunghi “inverni”, per dirla con un titolo preso in prestito da Franco Fortini, di ossessioni sceniche.
Testi cesellati con la passione del critico militante e il disincanto dello scrittore che riflette e riconosce la “distanza” tra sé e la Scena, testi che oggi andrebbero riletti anche con l’occhio rivolto alla Cronologia, misurando e monitorando anni mesi giorni di ininterrotto dovere, facendo risuonare lo scalpello del cronista inquieto nel buio solenne della sala – il clandestino munito di penna e taccuino – proprio per comprendere come e perché, attraverso l’infinito catalogo di inesauste trame teatrali, prendesse forma e figura l’identità e la civiltà di una nazione.
«L’attore italiano non sa più come definirsi. Non è, la sua, un’angoscia nominalistica, non è più questione di parole o di formule. È proprio l’immagine di sé che gli è, paradossalmente, ignota; o che gli si è andata oscurando e confondendo, sfumando in una serie di altre possibilità, apparenze, ipotesi e funzioni, man mano che egli acquistava – sembra una contraddizione ma non lo è – una sempre maggiore consapevolezza critica del proprio lavoro e del potere che, nella società, gliene deriva».
Di questo si tratta, sostanzialmente, del ritornello che ogni generazione trasmette alla successiva: c’era una volta il Teatro, c’era una volta l’Attore, c’era una volta la Scena cosparsa di luci e di ombre, percorsa di chiasso e furore; e c’era un volta il Critico, aggiungiamo noi, il creatore-disvelatore che da questa “scena” ne modellava un’altra, ne trascinava fuori una seconda, una sorta di scena alternativa, meglio una lingua alternativa, una parola alternativa, intorno alla quale si forgiava l’inconscio collettivo di una generazione.
«La parola, creta da modellare con la voce, materia familiare, antica polta dai sapori noti e remotamente contadini (gli umori e gli unti dialettali della Commedia dell’Arte), che era così facile da rimestare e dava gusto al palato, presa a larghe cucchiaiate dense di vitalità e allegria popolari; oppure la parola colta e timbrica o quella in panni borghesi, intensamente modulata, spartita in pause e cesure rigorosamente coincidenti col nesso logico; la parola dell’italiano di teatro, un po’ posticcio, un po’ inamidato, un po’ vuotato di sangue ma affascinante all’interno del lavoro di palcoscenico, proprio per l’astrattezza e la convenzionalità, lontane dalla vita, che lo caratterizzano e ne fanno una lingua difficilissima da adoperare nella mimesi istrionica e per la quale è necessaria, appunto, una precisa tecnica vocale, una minuziosa preparazione artigianale, pratica».

Malgrado le complesse mutazioni che il teatro ha sostenuto nei decenni che De Monticelli attraversa (si comincia da L’ingranaggio di Sartre-Strehler, anno ’53, e si finisce con Esuli di Joyce-Sciaccaluga, 1987), poche volte ci si è soffermati sulla funzione del critico-autore, colui che sovrapponendo al “copione di sala” il proprio stile, la propria scrittura analitica, silenziosamente, clandestinamente, affianca o addirittura presagisce la fortuna identitaria del regista o dell’attore. Lo si comprende bene se accade di sfogliare con volontà certosina le circa 2800 pagine dei quattro Tomi che raccolgono l’opera-omnia del suo racconto critico, pubblicati nel ’98 dall’editore Bulzoni, sotto la pregevole e scrupolosa cura di Guido De Monticelli (in collaborazione con Roberta Arcelloni e Lyde Galli Martinelli), che firma anche una esaustiva introduzione (Il grimaldello della metafora): affiora, nella più luminosa interezza, il grado di contiguità, di collusione – di patto segreto – tra la lingua del teatro e i codici culturali della realtà contemporanea.
Per cui se proviamo ad allentare o scardinare il diaframma “scolastico” che si tramanda tra scena-regia e gesto interpretativo, scopriamo che al “critico” – allo scrittore Roberto De Monticelli – spetta redigere il copione in seconda battuta, portando a ricognizione le zone opache, amorfe o incompiute dell’azione scenica, i “materiali” infaticabilmente germogliati ma che l’attore e il regista hanno lasciato fuggire e disperdere, la traccia che necessariamente si distacca, si emancipa dalla trama delle previste e ripetute orchestrazioni.
Come il teatro di Anton Čechov ha sussurrato ai numerosi epigoni, si può tenere in scacco la nostalgia dietro la chiacchiera inesauribile di cui ogni attore-personaggio si provvede prima di raggiungere lo spazio della scena (e ben lo sanno i raisonneurs, i “ragionatori” che invadono il teatro di Pirandello), ma ciò che conta, ciò che resiste è quell’imponderabile quid che spetterebbe alla Scena svelare, la scia di inesplorato, inesploso, non ancora detto, rimasto impronunciato, che si cela o si specchia dietro l’apparente figurazione disposta dall’autore e che il regista-demiurgo dovrebbe riconoscere e rivelare.
È questa, allo stesso tempo, l’illusione e la scommessa di De Monticelli: generare una scrittura critica che sia racconto epico del teatro, dell’esperienza-teatro, che si inquadri nel diagramma della storia culturale del nostro tempo e si faccia “segno”, traccia di appartenenza: un racconto critico che raccoglie la complessità, l’unicità e l’unitarietà di ciò che sulla scena è diviso, parcellizzato, affidato alle “competenze”, alla “ripartizione del sensibile”, direbbe il filosofo Jacques Rancière.
Governata da una volontà potente e onnicomprensiva, la scrittura critica unifica ciò che per il regista l’attore e lo spettatore rimane occasione: da sperimentare, da collaudare, da portare a conclusione. Sicché la paura del regista e dell’attore, il giorno dopo la “prima”, è che De Monticelli scoperchiasse, evidenziasse lo iato di incompiutezza o inadeguatezza che l’epopea della scena aveva prodotto rispetto all’esigenza di stile, di complessità , di credibilità che il rifacimento – la ripetizione – dei grandi testi della tradizione necessariamente comporta.
E le regie di Giorgio Strehler, la messa in scena di Giorgio Strehler, si prestano a identificare la sottile ma precisa linea di confronto-separazione che qualifica le due esperienze. Scorrendo i testi, rischiarando il lavoro strehleriano attraverso le puntuali note del critico amico – gentile riservato silenzioso, “che serba le parole, nutrendole e maturandole nel bozzolo caldo del suo silenzio”, narra affettuosamente il figlio Guido, condotto dal papà al Teatro Lirico o al Piccolo Teatro di Milano per osservare una “prova” del grande affabulatore – affiora la tentazione di ribaltare i “ruoli”: il regista e gli attori in platea, sui divanetti, e il critico sul proscenio, magari facendolo arrivare su un vetusto montacarichi, come genialmente fece nel 1923 Georges Pitöeff, disvelando con un atto di regia ciò che Pirandello non aveva ancora trovato, ossia l’origine dei Sei Personaggi in cerca d’autore.
Immagine nemmeno troppo distante dalla serata che lunedì 8 maggio il Piccolo Teatro Grassi dedica al critico-scrittore – Il sentimento della parola. Roberto De Monticelli trent’anni dopo – per la cura del figlio Guido e di Roberta Arcelloni.
Il mio contributo per l’Anniversario si concentra su un testo del De Monticelli “giovane”, uscito su La Patria il 14 gennaio 1955 e dedicato ad una storica edizione italiana de Il giardino dei ciliegi di Anton Čechov, per la regia di Giorgio Strehler e l’interpretazione di Sarah Ferrati, Luigi Cimara, Tino Carraro, Fulvia Mammi, Valentina Fortunato, Giancarlo Sbragia, Enzo Tarascio, Pina Cei.
Ne trascrivo due passi scelti, che mettono in evidenza quanto potente fosse il “sottotesto” demonticelliano, i cui bagliori raggiungono e riguardano la situazione dei nostri anni, l’avvenire teatrale di questi ultimi decenni, durante i quali, per restare soltanto alla grande drammaturgia dello scrittore russo, riproporre il teatro di Čechov sulla scena ha significato avvolgere i protagonisti in sontuosi abiti bianchi e farli danzare nel ruolo di contraddittori: che vuol dire ancora una volta vanificare la potenza di ciò che le parole nascondono, lasciare inesplorato quel fondo oscuro e opaco di significati che nessuna dialettica di scena potrebbe mai rivelare. (“Chi sono io e che ci sto qui a fare, nessuno lo sa…”).
Forse il De Monticelli critico dell’Oggi rammenterebbe ai registi-metteurs en scène che la scommessa più alta del teatro di regia è fuggire dal luogo dove l’autore è atteso, dove lo spettatore avrebbe urgenza di “stanarlo”, per trovarsi nell’ora imprecisata in cui le creature nate sul palcoscenico – come sapeva il Pirandello degli ultimi drammi – appaiono provvisoriamente sulla Scena per ostentare lo sgomento di essere stati catapultati nel Mondo.
Se non lo fanno, varrà anche per loro quella battuta fulminante che già Thomas Mann aveva messo in risalto nel bellissimo Saggio su Čechov (1954) e che si trova nel quarto atto di Zio Vanja: il saluto di commiato che Marija Vasilievna rivolge ad Aleksandr Serebrjakov, il professore emerito che scrive d’arte ma di arte non capisce nulla: «Voi, Aleksàndr Vladimìrovìč, fatevi fare una nuova fotografia e mandatemene una copia. Voi sapete quanto mi siete caro».
A quanti registi e attori dei nostri anni De Monticelli consiglierebbe di “farsi fare una nuova fotografia”?
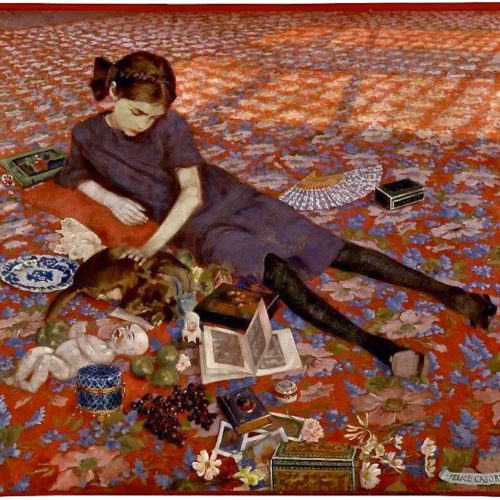
«Pensavamo, ascoltando ieri sera Il giardino dei ciliegi, all’influenza che il teatro di Čechov ha esercitato, in modo quasi inconscio, sul più sensibile e avvertito teatro d’oggi, in Europa ma soprattutto in America. Pensavamo a Thorton Wilder, a Tennessee Williams, a Saroyan. Lontana l’intenzione, naturalmente, di voler porre relazioni, stabilire derivazioni e confronti, ché l’ora è tarda e non la si finirebbe più di discutere. Sono diversi i “contenuti”, d’accordo, e poi si tratta di scrittori così remoti, con interessi e mete così distinte; ma è d’influenza di stili che si voleva parlare, d’una inconsapevole trasposizione di modi espressivi. I personaggi, che parlano per proprio conto; il mettere, fra l’uno e l’altro dramma individuale, quei diaframmi invisibili e tenaci contro i quali le parole d’ognuno vanno a battere come farfalle contro i vetri; quell’improvviso perdersi nella smemoratezza rassegnata, in una specie di malinconico e vaneggiante soliloquio; le reciproche incomprensioni che ruotano senza mai incontrarsi e fondersi, come mondi fissati al destino di un’orbita; e soprattutto, l’autoconfessione intaccata dalla reticenza, quel modo smarrito e labile e pallido di raccontarsi; tutto ciò che insomma, per comodo di critica, è stato classificato con la facile etichetta di “tecnica cechoviana” non è forse entrato a far parte della sintassi teatrale degli scrittori più moderni, attenti, più irrequieti e vivi? (…) Individualmente, gli attori sono stati tutti bravissimi; come bravissimo è stato il regista Strehler. Uno spettacolo degnissimo, inquadrato nelle belle scene di Tania Moiseiwitsch. Se c’è una riserva da fare è sul tono generale della recitazione che ci è parso un poco artificialmente grigia. Si sa che il teatro di Čechov va recitato sui piani di dissolvenza sfumati l’uno sull’altro; quell’aria disperata e chiusa ha pur da venire fuori dalla modulazione delle parole. Questo risultato tecnico si è raggiunto. Ma, a parer nostro, ha fatto difetto una certa interiorità. Lo sfilacciarsi delle battute di Čechov nell’incoerenza, nel vaneggiamento, non può esser reso soltanto con degli accorgimenti di raffinato mestiere; bisogna dare secondo noi il senso del mistero. A un certo punto delle battute di alcuni personaggi comincia la zona sconosciuta, il paese del sogno: là non esistono garanzie, cessano i sostegni della logica, non basta nemmeno la malinconia, nemmeno bastano le lacrime. Bisogna rendere il senso del mistero, passano gabbiani, corde sonore si spezzano a distanze inaccessibili, con un ronzio smemorato e sovrumano. Gli interpreti debbono letteralmente tremare di poesia; come di febbre». (Roberto De Monticelli, 1955)
(Maggio 2017)
TESTI CORRELATI:
Giorgio Strehler e Roberto De Monticelli

1 Commento. Nuovo commento
Da New York e sul punto di prendere il volo per atterrare domani in via Rovello. La sua attenzione lucida e colta , caro Rafele, quanto lo fu quella di Roberto De Monticelli prolunga una vita e rida’ voce a un pensiero che oggi ci risveglia all’essenziale. Grazie.