
Niente affatto sibillina la pretesa di presunzione d’innocenza che il Lettore di Dante afferma con perentorietà di fronte alla soverchiante, incontenibile erudizione che l’Opera esibisce senza modestia; anche tra i più esperti commentatori, la reazione somiglia allo spavento guardingo del Pellegrino di fronte alla seconda delle Tre Fiere, quella Lupa, bestia “sanza pace”, “che mai non empie la bramosa voglia, / e dopo ’l pasto ha più fame che pria”.
Un languore inesausto che pare non giungere mai a soluzione, che potrebbe forse placarsi se il Lettore, da ingenuo assimilatore o inerme compilatore di epifanie poetiche, si trasformasse in fiero “contendente”, deciso a far valere la propria porzione di “canoscenza”, fino a evidenziare, nel nome della poiesis, il necessario intreccio che si stabilisce e si irradia tra lettera e commento, per sancirne infine l’assoluta imprescindibilità.
È risultata vana o parziale, quindi, nel corso degli ultimi decenni, l’innocente esibizione degli Attori-Lettori, la messa a nudo di versi e terzine che per raggiungere l’intendimento dell’uditore-ascoltatore abbisognano del soccorso di un meticoloso corredo ermeneutico, dispiegato fin dentro le cellule minime della “littera”, facendo sì che una Lectura Dantis di alto livello – e in questi decenni non sono mancate in Italia comunità di interpreti di notevole sensibilità – si possa affermare in prima istanza come esercizio di stupore e di “maraviglia”, dove l’elemento della scoperta, del disvelamento di nodi problematici plurimi, annidati nelle pieghe e nei tornanti della scrittura dantesca, corre in parallelo con la passio della lettura modulata e variata, della vibrazione estetico-tonale che l’attore-dicitore deve saper porgere.
Cosi avviene che, in ultima analisi, sia proprio il Critico-Analista a prendere in carico la restituzione della complessità dell’approccio, accedendo per via diretta nel laboratorio-sistema di una intelligenza, quella di Dante, che si vuole suprema, consapevole della propria vocazione, eccelsa nel disporre principi e precetti, perciò mai doma di sé, mai in debolezza di manovra, mai allentante la presa: Alighieri mente presaga.
E proprio noi, abitatori di questa parte di Occidente europeo, consanguinei a Dante Alighieri per lingua, territorio e destino, se focalizziamo il connotato psico-culturale, possiamo orgogliosamente affermare di stare tracciando una ipotetica, ideale linea di continuità con i migliori interpreti che quella tradizione l’hanno iniziata già nei primi venti anni dopo la morte del demiurgo-compilatore (le Chiose di Jacopo Alighieri sono del 1322, la prima edizione del Comentarium del secondogenito Pietro Alighieri si attesta al 1340 e costituisce, a detta di Francesco Mazzoni, “uno dei momenti più alti dell’esegesi trecentesca del poema, in un perfetto equilibrio tra ragioni formali e impegno dottrinale, tra interessi letterari e ricostruzione del mondo morale e spirituale di Dante“).
Ambizione perciò di smisurata estensione che, per la fortuna di noi lettori intrepidi del caleidoscopio dantesco, non si è mai fermata, germogliando incessantemente traccia dopo traccia, aggiungendo togliendo correggendo assemblando progressivamente una critica delle varianti, che ancora oggi segna il diagramma preparatorio dei nostri esperimenti. È noto, del resto, che appena si sfiora il territorio di una accorta fenomenologia del dettato dantesco, nella prospettiva di una analisi-interpretazione, si accede ad una zona franca di difficile accordatura, si aguzza l’occhio all’interno di un “sentiero di nidi di ragno” che difficilmente se non fatalmente potrà raggiungere occasioni di comune investitura.
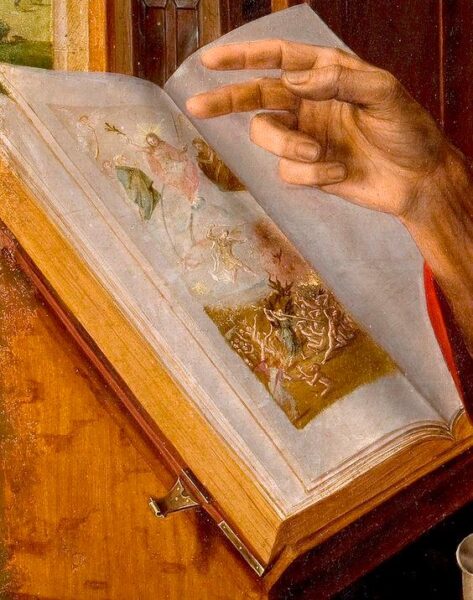
Chiunque imbastisse un catalogo di Variazioni sul tema D.A. scoprirebbe una preliminare insondabilità dell’affresco dantesco, proprio nell’accezione divinatoria che Thomas Mann proponeva a Prefazione/esergo della possente Tetralogia composta dal 1926 al 1943, Giuseppe e i suoi fratelli, il cui titolo è a noi congeniale: Discesa agli inferi – “lungo un cammino che doveva condurre spesso in valli tanto oscure” – il cui Incipit, come si ricorderà, recita queste parole: «Profondo è il pozzo del passato. O non dovremmo dirlo imperscrutabile? (…) Perché appunto in questo caso avviene che quanto più si scavi nel sotterraneo mondo del passato, quanto più profondamente si penetri e cerchi, tanto più i primordi dell’umano, della sua storia, della sua civiltà, si rivelano del tutto insondabili e, pur facendo discendere a lontananze temporali favolose lo scandaglio, via via e sempre più recedono verso abissi senza fondo».
Parole che quando sfiorai la prima volta, nella lettura adolescenziale, sfogliando l’edizione oggi vintage dei Classici Mondadori a cura di Lavinia Mazzucchetti e nella traduzione di Bruno Atzeni, mi parvero foriere di una gioiosa inarrestabile titanica immersione nelle viscere del Mito: la volontà di riportare alla luce, nella figura di Giuseppe figlio di Giacobbe – vissuto nell’Oriente babilonese ed egiziano intorno al 1400 a.C. – un poderoso sistema di relazioni antropologiche e strutturali, contestualizzate nello scrigno di un modello di letteratura critica e saggistica la cui finalità complessiva diventa l’incarnazione del Mito, ovvero – utilizzando la formula di Fabrizio Cambi nella sua Introduzione per la collana “Meridiani” dell’anno 2000 – l’attualizzarsi dell’uomo come mitologema.
Vale dunque la pena, oggi, nella prospettiva inedita che potrebbe dischiudersi, e che ha come obiettivo di raggiungere e svelare il presagio – oltre che il progetto – di una scrittura poetica che si materializza nel Mito, lo avvolge, lo trascende, immergersi nella costruzione epica dell’Opera, che di per sé tende a costituirsi come Mito, come “invenzione fabulosa sotto la quale va ricercata la verità allegorica“: un percorso che – nell’analisi del dantista Michelangelo Picone, dal cui saggio Dante e i miti è tratta la citazione – tende a far prevalere una radicalizzazione dell’elemento creativo-generativo, lasciando affiorare lampi e riflessi di quel che Dante può aver presagito. Si sviluppa perciò un itinerario a ritroso, à rebours, ritrovando una galleria di figure novecentesche, ripartendo dallo stesso Thomas Mann, dalla Conferenza che tenne alla Library of Congress della città di Washington il 17 novembre dell’anno 1942, nella quale chiarisce perché la scelta di scrivere un romanzo dopo La Montagna incantata sia caduta su una materia tanto arcaica: «Influirono varie circostanze, personali ed epocali, e quelle personali erano anche dettate dal tempo, legate com’erano agli anni e al raggiungimento di un certo stadio della mia vita. ‘The readness is all’. Dovevo essere stato, umanamente e artisticamente, in qualche modo nella ‘disposizione’ di essere toccato e sollecitato produttivamente da un oggetto simile, e la mia lettura della Bibbia non fu un caso. Le età della vita hanno inclinazioni, esigenze e orientamenti di gusto diversi, ma anche capacità e priorità diverse.
È certo nella norma che in certi anni vada a poco a poco perdendosi il gusto per tutto ciò che è semplicemente individuale e particolare, per il caso singolo per l’elemento borghese nell’accezione piu ampia del termine. In primo luogo si pone l’interesse per il tipico, per l’eternamente umano, per ciò che eternamente ritorna, l’atemporale, insomma: il mitico. Infatti il tipico è già il mitico nel momento in cui è norma e forma originaria della vita, schema atemporale e formula data da sempre in cui la vita fluisce, riproducendo dall’inconscio i propri tratti. È evidente che il conseguimento del modo di vedere tipico-mitico fa epoca nella vita del narratore, significa una particolare elevazione della sua disposizione artistica, una nuova serenità nel conoscere e nel dare forma che, come ho detto, sono riservate solitamente alle fasi più avanzate della vita: se nella vita dell’umanità il mitico rappresenta infatti una forma arcaica e primitiva, nella vita del singolo essa rappresenta invece una forma tarda e matura» (mie le sottolineature, da qui in avanti).
Per offrire adeguata consistenza teorica, spirituale e dottrinale all’Opera della maturità, Thomas Mann non esitò ad affiancare il proprio pensiero critico alla complessa Epopea del Mito e del Mitologico avviata fin dagli anni ’30 da uno dei maggiori filologi e studiosi di Storia delle Religioni, Karol Kerényi: ne scaturì un Carteggio che il critico-scrittore Giacomo Debenedetti pubblicò nel 1960, in due parti, nella collana da lui diretta – la Biblioteca delle Silerchie – per le edizioni Il Saggiatore, traduzione di Ervino Pocar, con i titoli Romanzo e mitologia e Felicità difficile.
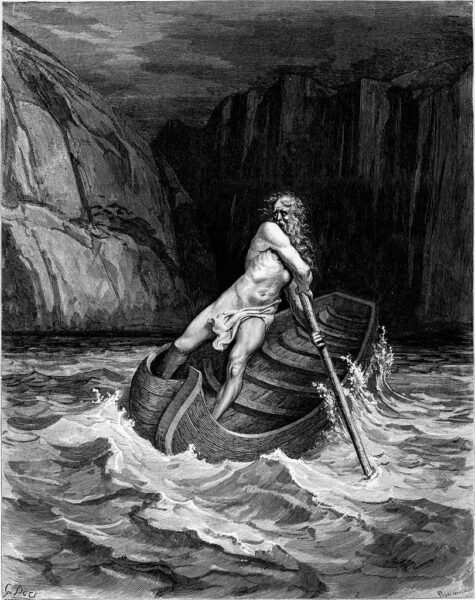
La concordia è già abbozzata in una delle prime lettere di Kerényi – 13 marzo 1934 – spedita da Budapest, che si conclude con queste considerazioni: «Lo studio del mito, persino di quello grande, è un compito che i massimi romanzieri si danno da sé. Il pubblico sta a guardare e ne capisce ben poco. E io mi domando se non si dovrebbe dire al più vasto pubblico in un linguaggio accessibile a tutti che il romanzo, avendo raggiunto il culmine, ritorna alle sue scaturigini e rivela la sua originaria natura».
Da un lato, quindi, la personalizzazione del Mito con tutto ciò che di inesorabilmente straniante, letterariamente e filosoficamente, comporta; dall’altro, il Mito come esperienza definitoria della fase tarda della scrittura d’autore, in virtù del quale il romanzo rivelerebbe, e ritroverebbe, la natura originaria.
Che Mann fosse preparato alle argomentazioni di Kerényi, lo testimonia un Discorso tenuto il 21 gennaio 1929 presso la Preuβische Akademie der Künste di Berlino, nell’occasione del Bicentenario della nascita dell’intellettuale e drammaturgo tedesco Gotthold E. Lessing, che inizia proprio con la definizione del concetto di classicità presentato “in una luce mitica”: «Classico è il tipo formato in precedenza, l’iniziarsi di una forma di vita spirituale attraverso l’elemento individuale vivente; è un tipo originario atavico in cui la vita ulteriore si riconoscerà e sulle cui orme procederà: è dunque un mito, giacché il tipo è mitico e l’essenza del mito è ritorno, atemporalità, perenne presenza».
Che il Mito potesse addivenire “realtà organica” e potesse di conseguenza stabilire intrecci e relazioni con le zone psichiche dell’Inconscio, fino all’opportunità di “afferrare le realtà psichiche in forme mitologiche”, è materia di due sostanziali saggi, risalenti agli anni ‘33 e ‘36: Dolore e grandezza di Richard Wagner, Freud e l’avvenire.
Del primo, iniziamo da questo passaggio: «Che cosa innalza l’opera di Wagner tanto al di sopra di ogni precedente dramma musicale? Sono due le forze che concorrono a tale innalzamento, forze e doti geniali che dovrebbero ritenersi opposte e ostili e di cui oggi appunto ci si compiace di riaffermare la contraddittorietà: la psicologia e il mito. Ora si vuole negare la possibilità della loro unione: la psicologia appare qualcosa di troppo razionale perché ci si induca a considerarla ostacolo superabile nel cammino che porta alla terra del mito. Essa è ritenuta antitesi al mito, così come è ritenuta antitetica alla musica, benché proprio questo complesso di psicologia, mito e musica ci si presenti subito in due grandi casi, in Nietzsche e in Wagner, come realtà organica».
Forze ostili, la psicologia e il mito, di cui ci si “compiace di affermare la contraddittorietà”, si trovano nell’ottica manniana congiunte, accordate: non più una posizione antitetica ma una correspondance, una corresponsione di obiettivi. Così si perviene a: «Wagner come mitologo, come scopritore del mito per il melodramma, come redentore dell’opera in grazia del mito: ecco la sua seconda forza. Ed effettivamente egli non ha eguali nell’affinità psichica con quel mondo di immagini e di idee, non ha eguali nella capacità di evocare il mito e ridargli nuova vita: egli trovò se stesso quando trovò la via dall’opera storica al mito, e ascoltando viene fatto di credere che la musica non sia stata creata per altro, non possa più porsi altro compito che servire il mito».
Non sfugge, in queste righe, che il passaggio dall’opera storica al mito istituirebbe la centralità e la crucialità dell’atto critico, l’attraversamento evolutivo; ancor di più, che nella creazione artistica sia contenuto in nuce il passaggio al Mito, un inconscio trasbordo verso le rive del Mito. Proprio come se l’opera d’arte si creasse come occasione per traghettar-si verso le regioni del Mito. Ancor più evidente in questo passaggio: «La musica di Wagner non è in tutto e per tutto musica, cosi come la trama drammatica che essa fa assurgere a poesia non è letteratura. È psicologia, simbolo, mitologia, enfasi… tutto ma non musica nel senso puro e pieno. I testi ai quali si abbarbica e che trasforma in dramma non sono letteratura, ma lo è la musica. Essa che sembra prorompere come un soffione dalle profondità preculturali del mito (e non sembra soltanto, ma ne erompe davvero), è per anche pensata, calcolata, cerebrale, scaltra e abile, e concepita letterariamente, allo stesso modo in cui i suoi testi sono concepiti musicalmente. Disciolta nei suoi elementi originari, la musica deve servire a porre in rilievo i filosofemi mitici».

La concordanza con il secondo saggio avviene dunque su precise coordinate: «Il mito vissuto è proprio il principio epico del mio romanzo – insiste Thomas Mann – e io vedo bene che nel momento in cui da narratore di vicende borghesi e individuali, mi sono rivolto a ciò che è mitico e tipico, il mio segreto rapporto con la sfera psicoanalitica è entrato, per così dire, in una fase acuta. […] Mito è infatti fondazione di vita; è lo schema senza tempo, la formula religiosa in cui la vita, dopo aver attinto dall’inconscio i tratti del mito e averli riprodotti, confluisce. Senza dubbio questa nuova visione mitica ed esemplare segna nella vita del narratore un momento essenziale, implica uno straordinario accrescimento della sua potenzialità artistica, una nuova felicità del conoscere e del creare quale, di solito, è riservata agli anni più tardi della vita; nella vita dell’umanità, il mito rappresenta infatti uno stadio primitivo e remoto ma nella vita del singolo uno tardo e maturo. Ciò che con questo modo di vedere si acquista è lo sguardo per la verità più alta che si mostra nel reale, la sorridente sapienza di ciò che è eterno, immutabile, sempre valido, dello schema nel quale e secondo il quale vive anche chi crede di vivere in maniera assolutamente individuale, nell’ingenua convinzione di essere il primo e l’unico, non sospettando nemmeno come la sua vita sia invece formula e ripetizione, un procedere su orme già mille volte calcate».
Il Mito è fondazione di vita, momento essenziale, accrescimento della potenzialità artistica, quindi legittimazione. Riporto tre ulteriori passaggi:
«Il compito dell’esistenza individuale consiste nel rendere vive e presenti, rivestite nuovamente di carne, forme già date, uno schema mitico che ha il fondamento nei padri».
«Il mito legittima la vita, e solo in lui e attraverso lui la vita trova la propria coscienza, la propria giustificazione e consacrazione».
«La vita, era dunque nell’antichità la reincarnazione vivente del mito, che si richiamava e si riferiva a esso e che soltanto per opera sua, soltanto richiamandosi al passato mostrava la propria importanza e autenticità».
Non si sarebbe di certo sottratto al confronto o all’evoluzione dialettica che queste parole richiamano, lo studioso di mitologie e di religioni Furio Jesi, che già nel lontano 1968 ebbe cura di incastonare nella sfera del Mito alcune “congiunzioni” di natura storico-strutturale, che consentono ancora oggi di circoscrivere opportunamente le nostre pretese. La domanda che rimane alla sommità del percorso suona cosi: Mito o Mitologia, Mythos o Mytología, presupponendo che «la parola “mitologia” non è sinonimo certo di “mito”, ed anzi se ne distingue nettamente poiché a “mito” aggiunge quello che pare essere il suo contrario, “logos”». E come per Thomas Mann, anche per lo studioso italiano non ci fu miglior interlocutore che l’apollineo Kerényi, della cui esperienza con le radici del divino faceva fede inizialmente il volume composto a quattro mani con Carl Gustav Jung, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, apparso nel ’48 in edizione italiana per l’editore Einaudi e la cura di Angelo Brelich.
Kerényi si domandava, per prima cosa, se “l’immediatezza dell’esperienza e del piacere di fronte alla mitologia” fosse ancora in generale possibile. E lo faceva discendere dalla coesistenza-associazione di alcune coordinate che val la pena di riproporre: la complessità della parola “mito”; il mito come “arte”, “arte come la poesia e partecipe essa stessa della poesia”; l’arte della “mitologia” come movimento della materia antica, da cui il termine mitologema (“il miglior termine greco”), che serve ad indicare “racconti intorno a dèi, esseri divini, lotte di eroi, discese agli inferi”.
Il paragone più appropriato – prosegue Kerényi – è quello con la musica: «Mitologia in quanto arte e mitologia, in quanto materiale, sono fuse in un unico e identico fenomeno, nella stessa maniera in cui lo sono l’arte del compositore e il suo materiale, il mondo sonoro. L’opera musicale ci mostra l’artista quale plasmatore e nello stesso tempo ci fa vedere il mondo sonoro nell’atto di plasmare se stesso».
L’Introduzione propone poi alcuni passaggi che possono costituire premessa per i nostri intendimenti danteschi. Uno di questi dice: «La mitologia, come la testa recisa di Orfeo, continua a cantare anche dopo la sua morte, anche a lunga distanza dal tempo della sua morte. Nel periodo della sua vita, il popolo cui essa era familiare, non soltanto cantava insieme con essa, come con una specie di musica: la viveva anche. Pur essendo una specie di materiale, essa era per quel popolo forma di espressione, di pensiero, di vita. A giusta ragione si è parlato della “vita per citazione” dell’uomo dell’età mitologica e a giusta ragione si è cercato di rendere chiara questa idea a mezzo di immagini di cui non si potrebbe trovare nulla di meglio».
Questo è dunque il territorio nel quale germogliano gli interrogativi che Furio Jesi pone per circoscrivere l’approdo teoretico cui giunge il lavoro di Karol Kerényi. Con una doverosa premessa: le parole mythos, logos, mithología, per la Grecia del V secolo si trovano alle prese con notevoli oscillazioni semantiche, suscitando la convinzione che originariamente «la parola “mithología” non fosse una mescolanza di contrari – dei “contrari” mythos e lógos – innanzitutto perché non sembra documentabile che mythos e lógos indicassero dei “contrari». Ne fa fede il movimento semantico dei due principali verbi che derivano da mythos – mythéomai e mythologéuō – ambedue verbi antichi presenti in Omero.
«Il primo deriva puramente da mythos; il secondo già implica la presunta “mescolanza di contrari”, “mythos” e “lógos”. Il primo, mythéomai, ha un significato prettamente aderente a quello di “lógos” e di “mythos” sembra rispecchiare il valore di “ordine”, “progetto”, “deliberazione”; il secondo, mythologéuō, significa “racconto”, “narro”, ma per solito con speciale riferimento a narrazioni di mythologíai, di vicende “intorno a dèi, esseri divini, ecc” o di vicende antichissime».
Il discrimine si compie dunque nella differenza-opposizione tra mythos e logos, ovvero tra la parola intesa come rivelazione e la parola di “ciò che è pensato e detto in maniera chiara e che può garantire la sua verità mediante prove rigorose”, per utilizzare le parole di un progenitore degli studi mitologici, Walter Otto. Continua Kerényi: «Solo il Logos include in sé – anche in quanto “discorso, narrazione, storia” – un nuovo tipo di responsabilità, la responsabilità di una qualche verità, sia essa storica, filosofica, scientifica o anche religiosa… Il logos, il racconto fondante piu consapevole della sua responsabilità, è subentrato al posto del mito persino nell’uso religioso. Questo processo rientra nella storia dell’uso della parola, degli stili e della letteratura, ma è anche una testimonianza della storia delle idee, in cui il logos – non come racconto bensì come fondamento di un certo tipo di comprensione – ebbe la meglio sul mito, il quale invece era il fondamento di un altro tipo di comprensione».
Un altro “tipo di comprensione” che per Kerényi coincide con la poiesis, con la forma del poetare, quindi nella “traduzione” del logos della “mitologhia” in versi, suscitando perciò un genere particolare che si colloca a metà strada tra la poesia e la pittura.
Il rapporto con il divino è quindi un rapporto “originario”, la mitologia è narrazione delle origini, gli dèi sono essi stessi origine. Jesi ricorda che, a proposito di dèi, Rainer Maria Rilke diceva “Voi soli siete l’origine”, eterne origini degli aspetti del mondo cui presiedono. Perfino il mondo infero – quel mondo che Dante Alighieri si “trova” a percorrere come origine del viaggio iniziatico – può essere considerato in tale accezione, “in quanto è solo la sua esistenza a fondare la morte che è parte integrante della vita”.
«Ogni mitologia spande chiarezza: chiarezza su ciò che è, avviene e deve avvenire. Il senso di tutto ciò si trova nei mitologemi… La lingua tedesca ha la parola appropriata: “begrϋnden”, motivare, fondare giustificare una cosa riportandola al suo fondamento. La mitologia “fonda”. Essa non risponde in vero alla domanda: “perché?” bensì a questa: “da dove? da quale “origine”?».

Parola che raduna nell’immediatezza una legione di pensatori tedeschi di comprovata fede: Wolfgang Goethe, che naviga nell’Urphänomen, il fenomeno originario, partecipando alla rigenerazione vitale del Mythos, e servendosi del prefisso Ur per ribadire il grado di intensità della derivazione primigenia; Martin Heidegger, che fa uso del termine Ursprung, traducibile con “surgimento” o “sorgimento”, per indicare e far risaltare – nella confluenza cui approda – il “saltare”, l’attraversamento di una “riva”, di una estremità.
Proprio Heidegger, del resto, ha opportunamente circoscritto il teorema poesia/verità – la cui andatura si rifletterà nel nostro dettato dantesco – indagando, approfondendo, la suggestione “ermetica” di un verso, non di Dante ma di Friedrich Hölderlin, poeta-Virgilio che lo ha orientato nella “tregenda” del Mito, illuminando il febbrile divenire del suo pensiero teoretico, e quel verso dice: «Pieno di merito, ma poeticamente, abita / L’uomo su questa terra», stabilendo l’inedita compatibilità – vertragen, “accordo” – tra “poetare” e “abitare”. «Poetare è l’autentico far abitare (Wohnenlassen). Ma con quale mezzo noi perveniamo ad una abitazione? Mediante il costruire (Bauen). Poetare, in quanto far abitare, è un costruire».
Ci troviamo, spiega Heidegger, davanti all’esigenza di pensare l’essenza del poetare come un “far abitare, come un costruire”, forse anzi il costruire per eccellenza, segnalando il cattivo uso che ordinariamente facciamo di termini come poesia poeta poetare, ogni volta che releghiamo il poetare nel regno della fantasia, allungando una distanza incommensurabile tra la poesia-poiesis e ciò che chiamiamo “il reale”, fotografando l’impressione che «l’abitare poetico strappi gli uomini dalla terra e trasvoli fantasticamente oltre il reale».
La poesia di Hölderlin, secondo Heidegger, ci guida proprio in direzione “terra”: «Pieno di merito, ma poeticamente, abita / L’uomo su questa terra». Basta mettersi in ascolto di versi come questi:
Può un uomo, quando la sua vita non è che pena,
Guardare il cielo e dire: così
Anch’io voglio essere? Sì.
Dove è messo in luce l’immagine-concetto dell’uomo cui è concesso di “guardare in alto verso i celesti”, mentre il commento recita: «Il guardare in alto supera la distanza che sta fra noi e il cielo, e rimane tuttavia quaggiù sulla terra. Il guardare in alto misura tutto il frammezzo (das Zwischen) che sta fra cielo e terra. Questo “frammezzo” è assegnato come sua porzione all’abitare dell’uomo. Questa misura diametrale cosi assegnata, e in virtù della quale il “frammezzo” di cielo e terra è aperto, la chiameremo ora la “dimensione” (dimension)».
Da qui Heidegger traghetta verso la domanda che indaga il significato “essenziale” della “dimensione”: «L’essenza della dimensione è la aperta-illuminata, e perciò diametralmente misurabile, assegnazione del “frammezzo”: il verso-l’alto del cielo e il verso-il-basso della terra. Non diamo un nome all’essenza della dimensione. Secondo le parole di Hölderlin, l’uomo misura da un capo all’altro la dimensione in quanto si misura con i celesti… L’uomo, in quanto è uomo, si è già sempre misurato rispetto a qualcosa di celeste e con qualcosa di celeste. Anche Lucifero viene dal cielo. Per questo è detto che “l’uomo si misura con la divinità”. Essa è la “misura” con cui l’uomo fissa le misure del suo abitare, del suo soggiorno sulla terra sotto il cielo». Segue un capoverso di particolare rilievo: «Solo in quanto l’uomo misura e dispone in tal modo il suo abitare sulla terra, egli è capace di “essere” in modo commisurato (gemäss) alla sua essenza. L’abitare dell’uomo sta in questo misurare-disporre la dimensione guardando verso l’alto; nella dimensione il cielo e la terra hanno parimenti il loro posto».
Se nel poetare accade, secondo Heidegger, la presa-di-misura, se il poetare è il prender misure inteso nel senso rigoroso del termine, attraverso cui l’uomo riceve la misura per l’estensione (Weite) della sua essenza, sorge una nuova argomentazione: «L’uomo è come il mortale. Egli si chiama cosi perché può morire. Poter morire significa: esser capaci della morte in quanto morte. Solo l’uomo muore, e ciò continuamente, fino a che dimora su questa terra, fino a che abita. Ma il suo abitare consiste nella poeticità. Hölderlin vede l’essenza del “poetico” nella presa-di-misura, mediante la quale si compie la misurazione-disposizione dell’essenza umana».
Nella lingua del poeta, la sostanza del “misurare” si contempla con questi versi:
Ma l’ombra
Della notte con le stelle non è,
Se cosi posso osar di parlare, più pura
Dell’uomo, che si chiama immagine della divinità.
Per ribadire che la regola di misura dell’uomo è la divinità: la divinità fissa le coordinate del suo abitare, del soggiorno sulla terra sotto il cielo. E lo sguardo dell’uomo verso la divinità – poeticamente abita l’uomo – consente di “edificare l’essenza dell’abitare“. Per raggiungere infine questi parametri di collocazione: «L’uomo è capace (vermag) del poetare sempre soltanto nella misura in cui la sua essenza è traspropriata (vereignet) a ciò che da parte sua ama e rende possibile (mag) l’uomo, e che perciò adopera e salvaguarda (braucht) la sua essenza. Secondo la diversa misura di questa traspropriazione, il poetare è di volta in volta autentico o inautentico. Per questo, anche il poetare autentico non accade in ogni tempo. Quando e per quanto tempo c’è il poetare autentico? Hölderlin lo dice con questi versi:
Fino a che l’amicizia,
L’amicizia schietta ancora dura nel cuore
Non fa male l’uomo a misurarsi
Con la divinità.
Resta da capire “l’Amicizia che cos’è?”, parola innocua che Hölderlin accompagna con l’aggettivo maiuscolo ‘die Reine‘, “la schietta“, e che nell’Aiace sofoclea, nel verso 552, compare come “la grazia (Huld), che sempre richiama la grazia“. E… «fino a che dura questo venire della ‘grazia’ è bene che l’uomo si misuri con la divinità. Se questo misurarsi accade, allora l’uomo fa poesia (dichtet) a partire dall’essenza del poetico. E se accade il poetico, allora l’uomo abita poeticamente su questa terra; allora, come Hölderlin dice nella sua ultima poesia, la vita dell’uomo è un vivere abitando».
Soffermiamoci a valutare il peso specifico di tali argomentazioni, a ridosso dell’onda enigmatica di quella “parola” per noi desueta, traspropriazione, che qui andrebbe intesa come una appropriazione del Sé, come il rendere propria una essenza. (Non va trascurato, del resto, che nel linguaggio heideggeriano, oltre alla nota parafrasi del Linguaggio come “dimora dell’essere”, la parola “origine”, che abbiamo messo sotto scacco, si declina nei modi opposti al convenzionale intendimento, si veda ad esempio come per “rivoluzione”, contrapposto a “tradizione”, Heidegger abbia coniato la formula «La révolution est un renouvellement opéré par voie – non de “progès” mais, au contraire, de “retrait”: il s’agit d’effectuer une remontée vers l’origine – qui savère toujours plus haut située qu’on ne saurait l’imaginer… Le mouvement de révolution n’est pas seulement dirigé vers l’extérieur mais débouche dans ce qui est antérieur: il est donc bien “un recul vers l’avant” – un engagement, autrement dit, dans le commencement».
Anche il verbo attiguo, traspropriare, ci rammenta l’intrigo imponderabile che lo stesso Dante accende su alcuni luoghi verbali, come sarà per il verbo Trasumanare – il Trasumanar significar per verba / non si poria del Canto I del Paradiso, che prevede appunto il superamento – l’oltrepassamento – della condizione umana di finitezza, quel Canto Primo della Terza Cantica avvolto nell’invocazione al Dio Apollo. Facciamo ancora un passo indietro, osserviamo come, sulla suggestione della figurazione Heidegger-Holderlin, ci paia di scorgere in filigrana la “prossimità” del viaggio dantesco, come nel vortice di concettualizzazioni che abbiamo percorso ci paia di intravedere la posizione, la postura, che il Pellegrino-Viandante-Viator sta assumendo per dare inizio al suo stupefacente Viaggio Oltremondano: lo scorgiamo mentre ancora giace sulla terraferma dell’accadere storico prima di perdersi nella “selva” del Canto I, prima di cedere allo smarrimento e al labirinto delle prove iniziatiche.
È proprio nel Canto I che il Pellegrino viene obbligato a misurare lo spazio immaginario e “reale” che ha di fronte, come fosse indotto a comprendere quanto misura lo spazio del Regno dell’Oltretomba che si accinge a varcare. Un compito, un mandato, che va di pari passo con la misurazione dello spazio di scrittura, misurazione delle sue facoltà, nonché della “resistenza” che un poeta deve possedere per governare la materia che si accinge a plasmare.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
La Selva è Origine, è cominciamento: ci si “perde” ma ci si “attarda”, il Pellegrino-Viandante la intercetta come luogo ineludibile, da osservare con circospezione e da percorrere in estensione. Anche Origine è parola holderliniana-heideggeriana, che in tedesco ha la modalità Ursprung, termine che ritrova il “sorgere”, lo “spuntare”, la repentina apparizione, dove Springen vuol dire saltare, varcare il limite: «Far sorgere qualcosa con un balzo in avanti, portarlo all’essere cominciando dalla provenienza essenziale e con il salto “instauratore”: ecco cosa significa la parola Ursprung».
La “provenienza essenziale”, il “salto instauratore”: ecco due elementi “strutturali”, sistemici, che ci consentono di distinguere comprendere appieno che cosa in Dante si fa “origine”, che cosa risospinge verso il nucleo forte e fecondo della originarietà, che si configura come trascendenza originaria, a cui Dante affida la sua zona di perdita, di smarrimento, di “abissalità”. Origine è dunque “scaturigine” che si pone davanti a noi, ci precede, a condizione che noi sappiamo “sistemarci”, farci “trovare” sul punto-limite, pronti a saltare, a operare il “salto”, ben consapevoli che la sola Origine di cui possiamo fare esperienza è il salto nel cuore, nel centro, del Tempo Originario.
Scriveva Philippe Arjakovsky, commentando la voce “Origine” del Dictionnaire Heidegger, che quando l’essere-uomo si apre al tempo dell’Origine, a questa maturazione del tempo che consente di aprire in simultaneità l’avvenire con l’essere stati, egli è portato, trasportato, da questo “rapt”, ratto, rapimento, che è insito, inerente all’evento dei fenomeni che si situano nell’istante della “con-temporaneità”, in una parola, esso è il tempo di un istante pronto a saltare al di sopra di se stesso per accogliere il getto, lo zampillo, lo sgorgare della fonte, accompagnando cosi il suo “sorgimento”.
La Commedia è dunque salto nell’Origine, una Origine che sta davanti a noi, Origine come visio, visio dei, ma al tempo stesso Origine è ritorno, ritorno alle cose stesse, “movimento essenziale” di una Fenomenologia che contemplando il “ritorno” addita il “là dove già siamo”, e se la condizione di avvio è la “sosta” del Pellegrino-Viator, ovvero il “mi trovai” della Selva Oscura, l’autore-agens che dispone la scrittura promuove nel silenzio il “raccogliersi dell’essere che si volge indietro alla sua verità”.
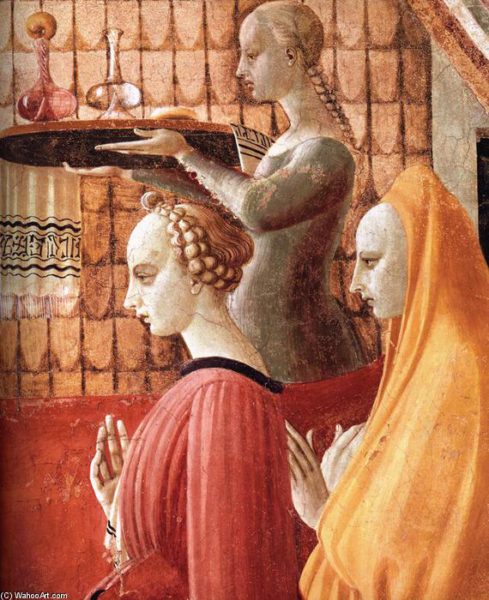
Mito, Origine, Provenienza essenziale, Salto instauratore: sostegni “dottrinari” che consentono la decisione, la scelta della messa in cammino del Viator Alighieri nell’anno 1300, elementi che Thomas Mann, nel riferimento a Goethe, avrebbe così commentato “Un’onesta fedeltà alla tradizione, che ha saputo elevarsi fino alla sfera del genio”.
Si potrebbe intitolare il percorso di Dante e della Comedìa come il percorso del “sacramente necessitato” che il termine tedesco “heiliggenöthiget” porge in traduzione italiana come “sacra necessità” o “sacramente necessitato”: si tratta di parola che compare una sola volta nel poetare di Hölderlin, nella composizione che porta il titolo Am Quell der Donau, Al fonte del Danubio, e che per Heidegger diventa “l’appello che pur rimanendo non pronunciato, non detto, domina l’intera sua opera poetica, l’appello a cui deve rispondere il suo poetare”, facendo sì che la parola poetica si apra – finalmente per necessità – al sacramento della propria sacralità, ovvero alla sua visibile e concreta “possibilità”: una possibilità che Dante rende ancor più tangibile nella configurazione, nella generazione di una parola poetica assolutamente nuova, mai “detta” prima.
Senza peraltro trascurare che la Commedia si impone in seguito ad una “urgenza” indifferibile, improcrastinabile, Dante interrompe, rende incompiute, due Opere di titanica impresa: Convivio e De Vulgari Eloquentia, lo scopo è in linea con la volontà di sacralizzare ad libitum la parola poetica, sancire la “possibilità” della sua essenza, l’infallibilità epistemologica e ontologica, decretare quindi lo “stato di necessità”.
“O Tutto sacro! Tutto intero vivente! Interiore”, dice la Pantea holderliniana, raccogliendo il precetto del (“divino”) Empedocle. Che, nell’esperire dantesco, diventa perseguimento della “Totalità” linguistica e poetica, la condizione di vantaggio che le Tre Cantiche fissano incomparabilmente: e se Heidegger ha modo di ribadire che “la Poesia si rapporta all’esistenza nella sua Totalità, in un modo essenziale” oppure che “là dove la Poesia si afferma, comincia ad affermarsi anche l’esistenza considerata come un Tutto”, il prodigio poetico dantesco appare il presupposto di ogni “alba” di poesia, sicché ci pare di intravedere, tra le righe sontuose del verso dantesco, il volto sgomento di John Milton, quando di fronte alla vastità del dettato shakespeariano, avvolto nel tormento della inarrivabile potenza, compone questi versi:
Ma tu, di se medesima orbando la nostra fantasia,
marmo ci fai, per troppo meditare.
“Totalità” è dunque la nota dominante dello spartito empedocleo, in assonanza con quella “Totalità senza limite” di cui verseggia Hölderlin nel poema “La morte di Empedocle”, il cui possibile legame è con la scena critica e filosofica di Maurice Blanchot – tenace, longevo decrittatore di misteri poetici – che in un saggio su Hölderlin, riprendendo l’itinerario di Heidegger, propone l’operare divino della “Luce” – “Il tuo operare divino, Luce, che riveli ogni cosa” – per annunciare o ribadire che dietro al poetare di Hölderlin, e alla trattazione che ne fa Heidegger, affiora la presenza-ombra dei Presocratici, il punto di congiunzione piu efficace con la Totalità di stampo empedocleo. Blanchot scrive: «In modo essenziale la poesia si rapporta all’esistenza nella sua totalità”; là dove la poesia si afferma, là comincia ad affermarsi anche l’esistenza considerata come un Tutto».
E con maggiore precisione: «Ciò con cui la poesia è in rapporto, e che permette di essere a sua volta rapporto, non è la Natura in quanto ‘pianta’, ‘popolo’ o ‘cielo’, e nemmeno la Natura come l’insieme delle cose reali, ma ciò che Empedocle chiama la Totalità senza limiti: il che significa tanto una totalità che non limita né il reale né l’irreale, quanto un Tutto dove viene a integrarsi e dov’è compresa questa libertà di non essere limitato da nulla».
Circoscrivendo così il poetare di Hölderlin: «La poesia si dirige verso questo Tutto, e rispondendo all’appello di questo “Tutto Intero” si educa e prende forma».
Ma una domanda pre-esiste alla “necessità” di far-si “poeta” e Blanchot la individua nella contraddizione di dover pronunciare, accanto alla necessità di essere poeta, l’impossibilità di divenire: “Non ci sarebbe alcun poeta, se quest’ultimo non tenesse incessantemente presente, non dovesse vivere, la sua propria impossibilità”. Come si configura, come si determina, questa “impossibilità”? «Essa ha questo senso fondamentale: che il poeta deve esistere come presentimento di se stesso, come futuro della propria esistenza. Egli non è ancora, ma deve già essere come ciò che sarà più tardi, in un “non ancora” che costituisce l’essenza del suo lutto, della sua miseria, della sua grande ricchezza».
Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi
Poi ch’ella stessa (la natura) presagendo riposa.
Trapela l’eco del disegno dantesco: la mente presaga si pone al “comando” delle forze della Natura, anticipando la potente illusione pretesa da Hölderlin negli Inni.
Perché piena di alto significato,
piena di forza silenziosa, la grande
natura abbraccia l’uomo che ha presagi, perché
dia forma al mondo.
Al poeta è consentito dare una forma al mondo, una “natura” al mondo, a patto che egli sappia aprirsi alla possibilità della poiesis: in tale guisa Dante costituirebbe l’Inizio – un Inizio – della Poesia come “possibilità” declinata nella “totalità” dell’esperimento: la poesia-poiesis diviene dunque “fabbrica” di lingua e di linguaggio, statuto originario – habitus principiorum: origine e motore di parole che consentono – giustificano – il nostro stare al mondo, i fenomeni che agiamo discendono da essa, dalla sua “presenza”, oltre che dal suo pre-sentimento: senza mai citare il Nome Dante Alighieri, Heidegger raggiunge alcuni presupposti basilari dell’itinerario del primo e del piu’ eccelso dei Viator: «Ora è chiaro: non solo non sappiamo chi siamo, ma alla fine bisogna partecipare proprio alla poesia per creare la condizione necessaria alla venuta del tempo in cui potremo apprendere chi siamo… Attraverso la poesia lasciamo innanzitutto che la questione riguardo a “chi siamo” pervenga, nel nostro ‘Dasein’, a una questione interrogata realmente, una questione cioè che affrontiamo durante tutto il tempo della nostra breve vita».
(Parentesi. A proposito del pre-sagire e della inedita alleanza tra Heidegger e Alighieri, procedendo sulla rotta holderliniana, quindi procedendo a ridosso della scoperta della “Lingua” o del Linguaggio, il filosofo lascia cadere questo concetto: «Il linguaggio, in quanto essenziale, presagisce la parola e sta in questo presagire. I vocaboli sono decaduti dal presagire. Essi formano, raccolti in un coacervo, sempre solo l’elenco della loro moltitudine, ma mai un linguaggio». Un “elenco” e “mai un linguaggio”: anche su queste parole una reazione di stupore ci coglie, intercettando, per il nostro sguardo di lettori-spettatori di stampo novecentesco, la sgomentevole unicità della prova dantesca, di fronte o contrapposta a pratiche scrittorie che oggi si risolvono in “coacervo” o in “elenco” di apparenti, spettacolari “moltitudini” e perciò inadeguate a divenire “linguaggio”.
Ma la fugacità di questo assunto mi porge, in repentina associazione, un passaggio, fugace anch’esso, che Heidegger lascia cadere in Essere e Tempo, e che suona così: «Il primo passo filosofico nella comprensione del problema dell’essere consiste nel “non raccontar storie”, ossia nel non determinare nella sua provenienza l’ente in quanto ente con il ricondurlo ad un altro ente, quasi che l’essere avesse il carattere di un ente possibile», e si tratta di un assunto relativo ad una riflessione che non posso qui ampliare: l’immagine che ne scaturisce, se riferita all’opera dantesca, lascerebbe trapelare che anche l’opera dantesca non potrebbe essere ricondotta ad altro da sé, si tratta quindi di un’opera che per essere “spiegata” abbisognerebbe di essere circoscritta in sé stessa, nel medesimo recinto di “forme”, di richiami, di presagi dentro cui è conchiusa, in sostanza non allontanandosi, non derogando dalla trascrizione originaria. Qui concludo la parentesi).

Siamo così entrati, approdati, nel Vestibolo, dove si allineano, si protendono, si dispiegano, le fasi, le stazioni, le propulsioni dell’esperienza dantesca, che è esperienza di Lingua e di Linguaggio – Parole mie che per lo mondo siete – articolazione del suo periodare strutturale e stilistico, dove “esperienza” si fa continuo “esperire”, esperimento del Sé, incessante sosta e variare di “motivi”, di occasioni, di percezioni, di appelli e di premonizioni. Un esperire che è viepiù esperienza delle origini, dei primordi, delle “trascendenze”. Per Dante esperire la Lingua vorrà dire sottoporla a perenne trasformazione, svellere dall’Idioma originario una danza di “motivi” che hanno inizio nella Scena Primordiale, con un Adamo e una Eva alle prese con l’esperienza-nozione del Peccato Originario, riportando al centro il tema dell’Origine, che qui assurge a prima volta – oltre che prima volta della forma e dello stile – celebrando il segno – i segni – dell’alleanza” tra Creatore e Primo Uomo – Dio e Adamo – dove si sancisce la fatale primazia della Lingua e del Linguaggio, creazione umana ad placitum, quindi la scommessa del Primo Uomo, colui che diviene detentore di Lingua e di Linguaggio, nella diversa e controversa duplice accezione – Gramatica e Volgare – affermando e reiterando la profonda, attiva trasformazione o mutabilità: nel De Vulgari Eloquentia I, ix è scritto: «Cum igitur omnis nostra loquela… Poiché dunque ogni nostra lingua – eccetto quella creata da Dio insieme al primo uomo – è stata ricostruita a nostro arbitrio dopo quella confusione biblica, che altro non fu che dimenticanza della lingua precedente, e poiché l’uomo è un instabilissimo e mutevolissimo animale, la sua lingua non può essere duratura né continua, ma, come tutte le cose nostre, ad esempio usanze e costumi, finisce per cambiare nel tempo e nello spazio».
Il Dante che frequenta strenuamente “le scuole de li filosofanti” apprende presto e bene che porre al centro della propria condizione di Poeta-Pellegrino, Viandante-Viator, Uomo itinerante del Tredicesimo Secolo, Esule e senza patria, la questione centrale, cruciale del tema-problema della Lingua, e della sua contorta, controversa evoluzione, accorda al suo divenire poetico quella mutabilità di approccio, di espressione, che in termini filosofici si pone come passaggio-trasmutazione, dall’Uno ai Molti, dall’Uno al Molteplice, e dal Molteplice all’Uno.
La Babele delle lingue e dei linguaggi su cui il Dante del De Vulgari Eloquentia si sofferma, dopo aver enunciato la regola del doppio registro – Gramatica come lingua stabile e incorruttibile e Vulgaris come lingua artificiale connotata di intrinseca mutevolezza – nasconde e dischiude la promessa temporale e strutturale di un “diveniente” poetico-compositivo che sarà centrale e propulsivo sia per il Dante rimatore della prima fase che per il Dante consapevole e major della seconda, che si immerge nella vastità del proprio dettato linguistico-narrativo, dispiegando nella costruzione della Commedia il compiuto modello di applicazione.
«Dicimus certam formam locutionis… Diciamo che con la prima anima fu concreata da Dio una determinata forma di linguaggio. E intendo “forma” sia riguardo ai vocaboli per indicare le cose, sia riguardo alla costruzione dei vocaboli, sia riguardo alla pronuncia della frase: e di questa stessa forma di linguaggio farebbe uso ogni lingua di essere parlanti, se non fosse andata distrutta per colpa dell’umana presunzione».
Parole estensive che nella coeva, parallela stesura del Convivio recitano: «Onde vedemo ne le cittadi d’Italia, se bene volemo agguardare, da cinquanta anni in qua molti vocabuli essere spenti e nati e variati; onde se ‘l picciol tempo così transmuta, molto più transmuta lo maggiore. Sì ch’io dico, che se coloro che partiron d’esta vita già sono mille anni tornassero a le loro cittadi, crederebbero la loro cittade essere occupata da gente strana, per la lingua da loro discordante».
È proprio la lingua “discordante” che Dante intende esaltare, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari” che costruisce, fabbrica, con-forma il destino di una lingua universale. Difficile quindi dimenticare o sottacere che quando Dante affronta il tema-problema della Lingua lo fa con lo sguardo rivolto alla Poesia, indicando il cammino dei Poeti, ragion per cui si fa palese la successione organica della sua Opera, ogni costruzione scrittoria è connessa alla precedente e alla successiva, ciascuna opera si fa eredità e annuncio, la forza trascendente che incorona il gesto poetico è conchiuso nella condizione di poeta pensatore, il poeta-critico, il poeta ermeneuta, nell’accezione moderna.
Sia il De Vulgari che il Convivio sono opere che per la loro intrinseca mutabilità, per l’ampio processo di sperimentazione che “incorporano”, risultano propedeutiche al cammino risolutivo della Commedia, costruite secondo un organico movimento interno: è nel suo farsi – sistematico e perpetuo – che si arriva a centralizzare il progetto, è nella strategia unitaria che rigorosamente persegue, e che infine abbraccia, circoscrive – unitariamente e coerentemente – il polivalente dettato della Commedia: ciò che è adombrato dentro alcuni passaggi della Epistola a Cangrande: «La prima divisione è quella per cui tutta la Commedia viene scandita in tre Cantiche; la seconda è quella per cui ogni Cantica si divide in canti; la terza è quella per cui ogni canto si divide in versi. La forma concepita come modo del trattare è poetica, inventiva, descrittiva, digressiva, transuntiva e insieme definitiva, divisiva, probativa, reprobativa ed esemplificativa». E ancora: «La commedia è un genere di narrazione poetica che differisce da tutti gli altri (…) Essa può essere definita polisensa, ossia dotata di più significati. Infatti, il primo significato è quello ricavato da una lettura alla lettera; un altro è prodotto da una lettura che va al significato profondo. Il primo si definisce significato letterale, il secondo, di tipo allegorico, morale oppure anagogico».
Il dato da tenere in evidenzia è dunque l’ampio tasso di organicità, di compiutezza dell’Opera dantesca, dell’intero corpus delle opere, una estensione scrittoria che converge intorno a un centro determinato, presupponendo l’esistenza di un sistema di richiami, di incessanti rimandi, sicché malgrado l’inquietante, grave, interruzione delle due opere che precedono la Commedia – scissura che cade come una lama sulla corporatura dell’Opus magnum – la congiunzione delle “parti” è esibita, potremmo dire, con spettacolarità tra i vari Gironi e tornanti, valga come esempio la raggiante, sincera esplosione di stupore con cui il Viator accoglie l’improvvisa apparizione del musico Casella nel Purgatorio II, nonché le parole precise che l’Ombra senza corpo gli rivolge, forse una delle poche volte in cui Dante avrà sorriso di profonda commozione, ritrovando inaspettatamente la forma del “richiamo” da lui già predisposta e risolta nel prosimetro della Vita Nova e ora esibita nell’abbraccio di quelle poche parole: “Così com’io t’amai / nel mortal corpo, così t’amo sciolta“.

Ora, se torniamo alla “parola prima”, al tema originario, al tema di cui siamo alla ricerca, per meglio avvolgere il percorso dantesco, se ci soffermiamo sulle parole prima citate (DVE I VI 4-5), constatiamo che il “certam formam locutionis” – sintagma ripetuto quattro volte – non è la semplice facoltà del linguaggio, ma – come scrive Mirko Tavoni – “una struttura linguistica compiutamente formata, cioè una lingua determinata che verrà identificata senz’altro con la lingua ebraica”. E crea ulteriore meraviglia constatare il grado, la misura del disegno strutturale che in questo breve passaggio possiamo riscontrare: Dante definisce in poche righe una densità e problematicità di temi che nell’ordine comprendono: anima, forma e linguaggio, pronuncia degli esseri parlanti, fino al criterio valutativo della “lingua della confusione” da cui promanerà il destino dei popoli.
Dante inizia a porre domande riguardo la lingua di appartenenza della stirpe umana, valutando inizialmente se il linguaggio, in senso proprio, possa appartenere anche ad altri esseri al di fuori dell’uomo, concludendo che il Linguaggio si rende necessario esclusivamente all’umana gente, quindi non necessario per gli Angeli che possono comunicare a mezzo di una forma di rispecchiamento intellettuale che li rende trasparenti l’uno all’altro, in sé stessi o attraverso lo speculum comune, cioè Dio; e infine chiedendo se Adamo si è espresso, nei riguardi di Dio, attraverso un linguaggio di tipo umano: Oritur et hinc ista questio… «Ma di qui sorge questo dubbio, che l’uomo per la prima volta parlò a Dio in forma di risposta (se si trattò di una risposta): infatti se fu rivolta a Dio, allora evidentemente Dio dovrebbe aver parlato, il che appare in contraddizione con quanto abbiamo prospettato sopra. Al che osserviamo che può ben aver risposto a Dio che lo interrogava, ma non per questo Dio deve aver “parlato”, nel senso di compiere quello che chiamiamo un atto di parola. Chi dubita infatti che ogni cosa che esiste si pieghi docilmente al cenno di Dio, dal quale tutte le cose sono state create, conservate e anche governate? Dunque, se l’aria si muove fino a produrre così grandi perturbazioni al comando della natura inferiore, che di Dio è ministra e creatura, da far rimbombare tuoni, lampeggiare fulmini, precipitare pioggia, spargere neve, scagliare grandine, forse che non si muoverà al comando di Dio per far risuonare qualche parola, scandita da Colui che separò e distinse cose ben più grandi? Perché no? (Quid ni?)». (De V.E. I iv 5-6)
Se ricerchiamo la “parola prima”, il primo fiat della Lingua di Adamo, la prima intonazione, il primo soffio vitale, la cui parola-essenza in lingua latina suona Primiloquim, notiamo che la ricerca dantesca trae consistente validità o essenza proprio nel dispiegarsi di una plurifunzionalità linguistica che allarga la “natura” della Lingua fino all’atto di experimentum: fare della Lingua un esercizio incessante di sperimentazione, soprattutto per la compresenza di istanze eterogenee e arbitrarie che sfociano nel rinnovato rapporto tra signa e res.
Oportuit ergo genus humanum… «Fu dunque necessario che il genere umano, per comunicarsi i propri concetti, avesse un segno razionale e sensibile: poiché infatti si tratta di ricevere dalla ragione e di portare alla ragione, doveva essere razionale; e poiché da una ragione all’altra non può passare nulla se non per un mezzo sensibile, doveva essere sensibile. Se fosse stato solo razionale, non poteva passare da un individuo all’altro; se solo sensibile, non poteva né ricevere alcunché dalla ragione né collocare nulla in essa». (De V.E. I iii 2)
E ancora: Hoc equidem signum… «È proprio questo segno quel nobile argomento di cui ci stiamo occupando: esso, infatti, è sensibile in quanto è suono; è razionale invece in quanto pare significare qualcosa a nostro arbitrio (significare videtur ad placitum)». (De V.E. I iii 3) (versione di Vittorio Coletti).
Affiora il doppio registro – razionale e sensibile – organicamente introiettato nel corpus linguistico, fino a generare la domanda su quale possa essere l’elemento che lega e salda le reciproche istanze, il signum vocale col concetto della mente. Abbiamo letto che il suono vocale diventa parola solo “in quantum aliquid significare videtur ad placitum”, “in quanto pare significare qualcosa a nostro arbitrio”, che parrebbe voler dire: naturale è all’uomo il parlare, ma naturale e necessario è il successivo variare dei linguaggi.
Il dantista Bruno Nardi, in uno scritto dell’anno 1921, così argomenta: «Si può attribuire al suono vocale un valore spirituale di segno, che per sé non avrebbe. Già sappiamo che la ragione, la quale si esprime per mezzo del linguaggio, è la ragione umana che si diversifica nei singoli individui per mezzo della discrezione, del giudizio e dell’elezione, quella ‘ratio inferior’, insomma, che sta in continuo contatto e si applica alla materia fornitale dai sensi. L’atto dell’intendere umano non si effettua, secondo Aristotele, senza un’immagine sensibile-interiore, in cui riluce, materiata, l’idea intelligibile. Si potrebbe anzi dire che ad ogni concetto intellettuale corrisponda già il suo segno espressivo nell’immagine fantastica. Ora è appunto l’immagine fantastica quella che muove il suono vocale e imprime ad esso un significato».

Dicimus ergo quod nullus effectus… «Diciamo dunque che nessun effetto, in quanto tale, supera la propria causa, perché niente può produrre ciò che già non è. E poiché ogni nostra lingua, tranne quella concreata da Dio nel primo uomo, è stata ricostruita a nostro beneplacito, dopo quella confusione che non fu altro che oblio della lingua precedente; e poiché l’uomo è un animale instabilissimo e mutevolissimo; non può essere né durevole né persistente, ma al pari delle altre cose umane, come i costumi e le abitudini, necessariamente varia con la distanza nello spazio e nel tempo. E non solo penso che non si debba dubitare di quel che abbiamo detto, “nel tempo”, ma anzi riteniamo che vada tenuto fermo: infatti, se esaminiamo a fondo le nostre opere umane, si vede che siamo molto piu’ diversi dai nostri antichissimi concittadini che dai piu’ lontani contemporanei». (DVE I ix 6-7) (versione di Vittorio Coletti)
Animale instabilissimo e mutevolissimo, né durevole né persistente, che varia con la distanza nello spazio e nel tempo, stirpe uomo connaturata alla “terra” da cui origina: ecco affiorare l’elemento Terra, il legame con la terra, opportunamente messo in risalto dal ricercatore Massimiliano Corrado nel libro Dante e la questione della Lingua di Adamo (2010), che richiama inaspettatamente il pensiero critico di Walter Benjamin, il saggio Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, che recita: «La seconda versione della storia della creazione, che parla dell’ispirazione del fiato, riferisce che l’uomo è stato fatto di terra. È questo, in tutta la storia della creazione, il solo passo in cui si parli di un materiale del creatore in cui egli esprime il suo volere, altrimenti concepito come immediatamente creatore. In questa seconda storia della creazione, la creazione dell’uomo non è avvenuta mediante la parola (Iddio disse – e così fu), ma a quest’uomo non creato dalla parola è conferito il dono della lingua, ed egli è innalzato al di sopra della natura».
L’atto del linguaggio è quindi un “passaggio” originario dell’uomo che indica il “legame” con la terra, l’atto di germinazione, il Creatore è prefigurato nei panni dello scultore-vasaio che plasma la creta, generando l’essere umano dalla polvere del suolo, non con la parola scaturita dalla propria bocca: Formavit igitur Dominus Deus hominem… «Allora il Signore Iddio con la polvere del suolo modellò l’uomo, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l’uomo divenne essere vivente» (Genesi 2,7). In tale accezione, “Adamo, oltre ad essere il nome proprio del primo essere creato, è un nome collettivo che indica ogni uomo legato alla terra da cui è stato tratto, con una sfumatura semantica che evoca la fragilità della creatura e ne designa la ‘finitudine ontologica’ (quia pulvis es et in pulverem reverteris)” (Massimiliano Corrado, 2010)
Nella finalità dantesca, potrebbe quindi rivelarsi affatto deviante la disperata “confusione babelica” da cui scaturisce la punizione celeste, posizionando al centro la natura peccaminosa dell’animale Uomo a seguito della cacciata dal Paradiso terrestre: O semper natura nostra prona peccatis! «O umana natura sempre pronta al peccato! O fin dall’inizio incessantemente sciagurata! Non era stata sufficiente alla sua correzione che, privata della luce per la primigenia presunzione, fossi condannata all’esilio dalla patria delle delizie? Non era bastato che, a causa della diffusa lussuria e crudeltà della tua razza, tutto ciò che era tuo, esclusa una sola famiglia, perisse nel diluvio e che gli animali del cielo e della terra avessero pagato per colpe che tu avevi commesso? Sarebbe ben dovuto bastare. Ma, come dice il proverbio, “non andrai a cavallo prima della terza volta”, tu, sciagurata, preferisti salire su un cattivo cavallo. Ecco, o lettore, perché l’uomo dimentico o sprezzante delle antiche regole, e distogliendo lo sguardo dai lividi che gli erano rimasti, per la terza volta insorse a meritarsi la frusta, presuntuoso di superba stoltezza». (De V.E. I, vii, 2) (versione di Vittorio Coletti)
È la “sorte” poetica, oltre che umana, di Dante Alighieri che si riversa in questi vigorosi moniti e nelle reiterate esclamazioni. Dalla parola “Babele” nasce infatti la parola “mutabilis”, e da qui la lunga sequenza delle lingue e dei linguaggi umani nel precipitare della condizione post-babelica: Cum igitur omnis nostra loquela… «Poiché dunque ogni nostra lingua – eccetto quella citata da Dio insieme al primo uomo – è stata ricostruita a nostro arbitrio dopo quella confusione biblica, che altro non fu che dimenticanza della lingua precedente; e poiché l’uomo è un instabilissimo e mutevolissimo animale, la sua lingua non può essere duratura né continua, ma, come tutte le cose nostre, ad esempio usanze e costumi, finisce per cambiare nel tempo e nello spazio». (De V.E. I, ix, 6) (versione di Vittorio Coletti)
È come se iniziasse a prevalere, sotterraneamente, la consapevolezza dell’intrinseco mutamento storico dei linguaggi, che per alcuni commentatori novecenteschi come Luigi Peirone diverrà la “scoperta della dimensione diacronica del linguaggio“, come se Dante fosse il prototipo del linguista moderno.
Se trasferiamo tali prerogative nel lesto variare dell’indole e del carattere dell’uomo, ritroviamo l’originaria “mutevolezza” nello stesso “destino” di Adamo, che dalla Lingua per eccellenza – la Lingua adamitica del Primo Uomo, contemplata nel Genesi prima della Caduta – ruzzola nel “fantasma babelico”, la confusio linguarum, alternativa e oppositiva alla “Lingua della Grazia”.
Agisce così la “contraddizione” di cui Dante, sia nel Convivio che nel De Vulgari Eloquentia, offre lucida attestazione: c’è la Lingua di Adamo, sacra e incorruttibile e inalterabile, che scivola, se cosi posso dire, nell’attrito, nel movimento dialettico, o contraddittorio, con il principio della intrinseca mutevolezza della lingua soggetta al beneplacitum umano, che è esercizio della volontà e del libero arbitrio, lasciando in opposizione i due elementi costitutivi: naturalità e necessaria variabilità dei Linguaggi.
Se nel Convivio (I V 14) Dante aveva difeso la Gramatica come principio dell’incorruttibilità della Lingua e dei Linguaggi (“però che lo volgare seguita uso, e lo latino arte, ma anche che lo latino è perpetuo e non corruttibile, e lo volgare è non stabile e corruttibile“), in De V.E. muta prospettiva e inneggia alla trasmutabilità, estendendo la legge della variabilità delle lingue naturali anche a quella di Adamo, quindi svelandone la corrispondenza, ma con un sentimento tutt’altro che rassegnato o cedevole, come se, seguendo l’argomentazione di Bruno Nardi, “gli stava così a cuore, che si risapesse questa nuova conquista della sua mente, che, incontratosi nel cielo stellato col vecchio padre Adamo, ne coglie l’occasione per mettergli in bocca la nuova dottrina”. Infatti, in Paradiso XXVI, Adamo, interrogato fra l’altro sulla lingua da lui usata (v. 114), risponde (vv. 124 ss.):
La lingua ch’io parlai fu tutta spenta
innanzi che a l’ovra inconsummabile
fosse la gente di Nembròt attenta:
ché nullo effetto mai razionabile,
per lo piacere uman che rinovella
seguendo il cielo, sempre fu durabile.
Opera naturale è ch’uom favella;
ma così o così, natura lascia
poi fare a voi secondo che v’abbella.
“Opera naturale è… ch’uom favella”, scrive Dante, e aggiunge: “ma così o così…”, precisando che “Natura lascia poi fare a voi secondo che v’abbella”. Nei versi precedenti aveva affermato che nessuna azione, per quanto scaturita dalla ragione, può considerarsi duratura, e questo perché l’uomo ha “piacere” di rinnovare in continuazione le proprie azioni, le proprie convinzioni: parrebbe, di conseguenza, che i termini linguistici utilizzati da Dante – e sappiamo quanto il suo poetare sia fondato sull’essenzialità della particella linguistica messa in campo – confermino che il poeta fosse ormai propenso a far risaltare la sistematica mutabilità delle lingue e del linguaggio (oltre a rimarcare che la féerie babelica avviene in un tempo posteriore rispetto alla sorte di Adamo: la lingua si era già spenta, dice Adamo al Pellegrino, prima ancora che gli “operai” della Torre iniziassero il lavoro di annientamento).
Così, transitando sul bordo di questi versi, forzando con garbo la cifra allusiva, potremmo spingerci fino a ipotizzare un Dante umano troppo umano, il Dante pellegrino e poeta che lascia fluire nella questione della Lingua la predizione della propria condizione morale ed esistenziale – l’esilio come militanza, exul immeritus – facendo in modo che il “troppo umano” che trapela nella fabbrica di una Lingua mutevole, soggetta al destino dell’Humani Generis, intonandosi ad esso, si riveli la spia, l’indizio, la traccia vistosa, evidente, del “suo” viaggio, anzi, della “sua” particolarissima condizione di viaggiatore oltremondano che si appresta a comporre il Poema – «cui porrà mano e cielo e terra» – investendo la “centralità” della condizione di viator consapevole, che ha preso su di sé l’incarico di poetare. Che è al contempo, appunto, la condizione di exul immeritus, di esiliato senza colpe: se la Lingua degli uomini muta, cangia, sottoposta alla controversa “natura” dell’elemento umano, cosi la Lingua è sottoposta alle variazioni della coscienza individuale, alla storicità delle “appartenenze”, perché soltanto se messa in tal guisa, se arricchita di tali “variazioni”, la Lingua può narrare, raccontare, l’infinita molteplicità-difformità dell’essere uomo e della coscienza individuale, l’umano troppo umano a cui “semo subietti” (alla cui sorte, del resto, soggiace – secondo Roland Barthes ne Il piacere del testo – l’individuo-lettore che “mescola tutti i linguaggi, anche se ritenuti incompatibili“, che si fa promotore della “contraddizione” e che sopporta la contraddizione senza vergogna: “Ora questo controeroe esiste: è il lettore di testo, nel momento in cui prende il suo piacere. Si capovolge il vecchio mito biblico, la confusione delle lingue non è più una punizione, il soggetto accede al godimento attraverso la coabitazione dei linguaggi, che lavorano fianco a fianco: il testo di piacere è Babele felice“).

È dalla condizione di perenne variabilità e trasmutabilità che discendono istanze linguistiche ed espressioni verbali che appartengono al nostro vocabolario di uomini moderni: caducità, mutabilità, dinamicità, instabilità, indeterminatezza, cristallizzando la rappresentazione primaria dell’Uomo, “instabilissimum atque variabilissimum animal”, come affiora nelle parole di Adamo in Paradiso XXVI: nullo effetto mai razionabile, / per lo piacere uman che rinovella / seguendo il cielo, sempre fu durabile.
Che è, del resto, la prospettiva “filosofica” che il De Vulgari Eloquentia muove sottotraccia, riassumibile nel disegno di un percorso “dall’uno ai molti e, di ritorno, dai molti all’uno”, formula che il dantista Ruedi Imbach ha messo in luce in un saggio del 2008: «Il ragionamento dell’intero primo libro si lascia riassumere nella seguente formula: un percorso dall’uno ai molti e, di ritorno, dai molti all’uno. Al principio si dà la lingua originale data da Dio ad Adamo. La pluralità delle lingue, comparsa nella storia dell’umanità in conseguenza del peccato originale, può spiegarsi non solo nei termini di una punizione divina, ma anche, razionalmente, a partire dalla “natura dell’uomo”. Gli inventori della lingua pura vollero vincere gli svantaggi collegati alla pluralità linguistica, sennonché la lingua o le lingue artificiali da loro escogitate, segnatamente il latino dei chierici, falliscono. Esse restano freddamente lontane, a causa del loro sollevarsi aldilà di tempo e spazio concreti, dalla dinamicità della vita umana. Dante, senza rinunciare alle esigenze di unità, abbozza perciò il progetto di un “altro viaggio”, di ritorno diverso all’uno, che consiste nell’intensificazione e regolazione dell’italiano comunemente parlato».
Proprio per i riferimenti di Dante agli auctores (Virgilio e Lucano, Orazio e Ovidio), potremmo ipotizzare che il riferimento all’Uno, che costituisce il finale porto di approdo dell’intera costellazione ermeneutica, intrecciando allegoria storia e politica – felice punto di congiunzione tra le molte e disparate “anime” che il caleidoscopio dantesco abbraccia e sussume (includendo quel giardino di opere ancora oggi colpevolmente trascurate, come la Monarchia, le Egloghe, le Epistole) – sia proprio da attribuire alla Poesia, affermata e declinata come Pŏēsis. L’appello che il Pellegrino rivolge ai mortali nel Canto I del Purgatorio – Ma qui la morta poesì resurga – denota uno sguardo rivolto all’indietro, evoca il primiloquim di cui Adamo era stato detentore, seppure per pochissimo tempo (sette ore, Pd XXVI), mentre visse in terra novecentotrenta anni e attese nel Limbo, prima di essere tratto al cielo da Cristo, quattromilatrecentodue anni e che ora passa, si trasferisce, si “compenetra” nel Poeta che dovrà proseguire quell’opera, dovrà affermare di nuovo una “prima volta”, una “parola prima”, come spettasse al Poeta novus, già cercato nella tensione adolescenziale della Vita Nova, sollevare la palma dell’Eletto di colui che, unico e primo, riceve direttamente da Dio la facoltà di parlare poetando.
È stato Gianfranco Contini a parlare, a proposito della “forma” della Commedia, di una “Enciclopedia degli stili”, volendo rimarcare con raddoppiata convinzione che l’itinerario critico-esegetico da perseguire riguardi sia la pluri-significanza che l’integrità del molteplice, ovvero le “due realtà speculari, i due sistemi di segni del tutto corrispondenti: Imago mundi e Forma encyclopaediae“ (così Cesare Vasoli in una conferenza del 1992). Che sono, appunto, gli spazi di manovra dentro cui la poesia dantesca sorge e si impone, i presupposti da cui discende la consistenza di un progetto onnicomprensivo che colloca l’operare poetico e critico di Dante dentro quell’ideale prevalentemente medievale che potremmo chiamare “sistematicità”.
Premesse e presupposti che rendono viepiù pressante la curiosità di scrutare la vita quotidiana del pŏēta nato nel 1265 e morto settecento anni addietro, comporre l’immagine dello scrittoio, che cosa lo connotasse, quali incartamenti o exemplaria, tabula o copia dimorassero sul suo tavolo di lavoro, come si intrecciassero codici e miniature, da dove originasse la poderosa cultura libresca, quali gli itinerari di ricerca, i Nomi illustres da consultare strenuamente, il catalogo, la presunta “bibliografia” degli auctores che lo irretivano e lo ispiravano. Una domanda che concede risposte esclusivamente lacunose, non foss’altro per la crudele punizione dell’esilio, a cui è costretto dall’anno 1302, la dispersione fisica e mentale, la penosa via crucis dell’erratico- errabondo, sicché spetta a noi in ultima istanza l’immagine-sintesi dell’ipotetico sciptorium, stabilire cosa mettere in spiccata evidenza, allestire un percorso che accenda in pregnante sequenza le opere maggiori raccolte nella Scuola “de li poeti e de li filosofanti“, iniziando ipoteticamente dall’Eneide virgiliana, transitando nel caleidoscopio della galassia aristotelica – Ethica Nicomachea in primis – raggiungendo Ovidio, le Metamorfosi, dove si evidenzia, come ha ottimamente discusso Michelangelo Picone, il carattere dissimulatorio dell’opzione virgiliana: «Il passaggio da Ovidio a Virgilio al livello del programma poetico non comporta affatto, al livello della composizione letteraria, un’emarginazione del modello ovidiano. Ben al contrario, Ovidio, detronizzato dalla funzione di guida e quasi assente come personaggio della Commedia, si prende la sua rivincita assumendo il ruolo di ispiratore segreto, ma continuo, del nuovo stile epico dantesco. Ancora più dell’Eneide, infatti, le Metamorfosi costituiscono l’intertesto classico privilegiato col quale la Commedia si trova a dialogare“».
Senza tuttavia trascurare il dato dinamico che sta dietro ai prestiti di erudizione intorno ai quali Dante costruisce l’identità del Poeta: se cerchiamo le condizioni che secondo Dante rendono possibile la funzione e la condizione del Poeta – presupponendo che il Poeta è colui che “detiene” la Lingua e il Linguaggio (che proprio in Heidegger si attesta come “dimora dell’Essere”) – scopriamo che il Poeta dantesco è “artifex”, e lo è strutturalmente, perseguendo e componendo il “destino” ultimo della stirpe uomo, Poeta è colui che “veste” non episodicamente, non occasionalmente, la poiesis ma colui che la “incarna”, la trattiene come elemento regolativo-costitutivo dell’esistere, ciò che misura la distanza – incolmabile – tra il paradigma di Lingua e Linguaggio imbastito da Dante nel De Vulgari Eloquentia e nel Convivio e le funzioni autoreferenziali dell’Io o dell’Es che siamo soliti affermare nei nostri anni. Il Poeta dantesco è artifex, nel senso che si fa “istitutore” di una Lingua, nonché mediatore-propulsore del Linguaggio che da quella Lingua discende e si dispiega via via nelle diverse “forme”: fosse la “forma artificiata, squisita e nuova – sottilmente lavorata, nobile e rara, per mezzo della quale dové attuarsi l’antico comporre di contenuto religioso” (utilizzando le parole di Francesco Petrarca nel 1349) o la “volgar forma, usitata ma artificiosa e esquisita e nuova (…) la quale forma li Greci appellano poetes; laonde nacque che quello che in cotale forma fatto fosse s’appellasse poesis” (che troviamo nei desiderata di Giovanni Boccaccio).
Da qui il passo veloce che si incarica di intercettare significati e valori: a quali condizioni, secondo Alighieri, si accende, si rivela la “poesia-poiesis”, quali “argomenti” il Poeta deve privilegiare, quali possono definirsi degni dell’Illustre Volgare? La risposta è custodita nel Libro II del De Vulgari Eloquentia: la sommità della scrittura poetica è affidata ai magnalia – salus venus virtus – che rispondono alla qualità essenziale della triplice natura dell’uomo – vegetale animale razionale – e dei relativi bisogni fondamentali: ricerca dell’utile, del delectabile, dell’honestum. E che i magnalia abbiano ruolo e funzione di “finalità”, nella configurazione più essenziale, che essi possano emergere – imporsi – “come oggetti o scopi supremi dell’agire“, “sommi temi da cantarsi nel modo più alto” (armorum probitas, amoris accensio, directio voluntatis: “valore nelle armi, ardore amoroso, volontà ben diretta“), tali insomma da poter competere o figurare accanto a “opere grandiose e mirabili“, lo constatiamo come preciso intendimento dell’operare dantesco, anche sulla scia delle intuizioni del critico-filologo Pier Vincenzo Mengaldo, che alla multisignificanza del trattato filosofico ha dedicato studi indispensabili.
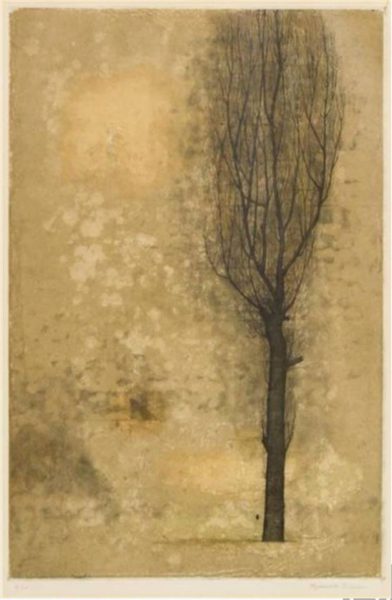
Guardiamo da vicino, ora, il passo in questione, il paragrafo IV del Libro II del De V.E. ponendo l’accento sulla regola degli stili: Per tragediam superiorem stilum inducimus… «Con ‘tragedia’ intendo lo stile superiore, con ‘commedia’ quello inferiore e con ‘elegia’ lo stile degli infelici. Se è un argomento da cantare in stile tragico, allora bisognerà assumere il volgare illustre e quindi comporre una canzone. Se invece lo stile è comico, si prenderà ora un volgare mezzano ora quello umile (e di questa scelta mi riservo di parlare nel quarto libro). Se infine lo stile è quello elegiaco, bisogna utilizzare solo il volgare umile (…) Deve essere chiaro che usiamo lo stile tragico quando lo splendore dei versi, l’altezza della costruzione e l’eccellenza dei vocaboli concordano con la profondità del pensiero. Ragion per cui, se ricordiamo che le cose somme sono degne di quelle a loro volta somme, e questo stile, che chiamiamo tragico, è evidentemente il sommo tra gli stili, quegli argomenti che ho distintamente mostrato degni di essere cantati nel modo più alto, vanno cantati solo in questo stile: dico la salvezza, l’amore e la virtù e quanto in funzione di essi si pensa, purché non siano sviliti da qualche accidente (…) Chi ci riesce è di quelli che il poeta nel sesto dell’Eneide (per quanto parli figurato) chiama diletti da Dio, alzati al cielo dall’ardore della virtù e figli degli dèi. Sia, perciò, confusa la stoltezza di coloro che, senza tecnica né cultura, fidando nel solo estro, si misurano con le cose più alte, che vanno invece cantate nella forma più alta; e cessino da tanta presunzione; e se per natura o fannulloneria sono oche, non cerchino di imitare l’aquila che si alza verso il cielo». (versione di Vittorio Coletti)
Pochi dubbi, per il poeta dantesco, riguardo l’altezza da perseguire nel volo d’aquila; pochi dubbi altresì circa la “credibilità” o la “giusta” finalità del divenire poetico: scorrendo il Libro II, si spalancano via via i precetti regolativi: il Poeta “alto” rifugge ornati e ornamenti – le exornationes (ciò che noi forse oggi identificheremmo con le facili o gratuite vampate di virtuosismo, sebbene vada salvaguardata la rigorosa distinzione tra ornatus facilis e ornatus difficilis); neppure può affidarsi esclusivamente all’ingegno – Ingenium – (che forse per noi, oggi, sarebbe il guizzo dell’estro occasionale), ma da questi livelli iniziali è costretto a innalzarsi, a volare più alto, proprio verso quel modello che prevede un alto grado di conoscenza e di cultura: Sed optime conceptiones non possunt… «Ma i pensieri più alti non possono trovarsi che dove c’è cultura e ingegno; perciò la lingua più alta non conviene che a quanti hanno cultura e ingegno. E così la lingua più alta non si addice a tutti i versificatori, perché i più fanno versi senza cultura né ingegno e, di conseguenza, senza il volgare illustre. In conclusione, se non compete a tutti, non tutti debbono usarlo, perché nessuno deve agire contro il principio di convenienza». (De V.E. II, i 8) (versione di Vittorio Coletti)
C’è poi una “legge” di carattere formale, alla quale il Poeta secondo Alighieri non può che soggiacere: le parole devono scoprirsi armonizzate “per legame musaico“, secondo l’arte retorica e musicale, come ritroviamo in De V.E. II viii 6: Et ideo cantio nichil aliud esse videtur… «E dunque la canzone non appare essere altro che l’azione compiuta di chi compone parole armonizzate per la musica: per cui sia le canzoni di cui ci occupiamo qui, sia le ballate e i sonetti, e tutte le parole di questo tipo armonizzate in qualunque forma metrica, in volgare e in gramatica, diremo che sono canzoni. Ma, poiché esponiamo solo le cose in volgare, tralasciando quelle in gramatica, diciamo che fra i componimenti poetici in volgare uno è quello supremo, che chiamiamo canzone per eccellenza: e che la canzone sia qualcosa di supremo è stato dimostrato nel terzo capitolo di questo libro (…) Diciamo dunque che la canzone, così denominata per eccellenza, quale anche noi la ricerchiamo è una congiunzione in stile tragico di stanze uguali, senza ripresa, di significato unitario, come abbiamo mostrato dicendo ‘Donne che avete intelletto d’amore’». (versione di Mirko Tavoni)

Appare certo che Dante volesse imprimere una forte connotazione soggettiva al suo pronunciamento segnico-strutturale, che volesse stabilire i criteri necessari per definire la poesia nella sua essenza, nella sua “essenzialità”, avvicinandosi a quel precetto a noi congeniale, felicemente postulato da Heidegger, secondo cui evocare l’essenza o l’essenzialità equivale a considerare “l’opera come realtà operante della coscienza stessa”. Sarebbe come vedere la coscienza individuale, la coscienza del Sé, che si trasforma in poesia, in poiesis, che si “fa” poesia in virtù di quel particolare “facere” che è proprio di essa (dove facere sta proprio per “creare cosa che non è“). Chi cercasse una definizione concreta, tangibile di “poesia”, nell’accezione dantesca, troverebbe infatti queste precise parole: “poesia” è fictio rethorica musicaque poita, la cui lineare trasposizione sarebbe “finzione espressa secondo retorica e musica“, constatando che Fictio è termine prismatico, aperto a mutazioni repentine, a convulse variazioni di significato. Nella Voce dell’Enciclopedia Dantesca, Fictio è “invenzione”, “opera di immaginazione”, “invenzione della fantasia”, “creazione fantastica”, fino all’ estensione lineare a noi prossima: fictio come “finzione”. Che nel rigoroso “sommario” medievale diventa pure: “bella finzione che cela una verità” (il secondo quaderno del Convivio – II XI 9 – confermerà essere triplice la bellezza della Canzone: «sì per construzione, la quale si pertiene a li gramatici, sì per l’ordine del sermone, che si pertiene a li rettorici, sì per lo numero de le sue parti, che si pertiene a li musici»).
È indubbio, del resto, che il Trattato, la cui iniziale composizione oscilla tra il 1303 e il 1304, secondo le valutazioni di Giorgio Petrocchi, sia condotto con spietato metodo analitico proprio per fissare le coordinate essenziali affinché si possa “istituire” la parola poetica, affinché si possa decretare la supremazia del “poetico”, che è soprattutto il grande tema-problema che Dante pone al suo tempo e alle generazioni che verranno: determinare le condizioni di possibilità che consentono la fondazione della “Poesia” come – ontologicamente – istitutiva del linguaggio umano (come fosse perpetua potenza nell’atto di compiersi). Contro una scrittura “occasionale”, richiamata nel trattato con la parola “casu“, distinguendo coloro che versificano casu da quelli che versificano arte, Dante innalza un decalogo dottrinario – un disegno “didattico-precettistico” (Mengaldo) – un apparato teorico, strategico e funzionale, che prevede precetti e regole sistematiche nonché ineludibili. A partire dall’assioma tam prosaice quam metrice decere (“è giusto utilizzare il volgare italiano sia nelle opere in prosa che nelle opere in versi“), il Trattato latino sciorina con affilata tensione le condizioni basilari che il Poeta è tenuto a rispettare: il Volgare Illustre richiede uomini eccellenti per ingegno – ingenium – e scienza, disprezzando gli altri; non conviene a noi umani in quanto “genere” (perché in tal caso converrebbe anche agli animali), né in quanto “specie” (perché converrebbe a tutti gli uomini, il che sarebbe sacrilego, non rispettando il criterio di differenza); conviene a noi umani in quanto “individui”, con la seguente precisazione: Niente conviene all’individuo se non per ragione della sua particolare dignità. Affiora la domanda: Che cosa intendiamo quando diciamo “degno”? «Diciamo che è degno ciò che ha una dignità, come diciamo che è nobile ciò che ha nobiltà (…) Una dignità è l’effetto ovvero il punto d’arrivo di certi meriti; così quando uno ha ben meritato, diciamo che è progredito verso una dignità buona, e quando ha mal meritato, che è progredito verso una dignità cattiva: per esempio chi ha combattuto bene è progredito verso la dignità della vittoria, chi ha governato bene verso quella del regno, e all’opposto chi ha mentito è progredito verso la dignità della vergogna, e chi ha rubato e ucciso verso quella della morte». Dal che si desume che: «Se le cose che convengono spettano alle dignità, cioè agli uomini che le possiedono (…) è chiaro che ciò che è buono converrà ai degni, ciò che è meglio ai più degni, ciò che è ottimo ai degnissimi», per cui, conseguentemente, la lingua migliore converrà ai pensieri migliori. E dove si “trovano” i pensieri migliori? «I pensieri migliori non possono essere se non dove c’è scienza e ingegno: dunque la lingua migliore non conviene se non a quelli che hanno ingegno e scienza». E dunque: «La lingua migliore non converrà a tutti i versificatori, dato che la maggior parte versifica senza scienza e senza ingegno, e di conseguenza nemmeno il volgare migliore. Perciò, se non si addice a tutti, non tutti devono usarlo, perché nessuno deve agire contro il principio della convenienza».
E ancora, proseguendo: «Il passo successivo è stabilire se con esso si debbano trattare tutti gli argomenti o no; e, se non tutti, mostrare partitamente quali argomenti siano degni di esso». Domanda: quali sono gli “argomenti” degni di essere trattati, meritevoli di ospitalità nella lingua più alta del Volgare? Si torna alla distinzione originaria: l’utile, il dilettevole, il virtuoso (salus, venus, virtus)… … «Ora, bisogna precisare – discutere – quali sono le cose grandissime. Anzitutto nell’ambito dell’utile: e qui, se guardiamo attentamente l’intento di tutti coloro che cercano – perseguono – l’utilità, non troveremo null’altro che ricerca della salute fisica. Riguardo invece al piacere, diciamo che è massimamente dilettevole ciò che piace in quanto oggetto più prezioso del nostro desiderio: ed è l’amore terreno. Per quanto concerne infine il bene – l’onesto – nessuno dubita che si tratti della virtù. Perciò, queste tre cose, cioè salute, amore e virtù, paiono essere quei tre alti argomenti che si devono trattare nel modo più alto – massimamente – cioè in ciò che è per essi più alto, vale a dire la prodezza nelle armi, la passione d’amore e il retto governo della volontà».

È a questa altezza che l’Espressione D.A. prende a configurarsi, avviando radicalmente una revisione dei parametri poetici, circoscrivendo, radunando, sotto lo stendardo del Volgare Illustre, i princìpi regolativi – e rivelativi – che consentono alla parola poetica, alla parola scritta e detta in forma di poesia, di raggiungere nobilitade e moralitade, dove quest’ultima ha significato di scelta, di convenientia, intendendo appunto quel rapporto “che non lega tanto stile (volgare) e contenuti come tali, ma dignità del volgare e dignità personale dello scrivente, la quale necessariamente produce alte concezioni” (Mengaldo). Così agendo, gli elementi costitutivi del quadrante poetico – constructio, utilitas, ordo, musica, rytmus, eccetera – si radunano intorno a uno status che prevede – esclusivamente – il grado più alto, l’eccellenza assoluta, tale da presupporre la scintilla “rivelativa” – nonché “veritativa” – dell’esperienza poetica, che è poi, detto altrimenti, la dimensione messianica, come se insomma il poetare fosse la “maniera” suprema – illustre – del linguaggio capace di intercettare quella totalità che discutevamo inizialmente. Una prospettiva che vedrebbe un Dante assertore, al contempo, della “perpetuità” della parola poetica, concepita e messa in atto come parola-verbo, parola illustre che si oppone al vuoto della condizione umana, alla nientità del “viaggio” terreno, conformando le nuove fattezze del Pellegrino-Agens incaricato di incarnare la dimensione essere/tempo – Personaggio Uomo collocato nel tempo “secondo un prima e un poi” (numero di movimento secondo un prima e un poi, secondo Aristotele) – mentre si dispone al passaggio nell’Oltretomba, “ove la fine e il principio eternamente coincidono“.
Conoscenza, Verità, Rivelazione: è proprio lo iatus tra Vita Nova e Commedia che certifica – giustifica – l’avvento della parola poetica come parola “qualitativa”, come Verbo veritate, una Parola che fa seguito all’incastro poetico-esistenziale esibito nel libello della giovinezza e sciorinato con lungimiranza nella scelta delle Canzoni nel Convivio (Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete, Amor che ne la mente mi ragiona, Le dolci rime d’amor ch’i’ solia). Tra gli artigli programmatici di questi versi si compie la crisi psico-esistenziale affrontata con consapevolezza di intenti e soluzioni, il delicato passaggio cui soggiace ogni itinerario poetico che si possa dire di “formazione”, la medesima sofferenza che secoli dopo interrogherà la giovinezza di Arthur Rimbaud come di Hugo von Hoffmansthal, come di Paul Celan e di poeti che si “misurano” con le autorictates, oppure, compiendo un salto ancor più azzardato, situato al limite tra la parola poetica e la parola de li filosofanti, il Friedrich Nietzsche che si arrampica sulle alture della Nascita della tragedia, spalancando d’improvviso un nuovo ordine del discorso.
Tra Vita Nova e Commedia si misura il distacco, la distanza tra la propensione poetica di prevedibile origine e “consistenza” e l’epifania consapevole; nasce e si impone l’Itinerarium ad Deum, che interrompe, spezza, trasforma, la matrice nativa, esponendo per la prima volta il poeta nell’idea di compiere un Viaggio Oltremondano, “dov’Ercule segnò li suoi riguardi“, come prima di Dante tenterà l’Ulisse naufrago di Inferno XXVI, risoluto a perdersi “di retro al sol, del mondo sanza gente”, non potendo disporre dell’attrezzatura “morale”, di moralitade, che quel “viaggio” impone, reclamando come requisito prioritario proprio lo svelamento dell’asse programmatico e ideologico delle proprie canoscenze (e Inferno X rafforza tale concetto, puntigliosamente affermato da Cavalcante de Cavalcanti, stupito e costernato, se non indignato, nello scoprire che il privilegio di cui Dante è mirabile soggetto-eletto non sia stato concesso al “primo de li suoi amici“: «E Guido ov’è? Perché non è teco?» «Da me stesso non vegno: /colui ch’attende là, per qui mi mena/forse cui Guido vostro ebbe a disdegno»).
Così, il solenne adagio di Inferno XXVI, Fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza, sovente esibito come stemma di nobilitate, attende di essere restituito all’ampiezza della derivazione, se non proprio di una efficace contestualizzazione che si irradi sopra l’intero patrimonio del dettato dantesco, agganciandosi come allegoria al patrimonio dottrinale aristotelico: conoscenza è prassi dell’Intelletto che valuta la Verità come fondamento – subiectum – di ciascun essere, a perfetta simiglianza – quindi non equivocabile, non modificabile, non deformabile, non alterabile o commutabile – con la cosa in sé, con la cosa come è. E come già Convivio IV aveva decretato: Sano dire si può [l’intelletto], quando per malizia d’animo e di corpo impedito non è ne la sua operazione; che è conoscere quello che le cose sono, sì come vuole Aristotile nel terzo de l’Anima (Cv IV XV 11).
Vera conoscenza, quindi, è conoscere secondo Veritate (Convivio IV I 3: Cominciai… ad amare li seguitatori de la veritade e odiare li seguitatori de lo errore e de la falsitade), mentre la “non verità” – non veritate o non veritade – si rende evidente anche nella conoscenza sensibile, nella conoscenza “esteriore”, “come un fanciullo che conosce soltanto le apparenze e non le cause delle cose”: La maggiore parte de li uomini vivono secondo senso e non secondo ragione, a guisa di pargoli; e questi cotali non conoscono le cose se non semplicemente di fuori, e la loro bontade, la quale a debito fine è ordinata, non veggiono, per ciò che hanno chiusi li occhi de la ragione, li quali passano a veder quello (Cv I IV 3).
Per cui, se il Viaggio del peregrinus avviene sotto la potente egida e protezione di Colui che tutto move, non può che prefigurarsi, allo stesso tempo, come viaggio di iniziazione “poetica”, di poiesis nel più acceso significato, ovvero è il Poeta-Fabbro Dante Alighieri che transita attraverso i Regni dell’Eternità e dell’Oltremondo con le armi – nude e crude – della parola poetica: è ad essa che Dante affida il compito – l’ufficio, la missione – di agire i tre emisferi che la conoscenza provvista di virtute ha posto a sigillo del cammino umano e nelle quali si stagliano, come in una sfavillante icona meridiana, le dimensioni morali e conoscitive oltre che estetiche e filosofiche, nonché la ri-composizione del mondo sensibile, la ri-creazione dello spazio-tempo, sotto la luce di colui che ‘n terra addusse / la verità che tanto ci soblima (Pd XXII 42).

L’ipotesi a noi più consona è che Dante parli della Poesia, della parola trasformata in poesia, ad-veniente poesia, come “trascendente” la verità “secondaria” delle cose, quindi capace di affermare la natura dei fenomeni “secondo l’ordine stabilito da Dio” (Cv II I 13 e IV VIII 15), additando il Poeta come depositario unico: il Poeta è colui che specula la verità, la interroga, la assedia, per rivelare le cose come sono (similitudo, madre della Verità), se è vero che Verità è l’oggetto dell’intelletto umano, è il suo bene, è scoprire l’essenza nel proprio fondamento, è la permanenza al di là del mutevole, Verità come permanenza e immutabilità: interrogare e fondare la verità è quindi operazione nella quale l’uomo in quanto tale si realizza pienamente, “conseguendo perfezione e felicità”. Seguendo il diagramma dello studioso Alfonso Maierù, che ha curato la voce Verità dell’Enciclopedia dantesca, Aristotele ha fissato nel Libro II della Metafisica il criterio in base al quale il rapporto che ciascun ente ha verso l’essere è analogo a quello che lo stesso ente ha nei confronti della Verità: “Tale criterio è fondato sull’affermazione che la conoscenza del vero si realizza a partire dalla conoscenza delle cause, e quindi il rapporto è inteso come dipendenza causale“, in altre parole, “la Verità è il fondamento (subiectum) di ciascun essere e insieme è la perfetta somiglianza della cosa com’è“. Ma questo statuto di Verità, questa similitudo tra Verità e oggetto-sostanza (confacente al significato che anche Nietzsche vorrà poi esibire), Dante li riconosce al Poeta, soggetto-eletto cui spetta la conoscenza delle cause in virtù dello strumento specifico, costitutivo, che è appunto la Lingua declinata nella sua forza originaria, come apparenza dell’apparenza, sogno del sogno, direbbe appunto Nietzsche: il Poeta è colui che divinizza la Lingua, la propria Origine, così la Commedia si fa e si proietta come rappresentazione-divinizzazione della Lingua.
Una Poesia che si attesta e si impone come scelta, atto di moralitade, punto di accordo, di congiunzione tra una istanza di verità e una istanza di moralità: poesia è nascita, evento tra scelte libere e consapevoli, è la nobile virtù che la ragione sussurra, conferita inizialmente da Dio, precisa Dante, ma liberamente scelta dall’uomo, chiamato a optare, a privilegiare la loda o il vituperio: E però è da sapere, secondo la sentenza del Filosofo nel terzo de l’Etica, che l’uomo è degno di loda e di vituperio solo in quelle cose che sono in sua podestà di fare o di non fare (Convivio III IV 6). E come scritto nell’Epistola a Cangrande, il fine, la finalità, il dato essenziale della Commedia, quindi dell’intera costellazione poetica dantesca, è removere viventes in hac vita de statu miseriae et perducere ad statum felicitatis.
Possiamo credere, giunti a questo punto, di star sorvolando quel delicato crinale lungo il quale la parola-guida di Dante si afferma e si rivela con maggior vigore, stretta com’è nella morsa, nella gravezza di un interrogativo: come passare dallo “statu miseriae” allo “statum felicitatis”? Un richiamo che fa risuonare il passaggio dalla Vita attiva alla Vita contemplativa postulato in Convivio IV XVII 11: «Che se moralemente ciò volemo esponere, volse lo nostro Segnore in ciò mostrare che la contemplativa vita fosse ottima, tutto che buona fosse l’attiva: ciò è manifesto a chi ben vuole porre mente a le evangeliche parole: Potrebbe alcuno però dire, contra me argomentando: poiché la felicitade de la vita contemplativa è più eccellente che quella de l’attiva, e l’uno e l’altra possa essere e sia frutto e fine di nobilitade, perché non anzi si procedette per la via de le virtù intellettuali che de le morali?».
Nessun dubbio, perciò, che Dante voglia tenere appaiate – in unitate – le virtù etiche, le virtù morali, più comuni e più richieste, con le virtù speculative, le virtù intellettuali – sapienza, scienza, arte – le prime specchiantesi nella vita attiva, le seconde confluenti nella vita contemplativa, dove la presunta, conclamata, eccellenza della seconda sulla prima consente di scivolare sul punto che più gli sta a cuore: «E così appare che nostra beatitudine (questa felcitade di cui si parla) prima trovare potemo quasi imperfetta ne la vita attiva, cioè ne le operazioni de le morali virtudi, e poi perfetta quasi ne le operazioni de le intellettuali. Le quali due operazioni sono vie espedite e dirittissime a menare a la somma beatitudine». (Convivio IV XXII 18)

È su tali premesse che il viaggio del Pellegrino-agens può trovare la “forza” di configurarsi come esperienza di conversione: precisa e chiara risuona l’avvertenza in Inferno I, “Non Enea, non Paulo sono”, nello “scandalo” di un Evento eccezionale che la mente presaga ha bene individuato: quel viaggio è concesso al viator Alighieri nell’anno 1300 dopo la venuta di Cristo, ed è concesso a lui soltanto, una impossibile scommessa da compiere sul medesimo terreno di Enea e di Paulo, che vuole dire: così si farà la mia nobilitate, proprio nell’oltrepassamento di entrambe le figure e le istanze che le due Figure richiamano.
Il personaggio che dice Io nella Commedia, studiato con filologica magnificenza da Gianfranco Contini, porge già nelle prime terzine i connotati dell’impresa impossibile, le coordinate metodologiche estetiche strutturali attraverso cui quel viaggio acquisterà valore e nobilitade. Non sono Paulo, non sono Enea, potrà dire Dante, dunque chi sono? Sono il soggetto “contemporaneo” di un divenire storico che si assume la chance, la possibilità – la consapevolezza – di fronteggiare l’uno e l’altro, e se possibile – se il “mandatario” celeste mi assegnerà (as-seconderà) autorevolezza e potere – di attraversare entrambi, stabilendo per la prima volta nella storia dell’Homo faber che le armi, e le funzioni, del fare poesia, del dire poesia, equivalgono a:
Morte, che fai piacere a questa donna,
per pietà, inanzi che tu mi discigli,
va da lei, fatti dire
perché m’avien che la luce di quegli
che mi fan tristo mi sia così tolta.
se per altrui ella fosse ricolta,
falmi sentire, e trarra’mi d’errore,
e assai finirò con men dolore.
Appunto, le Rime, le impressionanti Rime, che continuiamo a scoprire e studiare come fosse la prima volta come fossero apparse pochi giorni prima nel nostro firmamento di lettori accorti, al punto che forse non sarebbe affatto blasfemo riconsegnarle alla nostra memoria proprio come epilogo delle Tre Cantiche; le Rime, insomma, hanno già delineato il percorso futuro dell’Agens, mostrando, restituendo, il sentimento del Poeta, quindi tracce concrete e potentemente reali del significato dell’essere poeta e del fare poesia: le Rime ci mostrano l’officina dove si forgiano le armi del Viaggio che sta per avere inizio, come farà del resto Convivio, indicando le tappe che il Pellegrino deve rispettare prima di ideare e materializzare l’epifania del viaggio impossibile. Entrambi – Rime e Convivio – esibiscono il cuore-passione, il cuore-sentimento, che dispongono al far-si del Poema, esibiscono i perché della Vita Nova, il trasmutarsi del sentire come atto di potenza «E nell’una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta; e pareami che mi dicesse queste parole: “Vide cor tuum!”», di fronte alla ragione che predispone il cammino verso la Grazia, che spalanca i cancelli della Redemptio terris, della Redenzione in vita, con la premessa – che Dante non mancherà di ribadire – che Itinearium ad Deum è nello stesso tempo Itinerarium ad Poiesis.
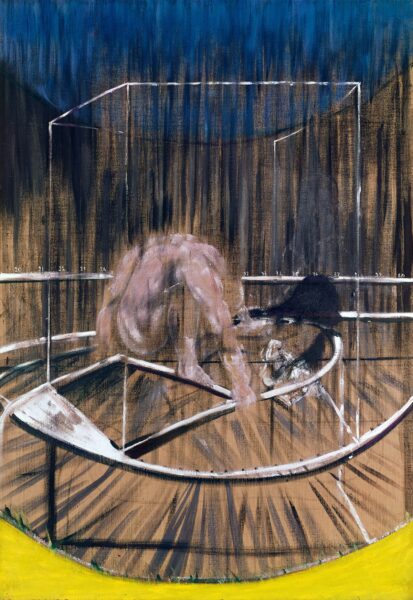
Giunti a questo stadio del cammino, bisogna intendere quale prezzo avrebbe, oggi, una inerte storicizzazione del dettato dantesco, il sottrarsi, come viaggiatori disincantati e casuali, alla conseguente idealizzazione/rivelazione che quel pensiero ancora pre-suppone e rilancia. Con la domanda: possiamo noi, sconsolati epigoni, percorrere il pensiero e il dettato dantesco nel distacco o nella dimenticanza della cornice/sostanza “rivelativa” del suo pensiero, rimanendo quindi, disancorati da quella traiettoria di “verità”, come se essa fosse a noi non appartenente o non congeniale? Insomma, al di là della magra, avvilente ricerca della cosiddetta “attualità” dantesca (sempre propugnata e forse mai trovata), che è inerte questione cronachistica, rimane il territorio della collocazione intellettuale e poetica di quel pensiero, rimane il divario tra pensiero storico e pensiero di rivelazione, sulle tracce del paradigma teorico che Luigi Pareyson aveva tracciato nell’anno ’71, nel libro il cui titolo già affermava una opportuna consonanza, Verità e interpretazione: due termini-limite della parabola dantesca (a tal proposito, è opportuno non trascurare le due Voci dedicate dell’Enciclopedia dantesca e Enciclopedia del Novecento, a firma, rispettivamente, di Alfonso Maierù e Hans-Georg Gadamer). Scrive Pareyson: «Separato dalla verità, il pensiero conserva, del suo carattere rivelativo, solo l’apparenza, cioè una vuota razionalità, i cui concetti debbono rinviare, per il proprio significato, all’altro aspetto del pensiero, cioè al suo carattere espressivo. Ma il divorzio fra la rivelazione della verità e l’espressione della persona, turbando l’intima costituzione della parola, produce uno sfasamento fra il discorso esplicito e l’espressione profonda: la parola dice una cosa ma ne significa un’altra. Per trovare il vero significato del discorso bisogna considerare il pensiero non per quel che dice ma per quel che tradisce, cioè non per le sue conclusioni esplicite, per la sua coerenza razionale, per l’universalità dei suoi concetti, ma per l’inconscia base che vi si esprime, cioè la situazione, il momento storico, il tempo, l’epoca».
E ancora: «La presenza della verità nella parola ha un carattere originario: è la scaturigine da cui rampolla incessantemente il pensiero, sì che ogni nuova rivelazione, più che avvicinarsi progressivamente a un’impossibile manifestazione totale, è la promessa di nuove rivelazioni… la parola significa per la sua fertile pregnanza, che oltrepassa la sfera dell’esplicito senza sminuirla, ma anzi irraggiandosene. Nel pensiero senza verità l’esplicito è così poco significativo che, dovendo cercare in altro il proprio significato, rinvia all’espressione nascosta dal discorso: comprendere in tal caso significa smascherare, cioè sostituire il sottinteso all’esplicito». (anche qui, come detto, sottolineature di mia responsabilità)
Asserzioni che, se lasciate scintillare nel contesto dell’operare dantesco, fanno apparire meno schematici o scolastici i quattro sensi che Dante promuove in Convivio II,1 e che val la pena rammentare: «Le scritture si possono intendere e deonsi esponere massimamente per quattro sensi. L’uno si chiama litterale, e questo è quello che non si stende più oltre che la lettera de le parole fittizie, sì come sono le favole de li poeti. L’altro si chiama allegorico, e questo è quello che si nasconde sotto ’l manto di queste favole, ed è una veritade ascosa sotto bella menzogna: sì come quando dice Ovidio che Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre a sé muovere… Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono intentamente andare appostando per le scritture, ad utilitade di loro e di loro discenti: sì come appostare si può ne lo Evangelio, quando Cristo salio lo monte per transfigurarsi, che de li dodici Apostoli menò seco li tre; in che moralmente si può intendere che a le secretissime cose noi dovemo avere poca compagnia. Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora sia vera eziandio nel senso litterale, per le cose significate significa de le superne cose de l’etternal gloria sì, come vedere si può in quello canto del Profeta che dice che, ne l’uscita del popolo d’Israel d’Egitto, Giudea è fatta santa e libera».
E dopo aver esultato, noi Lettori, presumendo che Dante volesse prelevare dai Testi Scritturali le dottrine dell’agire poetico, in analogus, in analogia (la parola ritorna) con i metodi previsti per l’insegnamento dei classici latini nei secoli XII e XIII, quindi applicando “alla lettura di quei testi gli stessi procedimenti allegorici impiegati per l’intelligenza del Vecchio Testamento“, la qual cosa vorrebbe dire e significare che i poeti pre-cristiani fossero preparati e autorizzati a svelare – rivelare – “profonde verità di carattere etico ed anche religioso, quasi preannunzio e prefigurazione del Cristianesimo” (argomento che, in un ipotetico sviluppo critico, sfocerebbe nell’uso che Dante fa dell’opera virgiliana, di colui che riconosce come “lo mio maestro e lo mio autore“: la Quarta Egloga virgiliana altro non sarebbe che una profezia dell’Incarnazione). Insomma, l’impulso ad andare oltre l’Integumentum o Involucrum, oltre il “manto favoloso dei loro miti, alla ricerca della verità che essi celavano e che era profondamente vicina alla rivelazione e ai fondamenti di una teologia filosofica ricca di echi e sfumature platoniche” (Cesare Vasoli), parrebbe opportuno presagio della Voce anagogico, che indica, appunto, “ciò che ‘conduce su’, ‘solleva’, e applicato all’ermeneutica biblica, della quale è termine tecnico, designa quel procedimento interpretativo (‘senso anagogico’), per il quale il testo delle Scritture, letto alla luce delle verità supreme, diviene uno strumento di superiore conoscenza. Dante stesso lo chiama sovrasenso“. (Tra parentesi: per la Voce “anagogico”, potrebbe ben figurare la puntualizzazione indicata da Francesco Tateo: “Il termine Anagogico (latino anagogicus) indica ciò che ‘conduce su’, ‘solleva’, e applicato all’ermeneutica biblica, della quale è termine tecnico, designa quel procedimento interpretativo (‘senso anagogico’), per il quale il testo delle Scritture, letto alla luce delle verità supreme, diviene uno strumento di superiore conoscenza).

E quindi: il Poeta è colui che produce sovrasenso? Un sovrasenso che sarebbe espressione di verità, che nasce attraversando la Verità, rimanendo a ridosso della verità, tenendola sulle ginocchia, per usare un’immagine appartenuta ad Arthur Rimbaud. Il Poeta è colui che sa, che sa oltre, che interpreta oltre, detentore perciò del pensiero rivelativo nell’accezione appunto ipotizzata da Pareyson. A cui si collega la presa d’atto ulteriore che nel primario concetto di Verità è contenuta la diretta filiazione con l’atto del conoscere, con la conseguenza che, dentro tale quadrilatero di ragioni ipotetiche, la verità non può che essere scelta, indirizzo di scelta, imbrigliata nella domanda prima del Poeta: che cosa scelgo di conoscere, dove dirigo il mio criterio di selezione finalizzato alla scoperta della differenza?
Domande a cui il Poeta dantesco risponderà innalzando superiori precetti, superiori doveri, con diretto riferimento alle Sacre Scritture, come la Passio del Cristo immolato e redento, raccogliendo dunque la forma-rivelazione del percorso “via, verità e luce“, come da Convivio II V 3: «’Lo qual fu luce che allumina noi ne le tenebre’, sì come dice Ioanni Evangelista, e disse a noi la veritade di quelle cose che noi sapere sanza lui non potavamo, né veder veramente», da cui segue l’investitura del poeta-veggente, messo in condizione – scoperto e svelato nell’atto – di trasfigurare.
Ciò che chiameremmo la qualità superiore dell’azione poetica la mette in campo, dunque, la poesia-sapienza, fissando i propri parametri nella libera andatura, nel libero transito tra Poesia e Filosofia, promuovendo, nella condizione ideale di scrittura, l’esercizio di Sapienza ovvero la prassi della conoscenza, ma poiché niente passa dalla potenza all’atto se non grazie a un ente in atto (Aristotele, Metafisica, citato in Monarchia I XIII 3), “è l’oggetto-sapienza che attua l’intelletto umano col suo lume-verità; in termini operativi, causa materiale della Filosofia è intendere – riguardare, speculare, contemplare; è quindi esercizio dell’intelletto che, se mosso dalla luce della verità (causa efficiente) e realizzato con amore disinteressato (causa formale), dà la felicità (causa finale). Per tal via l’amore per la sapienza trapassa nell’amore per la verità“.
È proprio nell’opposizione/antitesi Subietto-Forma che si installa, si posiziona – sostando – il Pellegrino dell’Intelletto prefigurato da Dante nel Convivio III, XI, 13-14-15: «E sì come la vera amistade, astratta de l’animo, solo in sé considerata, ha per subietto la conoscenza de l’operazione buona, e per forma l’appetito di quella; così la filosofia, fuori d’anima, in sé considerata, ha per subietto lo ‘ntendere, e per forma uno quasi divino amore a lo ‘ntelletto. E sì come de la vera amistade è cagione efficiente la vertude, così de la filosofia è cagione efficiente la veritade. E sì come fine de l’amistade vera è la buona dilezione, che procede dal convivere secondo l’umanitade propriamente, cioè secondo ragione, sì come pare sentire Aristotele nel nono de l’Etica; così fine della Filosofia è quella eccellentissima dilezione che non pate alcuna intermissione o vero difetto, cioè vera felicitade che per contemplazione de la veritade s’acquista». Con la conclusione seguente: «E così si può vedere chi è omai questa mia donna, per tutte le sue cagioni e per la sua ragione, e perché Filosofia si chiama, e chi è vero filosofo, e chi è per accidente».
Parole che attraversano il nostro sguardo di individui secolarizzati, riesumando una parola in voga alcuni decenni addietro: Dante ci racconta come si perviene alla felicitade intellettiva, ci indica che la Filosofia è “regina”, non “ancella” – “a fianco della colomba che è la teologia”, ribadisce che la contemplazione della verità è somma e perfetta felicità, una condizione di cui è simbolo la Donna Gentile, ci dice che il vero, assoluto amore di Sapienza si colloca oltre le singole scienze – investendo di conseguenza l’Arte – oltre la facoltà di creazione che spetta alla mens umana – da cui: la mente presaga del Dante profeta di conoscenza, perché essa, Sapienza, risiede massimamente in Dio, “somma sapienza e sommo amore e sommo atto“, è in lui “per modo perfetto e vero, quasi per etterno matrimonio“, e si accende nella nostra mente come riflesso della luce divina.
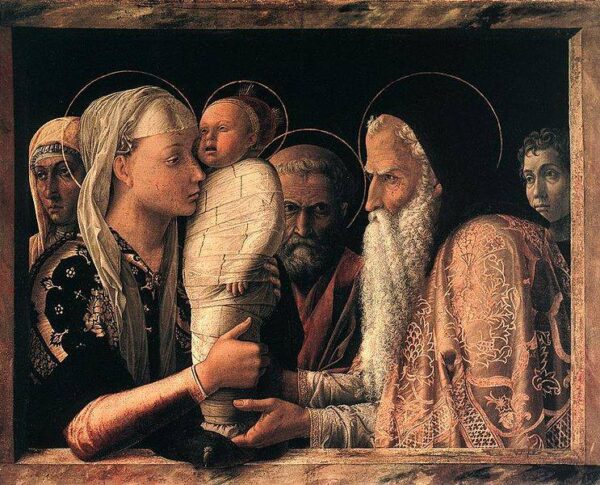
A questo punto il Poeta dantesco – che ha ormai profondamente compreso che esercizio di verità è esercizio di rivelazione, secondo quel precetto programmatico che trova in Paradiso XXII, 42 e in Paradiso IV, 124-126 due onde determinate (Colui che ‘n terra addusse / la verità che tanto ci soblima e Già mai non si sazia / nostro intelletto, se ‘l ver non lo illustra / di fuor dal qual nessun vero si spazia) – ha tutte le condizioni per agire: conosce le premesse e le conseguenze del compito cui (si) è “assegnato” – destinato – attestandosi, con lo sguardo attonito e consapevole, nell’incrocio di destino che molti secoli dopo annoderà, avvilupperà figure come Hölderlin, Mallarmé, Rimbaud, Rilke, Leopardi, Dino Campana, Paul Celan, Eugenio Montale, per citarne soltanto alcuni.
Il cui debito di ispirazione, o la cui promessa di contiguità, appaiono così poco “verosimili”, così poco “avvicinabili” alla titanica consistenza del fare dantesco, che varrebbe la pena osservare in filigrana a quali condizioni alcuni poeti del Novecento, del nostro secolo di appartenenza, hanno creduto di rendersi vicini, o quanto meno con quale “spirito” si sono appropinquati alla vertigine del Poeta-Primo: di Montale, per esempio, abbiamo tracce esaustive, la partecipazione all’importante Convegno Internazionale di Studi danteschi che si svolse a Roma nei giorni 8-10 aprile dell’anno 1965, nell’occasione delle Celebrazioni per il Settimo Centenario della nascita.
Montale parla di Dante come di un “poeta concentrico“, che “non può fornire modelli a un mondo che si allontana progressivamente dal centro e si dichiara in perenne espansione: perciò la Commedia è e resterà l’ultimo miracolo della poesia mondiale“. E proiettandosi verso una domanda finale che impressiona, oggi, non poco, Montale si chiedeva se la scrittura della Commedia fosse stata possibile “per una particolare congiunzione degli astri nel cielo della poesia” oppure se si fosse trattato di “un fatto miracoloso, estraneo alle possibilità umane“. Concertando con un dantista come Charles Singleton l’ipotesi che “non ci si può immaginare un Dante che invecchia e assiste al formarsi della sua controversa leggenda. Tuttavia posso tranquillamente considerare l’affermazione del Singleton che il poema sacro fu dettato da Dio e il poeta non fu che lo scriba“. Parole “profetiche” che di certo non facevano parte delle argomentazioni, palesi o dissimulate, del dantista americano ma che, stranamente, Montale sente l’esigenza di proporre, per poi precisare: “Purtroppo non posso citare che di seconda mano e mi chiedo se l’eminente dantista abbia inteso in senso letterale questo suo giudizio o se in esso si debba ravvisare solo il carattere ispirato e perciò ricevuto di ogni grande poesia“, concludendo con un ancora più sorprendente: “Neppure nella prima ipotesi io farei obiezioni e non avrei nessuna prova per contestare il carattere miracoloso del poema“.
Guardando oltre Montale, a noi spetta comunque rischiare un delicato tentativo di avvicinamento alla genesi del poema dantesco, ai “perché”, ai “come fu possibile”, quindi il tentativo di raccogliere – con urgenza imperiosa, pressante – il dettato dantesco nelle prossimità del nostro tempo, dove “nostro tempo” è il tempo della mia formazione, il tempo dei decenni cruciali del Novecento (secolo, da tale osservatorio, non certo “breve”), con tutte le conseguenze teoriche e teoretiche che si sono susseguite, che si sono scagliate, scaraventate sulla nostra condizione umana. E per rispondere a questo, vorrei inerpicarmi per le alte vette della giostra ermeneutica, trattare una questione parecchio ardua che chiama in causa, e in naturale antitesi, concetti che la filosofia novecentesca ha posto alla sommità del suo pensiero critico: intendo la questione Essere e Nulla, l’Essere e il Niente, osservare la possibilità di situarci – situazionarci, attestarci – nel mondo, di contro al non che contempla la negazione, generando il Niente, il Nulla, la Nientità, la Nientificazione. E rapportare poi questi elementi di analisi alla Parola Prima, quindi alla Verità, al concetto di “verità”.
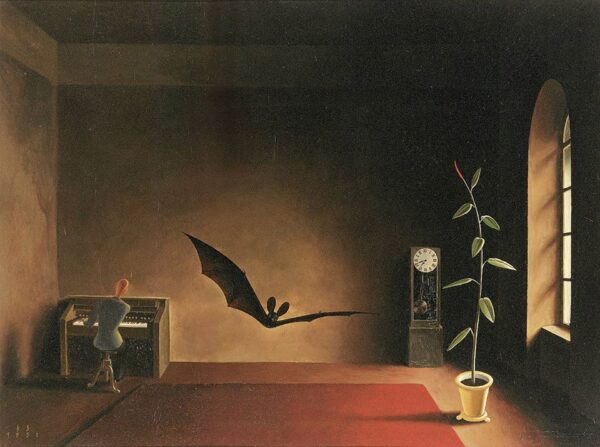
Si tratta di postulati che mostrano a piè di pagina firme illustri, ne cito due che in queste pagine abbiamo già incontrato, Martin Heidegger e Luigi Pareyson, sebbene ancor prima risale il nome di Leibniz, autore del Settimo paragrafo dei Principes de la Nature et de la Grâce con la domanda «Pourquoi il y a plutot quelque chose que rien», che sappiamo di poter tradurre con “Perché c’è l’essere piuttosto che il nulla“, giusto per ribadire e sottolineare che vorremmo sostare in un nuovo accampamento che collima con la fondazione dell’essere poetico, del far-si poeta, del far-si poesia: evento generativo e formativo della condizione umana. Che innesta sempre il ritorno al paradigma originario, instaurando la parola poetica come parola originaria che si pone davanti all’uso della Lingua e del Linguaggio, facendo della poesia un prius, un evento rivelativo della condizione di esistenza, poesia – insomma – come disvelamento dell’Essere.
È proprio a questa altezza, ostentando lo scudo della domanda fondamentale, raccogliendo le stimmate intellettuali del nostro procedere, avendo quindi accertato che non è lecito obliare in nessuna porzione del nostro esistere il percorso, a volte inesorabile, che ci conduce dove siamo, che ci conduce a esibire il “presente”, abitando e percorrendo un paradigma storico dove vige una progettualità “creativa” parcellizzata tra le varie pratiche di applicazione – poesia letteratura teatro cinema musica… è raccogliendo l’opera di Dante come altamente costitutiva e rivelativa di tale domanda, che ci poniamo nelle condizioni di meglio comprendere che cosa agitiamo e sovvertiamo del nostro perturbato “presente” ogni volta che sostiamo nei paraggi di quell’impegno “coscienzioso” che sovente abbiamo l’ardire o la presunzione di chiamare Arte.
Potrebbe darsi, insomma, che ponendoci di fronte al grave compito di “comprendere” la sconvolgente prismaticità dell’opera dantesca, si spalanchino davanti a noi, davanti al nostro sguardo, le domande che i filosofi hanno definito fondamentali, le domande che collimano con la storia dell’Essere, facendo riaffiorare sulla Scena l’offerta nativa. Promulgando due statuti del far-si Arte o del far-si Poesia: la Parola originaria, che è parola di rivelazione, e la parola mondana – storicamente “evidente”, storicamente “presente” – la parola-traccia del nostro esistente che si squaderna nel mondo divenendo storia, facendosi evento, orma della realtà dentro cui agiamo come autori/fruitori di rappresentazione. Avendo tacitato dal nostro destino di abitatori dell’Occidente la Parola-Prima – Primiloqium – la parola originaria, la parola come Origine, dimorando dentro quel contesto storico-evolutivo che per l’argomentare heideggeriano si compie e si risolve nell’orizzonte della storia della metafisica… dovremmo arguire che non accedendo ai primordi della parola-creazione, il nostro destino sarà – prevalentemente – l’utilizzo della parola generativa in una funzione meramente storica, quindi una parola-poesia mutilata e spesso resa inoffensiva (dove la “rappresentazione” – tema-rifugio dei nostri decenni novecenteschi – vale come esibizione dei nostri frammenti dentro una spirale fintamente “creativa” che sotto il mantello della “brillantezza” non di rado si mostra prevedibile e ripetitiva).
Se c’è un tema “probante” che il Novecento ha dovuto prendere in eredità dalla Sapienza delle origini, dall’archi-sapienza, attraversando la vastità della significazione e declinandola sia storicamente che filosoficamente, è proprio la storia dell’Essere nell’accezione heideggeriana, che vuole dire “senso dell’Essere”, quindi la presa istantanea della contrapposizione che aveva ravvivato la storica querelle, datata 1946, tra Heidegger e Jean Paul Sartre nella Lettera-pamphlet intitolata Lettera sull’umanismo: “Di altro non si tratta – scriveva Sartre – che della storia dell’Uomo” (Uomo-personaggio o Personaggio-uomo che nei suoi romanzi abbiamo imparato a conoscere nelle differenti incarnazioni, vedi La nausea, Il muro, L’età della ragione), affermazione che risolutamente Heidegger correggeva in “Di altro non si tratta che della storia dell’Essere“, indicando e rilanciando il dato originario che pre-esiste all’atto di creazione. E che il saggio del 1929, Che cos’è metafisica, porgeva dispiegando l’antica tesi “ex nihilo nihilo fit” che diventa “ex nihilo omne ens qua ens fit“, che significa semplicemente “Nel niente dell’esserci soltanto l’ente nella sua totalità giunge a se stesso, secondo la possibilità che gli è più propria, cioè in modo finito“, ed ecco svelata la proprietà del far-si poesia, del divenire poeta, per poi inquadrare, contestualizzare il tutto con queste parole: «In quanto esiste l’uomo accade il filosofare. Ciò che noi chiamiamo filosofia non è che il mettere in moto la metafisica attraverso la quale la filosofia giunge a se stessa e ai suoi compiti espliciti. La filosofia si mette in moto soltanto attraverso un particolare salto della propria esistenza dentro le possibilità fondamentali dell’esserci nella sua totalità. Per questo salto sono decisivi: anzitutto il fare spazio all’ente nella sua totalità; quindi il lasciarsi andare al niente, cioè il liberarsi dagli idoli che ciascuno ha e con i quali è solito evadere; infine il lasciare librare fino in fondo questo essere sospesi, affinché esso ritorni costantemente alla domanda fondamentale della metafisica, a cui il niente stesso costringe: Perché è in generale l’ente e non piuttosto il niente?».

Postulati, affermazioni, che graffiano, intaccano la carne dei nostri pensieri contemporanei: quando leggiamo della necessità o dell’urgenza di un particolare salto della propria esistenza e del liberarsi degli idoli che ciascuno ha, sembra proprio di ascoltare un vibrante richiamo ai nostri anni, pare di veder richiamata o riflessa l’angustia della nostra condizione intellettuale, noi soggetti del XX e XXI Secolo su cui grava il compito o la tentazione di produrre oggetti d’arte, quindi il nostro cercare a tentoni pretesti “creativi” nell’illusione che accendere i fatui bagliori di una idea sia già percorrere l’incognita vastità di percorsi generativi e costitutivi di quel divenire poesia-esistenza che Dante aveva predetto, quando insomma ci ostiniamo a celebrare le nostre opere come sentieri dell’altrove o del sogno o dell’illusione “artistica”, come fossimo davvero gli eredi designati di quella dinastia di antica civiltà e classicità, di segno greco-antico, che sapeva mescolare – far “interagire” – diremmo oggi – la cetra del dio Apollo all’informe caoticità del dio Dioniso, mentre noi, a conti fatti, restiamo autori e spettatori del naufragio dei nostri frammenti. Da qui l’importanza, la “necessità”, l’urgenza – che Dante raccoglie e percorre in un’opera come Convivio – di dover declinare insieme, connaturandoli, Poesia e Filosofia, lo spirito poetico immerso nella sapienza filosofica, “evento” che a noi dovrebbe risuonare, oggi, come postulato di verità, se non proprio condizione preliminare dell’impegno dell’autore-creatore, e non soltanto una ipotetica chance al servizio di un effimero stimolo “ispirativo”, attraverso il quale si rende possibile stabilire una priorità, aprire il sipario di una ipotetica Scena moderna che tende a far coincidere – a far corrispondere – l’apertura – ovvero la manifestazione dell’esserci – con la presa d’atto del nostro pensare l’Essere come Heidegger lo ha riconosciuto e proposto.
Questione uno: «Nel pensiero l’essere viene al linguaggio. Il linguaggio è la dimora dell’essere. Qui abita l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora. Il loro vegliare è il portare a compimento la manifestatività dell’essere; essi, infatti, mediante il loro dire, la conducono al linguaggio e nel linguaggio la custodiscono». Questione due: «Il pensiero non si fa azione perché da esso scaturisca un pensiero o una applicazione. Il pensiero agisce in quanto pensa. Questo agire è probabilmente il più semplice e nello stesso tempo il più alto, perché riguarda il riferimento dell’essere all’uomo. Ma ogni operare riposa nell’ente e mira all’ente. Il pensiero, invece, si lascia reclamare dall’essere per dire la verità dell’essere. Il pensiero porta a compimento questo lasciare». Questione tre: «Soggetto e oggetto sono denominazioni improprie della metafisica, che fin dall’inizio si è impossessata dell’interpretazione del linguaggio nella forma della ‘logica’ o della ‘grammatica’ occidentali. Ciò che si nasconde in questo accadimento, oggi lo possiamo solo sospettare. La liberazione del linguaggio dalla grammatica per una strutturazione più originaria della sua essenza tocca al pensare e al poetare. Il pensiero non è solo l’engagement dans l’action – l’impegno nell’azione – per e mediante l’ente, nel senso del reale della situazione presente. Il pensiero è l’engagement – l’impegno – per e attraverso la verità dell’essere, la cui storia non è mai passata, ma sta sempre per venire. La storia dell’essere sostiene e determina ogni condizione e situazione umane».
Sono proprio le trame concettuali che, sotto certi aspetti, stavamo cercando da quando abbiamo iniziato a gravitare nel cosmo dantesco, le parole attraverso le quali, prende avvio, prende corpo l’oltrepassamento delle ragioni della filosofia e si apre, si spalanca uno spazio assoluto dove cammina vive e opera il soggetto poetante. Quando leggiamo “Il pensiero si lascia reclamare dall’essere per dire la verità dell’essere“, oppure: “La liberazione del linguaggio dalla grammatica per una strutturazione più originaria della sua essenza tocca al pensare e al poetare“, quale Nome rimbalza nel nostro cosmo di lettori accorti, partecipi, sensibili, adulti, se non il Nome di colui che ha saputo tenere in equilibrio, in bilico, la molteplicità delle istanze, il far-si poeta come cammino insieme di storia e di esistenza?
Se volessi apporre una nota fatua, a margine di tale invocazione, scriverei che il titolo nietzscheano La nascita della Tragedia dallo spirito della Musica in Dante diventa La nascita della Commedia dallo spirito della Totalità. E senza perdere di vista la prospettiva, i passaggi, nei quali la critica oltrepassa le ragioni stesse della filosofia per cercare dimora nello spazio del “poetare”; senza mai trascurare che è in virtù dell’esperienza filosofica che arriviamo a comprendere razionalmente cose che senza di essa apparirebbero forse ignoti miracoli di un anonimo o indeterminato ingegno creativo. Non bisogna camminare troppo o sapere troppo dei centri gravitazionali danteschi per arguire la potenza risolutiva che l’apparato filosofico studiato da Dante riflette nella sua opera, basterebbe rammentare che la svolta operata e messa in atto grazie all’introiettarsi nel pensiero dantesco dello spirito filosofico-militante (nella doppia valenza di Filosofia e pensiero poetante), si dispone in forme così radicali da presuppore l’allontanamento dal proscenio della stessa Beatrice, la quale si ritrova per la prima volta, dopo l’impeto della Vita Nova, “oscurata”, marginalizzata, definita minore amica, prima che la Commedia le restituisca, in virtù delle nuove conformazioni filosofico-dottrinarie, le stimmate della gloria imperitura.
Il Dante che si trova a suo agio dove Ella – la Filosofia – «si dimostrava veracemente, cioè ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de li filosofanti», ha risolutamente centrato e concentrato ogni risorsa poetico-filosofica nell’Amore e nel dominio dell’Intelletto senziente, tenendo fede al precetto aristotelico secondo cui “L’uom si dee traere a le divine cose quanto può” (Convivio IV XIII 8), dove il “traere a le divine cose” sta per traere all’amor di sapienza e al filosofico poetare. La Filosofia è dunque espressione massima di Amore sapienzale, come già detto in Convivio III, XIV 6-8, “là dovunque questo amore splende, tutti li altri amori si fanno oscuri e quasi spenti, imperò che lo suo obietto eterno improporzionalmente li altri obietti vince e soperchia. Per che li filosofi eccellentissimi ne li loro atti apertamente lo ne dimostraro, per li quali sapemo essi tutte l’altre cose, fuori che la sapienza, avere messe a non calere“. Che significa: tutte le altre cose lasciate dileguare, nell’oblio o nella noncuranza.

Precetto non certo trascurabile, che ci invita anzi a rileggere, con accurata selezione, le parole di Convivio II, XII, 1-9: «E però, principiando ancora da capo, dico che, come per me fu perduto lo primo diletto de la mia anima, io rimasi di tanta tristizia punto, che conforto non mi valeva alcuno … e misimi a leggere quello non conosciuto da molti libro di Boezio… E avvegna che duro mi fosse ne la prima entrare ne la loro sentenza, finalmente v’entrai tanto entro, quanto l’arte di gramatica ch’io avea e un poco di mio ingegno potea fare; sì come ne la Vita Nova si può vedere. E sì come essere suole che l’uomo cercando argento… trovai non solamente le mie lagrime rimedio, ma vocabuli d’autori e di scienze e di libri: li quali considerando, giudicava bene che la filosofia, che era donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, fosse somma cosa. E imaginava lei fatta come una donna gentile, e non la poteva immaginare in atto alcuno, se non misericordioso; per che sì volentieri lo senso di vero la mirava, che appena lo potea volgere da quella. E da questo imaginare cominciai ad andare là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de li filosofanti: sì che in picciol tempo, forse di trenta mesi, cominciai tanto a sentire la sua dolcezza, che lo suo amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero. Per che io, sentendomi levare dal pensiero del primo amore a la virtù di questo, quasi maravigliandomi apersi la bocca nel parlare de la proposta canzone, mostrando la mia condizione sotto figura d’altre cose: Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete».
Quale nuova consistenza, quale nuova visione della parola “amore” affiora dai versi di questa Canzone, tra le più celebrate, complesse, “oscure”, della prima fase dantesca. Apprendiamo che la Filosofia, la parola-filosofia, ha il potere – la virtù – di annullare ogni altro pensiero, di cancellare le lacrime dal volto del pellegrino affranto, accendendo vocabuli d’autori e di scienze e di libri, secondo un’accezione che parrebbe rovesciata rispetto alle peripezie di Vita Nova: Amore, ora, è Intelletto senziente che modifica, trasforma – rinnova – il paradigma del desiderio-pathos, capovolgendo la scena di Dolce Stil Novo, progettando le mutate condizioni del fare arte-poesia: «Filosofia per subietto materiale qui ha la sapienza, e per forma ha amore, e per composto de l’uno e de l’altro l’uso di speculazione. Onde in questo verso che seguentemente comincia: In lei discende la virtù divina, io intendo commendare l’amore, che è parte della filosofia. Ove è da sapere che discender la virtude d’una cosa in altra non è altro che ridurre quella in sua similitudine… Così dico che Dio questo amore a sua similitudine reduce, quanto esso è possibile a lui assimigliarsi… E ciò si può fare manifesto massimamente in ciò, che sì come lo divino amore è tutto etterno, così conviene che sia etterno lo suo obietto di necessitate, sì che etterne cose siano quelle che esso ama. E così face a questo amore amare; ché la sapienza, ne la quale questo amore fere, etterna è. Ond’è scritto di lei: “Dal principio dinanzi da li secoli creata sono, e nel secolo che dee venire non verrò meno”; e ne li proverbi di Salomone essa Sapienza dice: “Etternalmente ordinata sono”; e nel principio di Giovanni, ne l’Evangelio, si può la sua etternitade apertamente notare. E quinci nasce che là dovunque questo amore splende, tutti li altri amori si fanno oscuri e quasi spenti, imperò che lo suo obietto etterno improporzionalmente li altri obietti vince e soperchia. Per che li filosofi eccellentissimi ne li loro atti apertamente lo ne dimostraro, per li quali sapemo essi tutte l’altre cose, fuori che la Sapienza, avere messo a non calere». (Conv III XIV 1-9)
Parliamo quindi di “amore”, quando parliamo della ricerca di una Lingua originaria poetica che dovrebbe essere alla base delle nostre ambizioni creative, concetto che diviene ancora più precipuo se lo avvolgiamo nella materia concettuale heideggeriana, estraendola ancora dalla Lettera sull’umanismo: «Il pensiero, detto semplicemente, è il pensiero dell’essere. Il genitivo vuol dire due cose. Il pensiero è dell’essere in quanto fatto avvenire (ereignet) dall’essere, all’essere appartiene. Dire che il pensiero è, significa dire che l’essere si è ognora preso a cuore destinalmente la sua essenza. Prendersi a cuore una “cosa” o una “persona” nella sua essenza vuol dire amarla, volerle bene. Pensato in modo più originario, questo volere bene significa donare l’essenza». (E poche righe prima: «Il pensiero è nello stesso tempo pensiero dell’essere in quanto appartenendo all’essere, è all’ascolto dell’essere. Appartenendo all’essere in quanto ne è all’ascolto, il pensiero è ciò che è in base alla sua provenienza essenziale»).
Nessun dubbio, quindi, che in Dante la questione amore, innestata e risolta sulla pianta Filosofia, viene inserita dentro un circuito problematico che ha al centro Intelletto e Sapienza, con questa accortezza: «La Filosofia, fuori d’anima, in sé considerata [cioè, senza riferimento a chi la possiede], ha per subietto lo ‘ntendere, e per forma uno quasi divino amore a lo ‘ntelletto, che sua cagione efficiente è la verità e fine».
“Volere bene significa donare l’essenza”, quindi “far essere“, costituire l’essere, mentre Dante, da canto suo, ci fa intendere che l’essenza dell’essere è il poetare, il far-si poeti, è il dispiegare l’essenza attraverso la poiesis. Rimane da stabilire un dato: la “poesia” è combinazione di virtù intellettuali di cui Dante pare riconoscere la “superiorità oggettiva”, virtù intellettuali che discendono dalla virtù della contemplazione, come in Conv IV, XVII: «Veramente è da sapere che noi potemo avere in questa vita due felicitadi, secondo due diversi cammini, buono e ottimo, che a ciò ne menano: l’uno è la vita attiva, e l’altra la contemplativa; la quale avvegna che per l’attiva si pervegna, come detto è, a buona felicitade, ne mena ad ottima felicitade e beatitudine, secondo che pruova lo Filosofo nel decimo de l’Etica (…) Che se moralemente ciò volemo esponere, volse lo nostro Segnore in ciò mostrare che la contemplativa vita fosse ottima, tutto che buona fosse l’attiva: ciò è manifesto a chi ben vuole porre mente a le evangeliche parole». E in Conv III, XV: «E qui si conviene sapere che li occhi de la Sapienza sono le sue demonstrazioni, con le quali si vede la veritade certissimamente; e lo suo riso sono le sue persuasioni, ne le quali si dimostra la luce interiore de la Sapienza sotto alcuno velamento: e in queste due cose si sente quel piacere altissimo di beatitudine, lo quale è massimo bene in Paradiso. Questo piacere in altra cosa di qua giù essere non può, se non nel guardare in questi occhi e in questo riso. E la ragione è questa: che, con ciò sia cosa che ciascuna cosa naturalmente disia la sua perfezione, senza quella essere non può l’uomo contento, che è essere beato; ché quantunque l’altre cose avesse, sanza questa beatitudine rimarrebbe in lui desiderio: lo quale essere non può con la beatitudine, acciò che la beatitudine sia perfetta cosa e lo desiderio sia cosa defettiva; ché nullo desidera, quello che ha, ma quello che non ha, che è manifesto, difetto. E in questo sguardo solamente l’umana perfezione s’acquista, cioè la perfezione de la ragione, de la quale, sì come di principalissima parte, tutta la nostra essenza depende; e tutte l’altre nostre operazioni – sentire, nutrire, e tutto – sono per quella sola, e questa è per sé, e non per altri; sì che, perfetta sia questa, perfetta è quella, tanto cioè che l’uomo, in quanto ello è uomo, vede terminato ogni desiderio e così è beato. E però si dice nel libro di Sapienza: Chi getta via la sapienza e la dottrina è infelice».
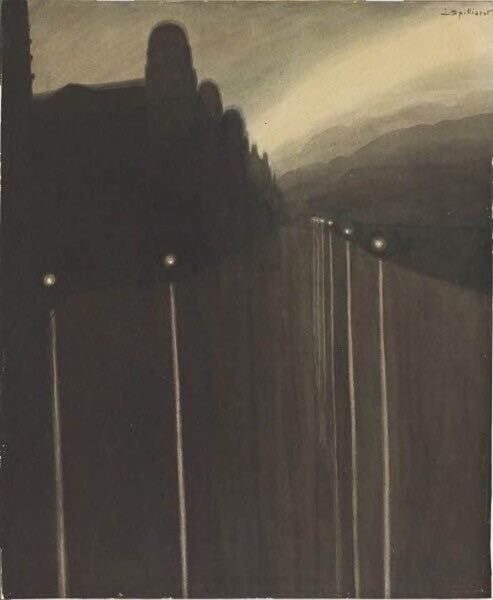
Concludo qui, su queste Note, la Parte prima o Tempo primo dello studio iniziato nel 2020, a ridosso del Settecentesimo Anniversario della morte del “divin poeta”, con la promessa di raggiungere – nel Tempo secondo – una questione di importanza non secondaria, suscitatrice di squisite passioni ermeneutiche mai sopite. Mi riferisco allo studio e all’interpretazione dell’opera dantesca, al lungo viaggio mai concluso e che mai avrà termine, alla mirabolante avventura che ha accompagnato nei secoli la lettura critica delle opere attribuite all’auctor Dante Alighieri, quindi la meticolosa ossessiva virtuosa dedizione di alcuni grandi Interpreti che ha consentito e consente, a noi lettori e appassionati indagatori di quel dettato, di “intendere”, constatare, la sconcertante vastità e profondità dell’Opera, rivelandone le ampie, titaniche latitudini dentro cui si è attestata.
Che equivale poi a domandarsi – sostanzialmente – quali sono le “modalità” – poetiche e strutturali – che consentono all’opera di Dante di sorgere e risorgere e al suo autore di vivere innumerevoli “vite” (come opportunamente evidenziano Elisa Brilli e Giuliano Milani nel volume Vite Nuove. Biografia e autobiografia di Dante, apparso nel 2021).
Sappiamo bene che senza i grandi Lettori Interpreti, disvelatori e commentatori di ogni atomo-particella dell’epopea dantesca, non conosceremmo né la superfice né la profondità di quella Espressione, nel cui “ritmo” convergono traiettorie molteplici, dove accanto alla Poesia declinata come virtù suprema si attua la confluenza di scienza e sapienza, quel “saggismo” di alto lignaggio che auspicava Robert Musil per la propria opera, un “saggismo” che consentiva già a Dante – nato nel 1265 – di offrire ambigua residenza finanche a postulati “misterici”, come il 910 e cinque, che ha fatto impazzire non poco gli esegeti, incerti nello stabilire se quella formula fosse scaturita da una scintilla esoterica oppure fosse uno dei tanti “enigmi” che Dante non di rado, e con un’oncia di perfidia, esibiva al Lettore.
Anche per Dante, forse, potrebbe valere l’aforisma-frammento postumo dell’anno 1887, vergato da Friedrich Nietzsche, che dice: «Che cosa può soltanto essere la conoscenza? “Interpretazione”, non “spiegazione”».
Nel viaggio che si annuncia non potranno mancare, né essere trascurati, i nomi e le gesta di grandissimi Interpreti che hanno saputo gettare lo scandaglio analitico in ogni profondità e rischiarare zone un tempo inaccessibili: i Nomi sarebbero tanti, ciascuno ha i propri “dantisti” da consultare periodicamente, per quanto mi riguarda, volendo indicare le letture privilegiate, il mio tributo va a Teodolinda Barolini, Emilio Pasquini, Michelangelo Picone; Marco Ariani, Guglielmo Gorni, Corrado Bologna, Pier Vincenzo Mengaldo; Enrico Malato, Robert Hollander, Georges Gunthert, Osip Mandelstam, Edoardo Sanguineti, Cesare Vasoli, John Freccero, Robert Hollander, Giuseppe Ledda, Donato Pirovano, Carlo Sini; oltre agli studiosi-interpreti che nella Parte prima hanno già trovato un preciso cenno: Erich Auerbach, Gianfranco Contini, Bruno Nardi, Charles Singleton, Nomi che ritroveremo con marcata forza nella Parte seconda (e senza, tuttavia, mai trascurare quell’Opera che a tutti è appartenuta, muovendo i primi e i secondi passi: la Enciclopedia dantesca, la cui prima edizione risale al 1970).
Una notazione particolarissima e affettuosa mi preme esprimerla per Jacqueline Risset, la dantista di Lingua francese che in un giorno dell’anno 1985 ci svegliò dal torpore intonando questi versi:
Au milieu du chemin de notre vie
je me retrouvai par une forêt obscure
car la droite vie était perdue.
(“Dante. La Divine Comédie, L’Enfer: Traduction, introduction et notes“). Seguirono, a distanza di pochi anni, il Purgatorio e il Paradiso. Apprendemmo note e dettagli che non conoscevamo. Jacqueline ci guidava dentro un tornante di alto rischio, come lei stessa specificava: “Traduire Dante est une opération risquée; mais le traduire en français l’est plus encore“. E citava l’autore settecentesco che esattamente due secoli prima aveva compiuto la medesima operazione, Antoine Rivaroli, noto come il Conte di Rivarol, nato nella Linguadoca ma proveniente da una famiglia di origine italiana, residente nelle colline piemontesi: “Il n’est point de poète qui tende plus de pièges à son traducteur: c’est presque toujours des bizarreries, des énigmes ou des horreurs qu’il lui propose: il entasse les comparaisons le plus degoutantes, les allusions, les termes de l’école et les expressions les plus basses: rien ne lui parait méprisables, et la langue francaise, chaste et timorée, s’effarouche à chaque phrase“.
Ce n’è a sufficienza, come si può vedere, per affrontare il grande tema del Tradurre Dante, muovendo proprio dal pregevole impegno “militante” compiuto dalla francesista che aveva scelto l’Italia, Roma, come sua dimora (il “caso” Risset risospinge sul proscenio dell’Oggi le due domande: come tradurre Dante e perché tradurre Dante, questioni che in Francia, nella prima metà del secolo, erano state accennate e discusse dal dantista André Pézard).
Ecco, quindi, che il dantismo, la storia novecentesca del dantismo, potrebbe costituirsi come “forma” del pensare, avvolta dentro un sistema di relazioni e di intrecci di carattere storico e critico, quindi genealogico, alle cui pendici staziona il postulato della “verità”, che nell’accezione positiva – costruttiva, ideativa – definisce lo statuto ontologico dell’essere, opposta a “errore”, “falsitade”, “menzogna”: «la verità è il fondamento “subiectum” di ciascun essere e insieme è la perfetta somiglianza della cosa com’è».
Porre dunque in relazione, in rapporto costitutivo, l’essere dantesco con la verità cui quell’Opera conduce (o allude), il “che cos’è” dell’opus dantesco in relazione con la veritas: l’obiettivo diventa quello di salvaguardare l’uomo dantesco, mantenerlo in presenza attiva, sistemarlo nella clessidra della Storia a noi contemporanea, fedeli ad un altro ammonimento nietzscheano: “Non mi interessa questa o quella filosofia: mi interessa che la mia specie non si estingua“.
Se poi seguiamo il preciso tracciato che lo stesso Dante ha percorso nel Convivio per configurare il fattore Verità, come lo chiamerebbe Jacques Derrida, scopriamo che “essa è la nona virtù etica, la quale modera noi dal vantare noi oltre che siamo e da lo diminuire noi oltre che siamo, in nostro sermone” (Cv IV XVII 6); quindi, come scriveva Alfonso Maierù per la voce omonima della Enciclopedia dantesca, “è il giusto mezzo che regola il ‘parlare di sé’ secondo il debito riconoscimento del proprio essere“. E poiché viviamo in un’epoca che senza pudore sopravaluta qualsiasi accensione di creatività, la Veritas in accezione dantesca consentirebbe di addivenire ad una severa disanima del “che fare“, avendo di mira giustappunto le turbolenze culturali e politiche del nostro presente.
Il passaggio al Tempo secondo, tuttavia, significherà anche dischiudere uno squarcio efficace e, spero, rigoroso in merito alle scelte editoriali che le case editrici italiane hanno compiuto, in particolare negli anni dal secondo Dopoguerra ad oggi. Capitolo non ancora esaminato, che potrebbe convincere alcuni Editori italiani a progettare nuovi circuiti di offerta dantesca, nuove linee editoriali, focalizzando – e mi riferisco alla Commedia – Canti e/o Personaggi intorno ai quali sprigionare un’attenzione critica “minimale” e circoscritta oppure raccogliendo con naturale caparbietà il circolo ermeneutico che su quel Canto o quel Personaggio si è depositato.
Perché – forse – il compito che ci attende – oggi, ancora oggi – l’impegno dell’Individuo novecentesco divenuto soggetto-interprete dell’avventura dantesca, è prendersi cura della configurazione e azione del primato della Conoscenza, da declinare nella pluridimensionalità dei “saperi”, senza timori reverenziali, in opposizione rigorosa alle pratiche culturali che inneggiano ed esaltano la presunta “globalizzazione” – l’essere “connessi” sempre e comunque. Se l’interazione-globalizzazione designa l’indistinto procedere verso pratiche digitali che schizzano a raffica pulsioni, plasmando a ripetizione immagini raggelate, la prismaticità del Sapere è invece il movimento del pensiero che si fa, si compie riconfigurando – potenziando – gli archivi della memoria con lo scopo di scoprire, instaurare, una tavolozza dei “saperi” dentro una spirale di nichilismo attivo che scarta immediatamente effimere o fuorvianti tentazioni.
Il Dante interpretato pervicacemente, quindi “disvelato”, reso “possibile” dalla lunga tradizione novecentesca – che diverrà titolo e nucleo della Parte Seconda di questo percorso ricognitivo; il Dante che i grandi Interpreti hanno consentito a Noi di lumeggiare, oggi può e forse domanda di essere partecipe di un ampio gioco di suggestioni incroci e rimandi critici, un montaggio di attrazioni “sapienziali” che intreccia cattura interseca le domande fondamentali. E che chiede a noi, incerti epigoni, di rimanere dalla parte della “fede”, lungo un percorso che diverrebbe perciò unico; sarebbe dentro questa voragine dell’Unico che andrebbero cercati e indagati sia la “completezza” del senso che il possibile scacco, il non compimento del “percorso”, la parzialità tragica con cui costantemente siamo e saremo chiamati a misurarci.
A noi spetta circumnavigare tra le istanze – diverse o disparate – che hanno fatto parte della linea di condotta di questi decenni di ricerca (oltre che di meditate, sofferte bibliografie), tentando una possente ri-composizione sotto il segno o l’alveo di studi e di studiosi che per noi hanno generato la piattaforma-base sulla quale programmare la rotta. A questo proposito si potrebbe supporre, con delicata forzatura, che chi studia Dante è atteso, nella moltitudine di letture da compiere, anche da quel libro di Walter Benjamin che in tedesco suona Über den Begriff der Geschichte e in italiano Tesi di filosofia della storia. Libro-cardine, che potrebbe fare da viatico ai prossimi anni, una volta stabilito il primato del Jetzteit, Tempo-Ora, inteso come “modello di temporalità disomogenea, avulsa dalla linearità delle scienze naturali, e piena, in quanto solcata dalle tensioni dell’attualità e del presente storico” (Giulio Schiavoni).
Giusta, esemplare ricompensa per chi si è riconosciuto nell’attesa di un tempo messianico, che ha intravisto nell’incedere spasmodico del tempo storico, nella sua accelerazione in senso modernista, il sopravvenire tacito della catastrofe prossima imperitura.
Ci attende, quindi, a certe condizioni ancora da definire, il Dante dei rimandi e delle restituzioni, la presa d’atto – o di “possesso” – del Tempo-Ora dei personaggi che abbiamo visto transitare nella costellazione storica e cosmologica di appartenenza: Provenzan Salvani, Casella, Farinata, Piccarda Donati, Cacciaguida, per citarne soltanto alcuni, saranno prodomi di una scintilla che in lingua tedesca ha nome Eingedenken, in lingua italiana immemorare, verbo sostantivato il cui oggetto è “l’affiorare di una potenzialità che attende ancora di essere realizzata; non un che di ricordabile in quanto già avvenuto, bensì un’esigenza che non ha ancora trovato modo di attuarsi” (Stefano Marchesoni). Come se… una scintilla di redenzione di colpo, sovvertisse il loro destino storico.
Lo stesso Dante ne fa esperienza diretta, nel Canto più invocato e temuto dell’Inferno, il Canto Quinto, l’apparizione di Francesca da Rimini, la confessione, in fondo alla quale pare di intravedere l’Einbruch distruttivo-redentivo del Messia, che è forse la percezione che il pellegrino Alighieri sente vibrare sottotraccia, il fremito del passato che riesplode: uno dei pochi momenti che vedono il pellegrino muto, tra “tristitia e misericordia”, inadeguato a pronunciar parole (“Il dolore dei vinti acquista nel mondo storico uno splendore che si accende nell’atto della rammemorazione” (Fabrizio Desideri).
Come aveva intuito precocemente l’amico di Benjamin, Gershom Scholem, l’Evento messianico “è un giorno di catastrofe” (Benjamin avrebbe detto: il “salto” che scardina il presente) e coincide con una Fine cataclismatica, dolorosa (i “dolori del parto del Messia”), terrificante e pericolosa. «La redenzione non è l’esito di uno sviluppo immanente […]. Si tratta piuttosto di una irruzione della trascendenza nella storia, un’irruzione in cui la storia stessa sprofonda, trasformandosi in questo tramonto».
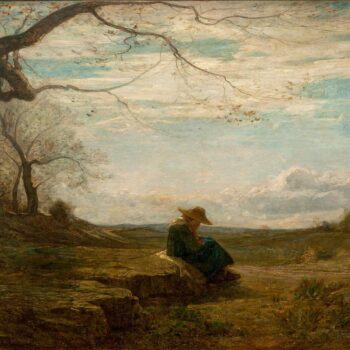
In conclusione, mi preme ricordare, illuminando un varco di natura personale, che questo Testo corre parallelo ad un ciclo di trasmissioni radiofoniche concordate con Rai Sardegna, da me scritte e realizzate nella Sede Rai di Cagliari: La Commedia di Dante raccontata e commentata in Lingua sarda, un progetto che si dispiega per 36 Stanze, che si avvale della traduzione delle terzine dantesche nella Lingua del “sardo illustre” – il logudorese letterario – di Padre Paolo Monni, resa pubblica in tre volumi, negli anni 2000-2003, dalle Edizioni Della Torre.
Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero,
ché ‘l velo è ora ben tanto sottile,
certo che ‘l trapassar dentro è leggero.
(Purgatorio 8, 19-21)
Lettor, tu vedi ben com’io innalzo
la mia matera, e però con più arte
non ti maravigliar s’io la rincalzo.
(Purgatorio 9, 70-72)
(Aprile 2020/Luglio 2025)
Vedi anche:
«Parole mie che per lo mondo siete». L’Inferno di Dante raccontato in Lingua sarda
Perché non possiamo dirci artisti

4 Commenti. Nuovo commento
Un magnifico e complesso percorso nella cultura europea, Dante è causa e pretesto per una rara sintesi del pensiero occidentale. Complimenti!!!
Mi saprebbe dire se e dove sia possibile ascoltare il suo Dante in lingua sarda?
Grazie davvero per la “sintesi” efficace e per il riferimento al Dante in Lingua sarda. Le prime Sei Stanze del “Paradiso” – “A bider fattos chi contare” – sono andate in onda da domenica 15 giugno a domenica 20 luglio. È possibile ascoltarle su Rai Play Sound. (Link: https://www.raiplaysound.it/programmi/abiderfattoschicontare?).
Grazie davvero per la sua sollecitudine, ho seguito il link e ho trovato solo le ultime tre puntate del ciclo del Paradiso, come mai? Le prime tre puntate? I cicli dell’Inferno e del Purgatorio?
Ho comunque ascoltato la quarta puntata e ne sono rimasto affascinato e avvinto, trovavo Dante classicizzato e lontano, il suo lavoro lo rende “contemporaneo”.
Caro, esperto navigante dei Mari del Sapere, scopritore di nuove rotte e terre inattese, mi sono imbarcato senza paura e fiducioso dei miei mezzi sul mio modesto sloop, a seguire la scia del tuo magnifico veliero lucido di ottoni e levigati legni, in rotta verso ancora non note Encantadas.
Il primo mare e i venti che lo increspavano facevano sì di tanto in tanto tremare l’unica mia vela, ma ancora tenevo la rotta seguendo a vista la strada sicura che tracciavi, mentre impercettibilmente ma fatalmente su di me prendevi vantaggio, lontanando verso orizzonti siderei.
Qualche isola ancora mi riusciva di riconoscere, poi ignote, isolate cime emergenti dalle acque, che i tuoi fantastici portolani componevano sicuri in arcipelaghi a te familiari ed amici, mentre nella mia vecchia carta nautica sbiadita non trovavano riscontri se non come avamposti di terre lontane, irte di “Hic Sunt Leones”.
E a notte innumeri astri, a te costellazioni amiche e guide del tuo andare, per me immensità spaurente di luci lontane ed enigmi di vertiginosa profondità.
Confesso, a mezzo il viaggio ho invertito l’andare e fatto rientro al familiare approdo, nel timore di scogli ostili o di smarrimenti fatali.
Nella mia cabina resta però il tuo scritto affascinante come livre de chevet a me caro, testimone di amicizia che temo immeritata e del cui dono ti sono grato.
Nel suo mare mi saranno dolci i naufragi.