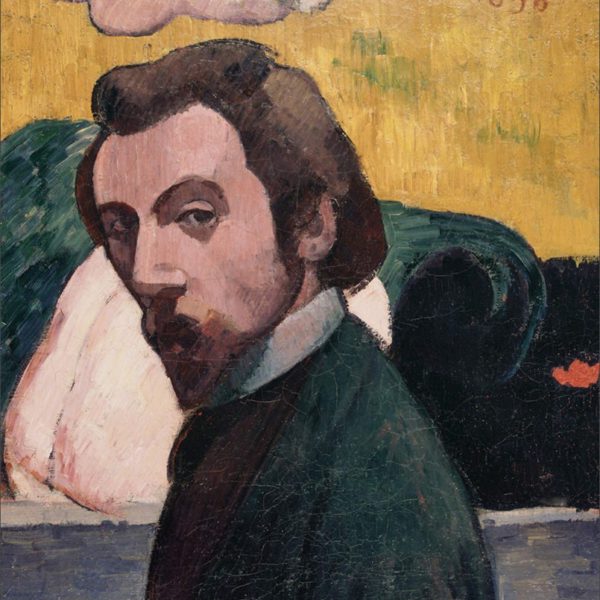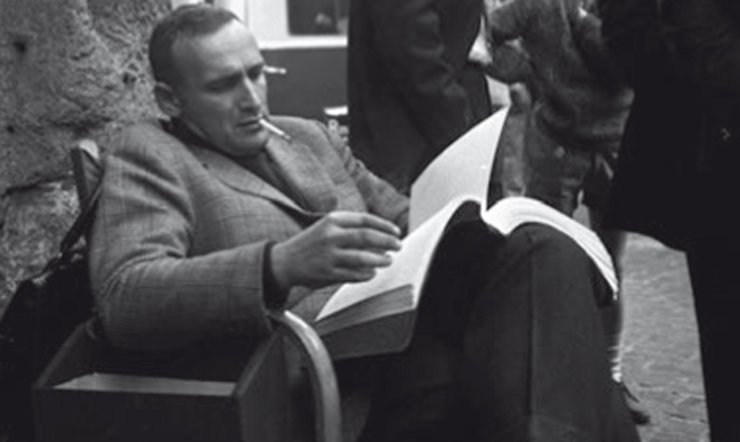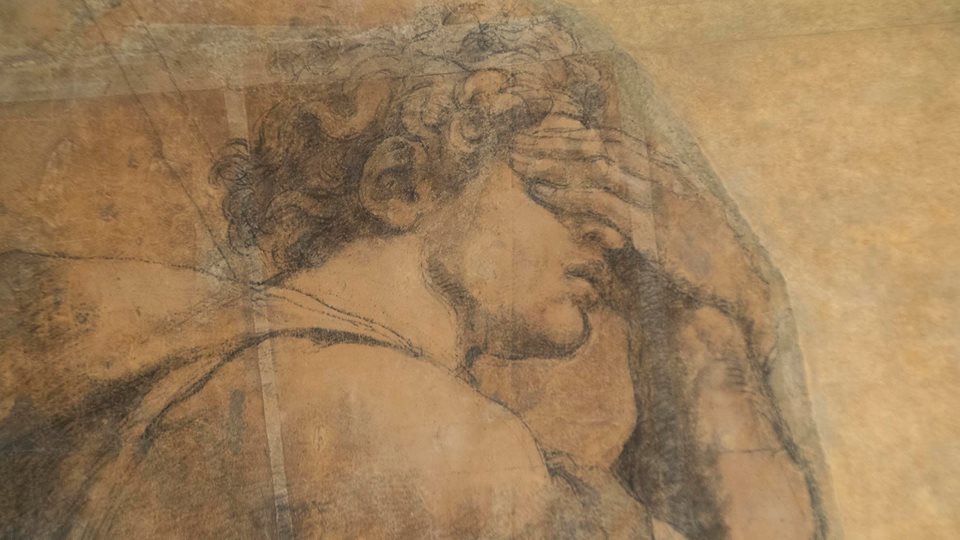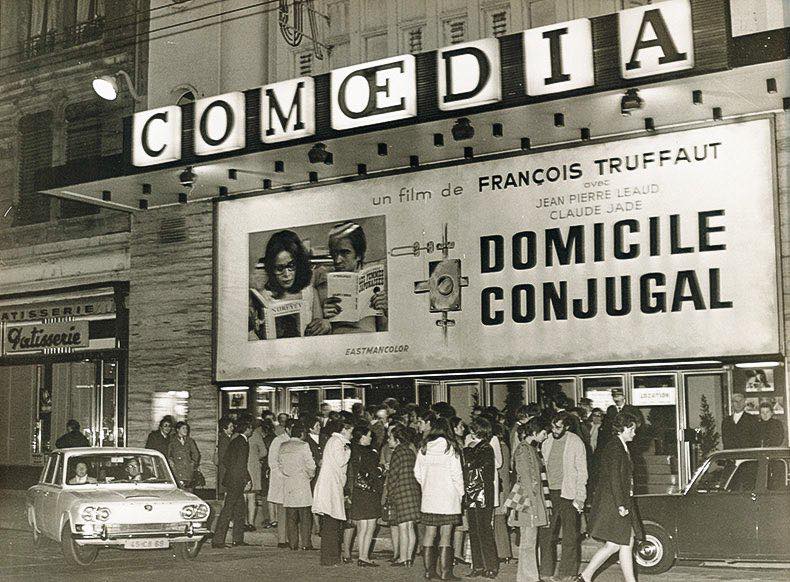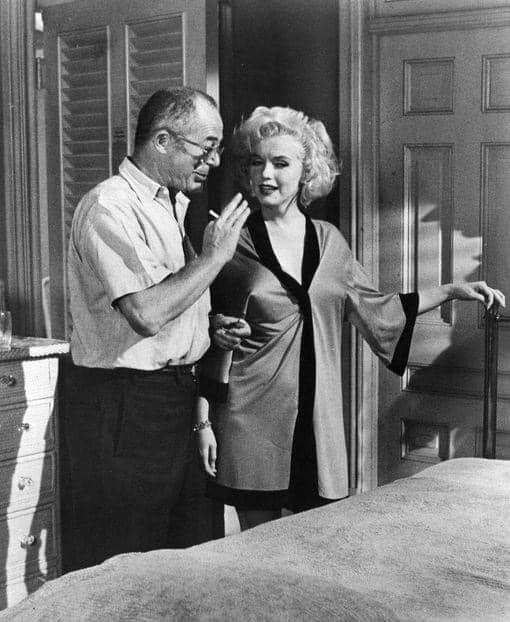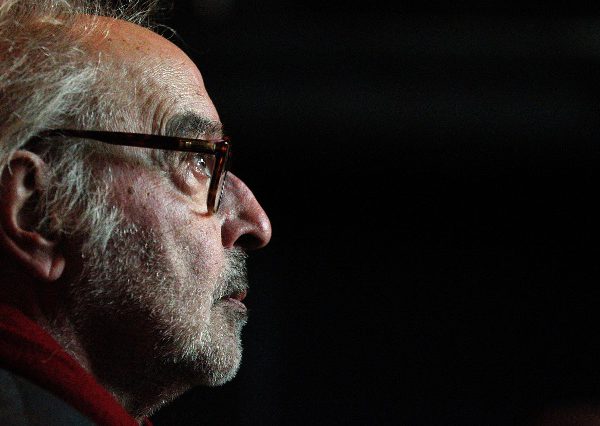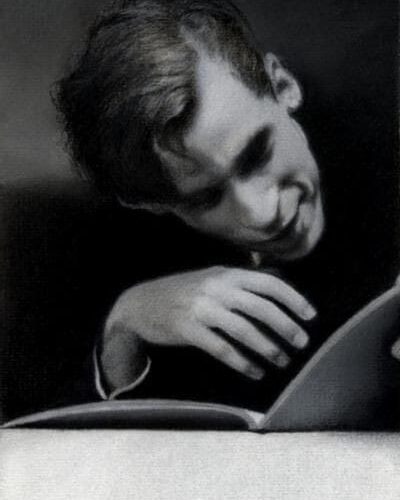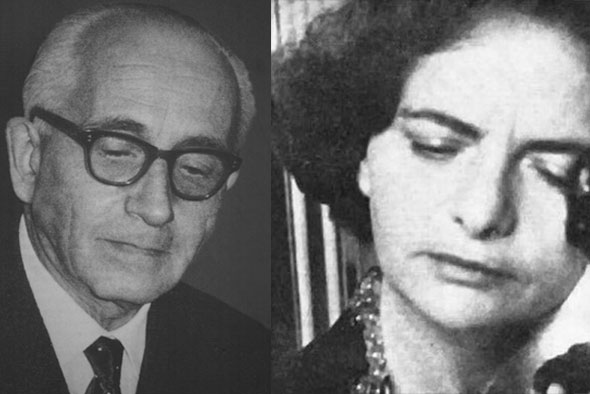Espressione Dante Alighieri Apocalypsis cum figuris (tempo primo): Chi getta via la sapienza e la dottrina è infelice!
Il pozzo del passato: mito, origine, lingua, poesia
La provenienza essenziale, il salto instauratore
La mente presaga, la visione onnisciente
«Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?»
Conversione e Rivelazione, Poesia e Filosofia
Primiloquium, la Parola che (av)viene prima
Origine “davanti a noi”, ritorno alle cose stesse, “là dove già siamo”
«Mare non notum», da Ovidio a Dante: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»
«Non Enea, non Paulo sono». E dunque?
Poesia come “stato di necessità”: la lingua “discordante”, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari”
«Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi»
«Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete»
La parola “generativa” contro la rappresentazione fintamente “creativa”, prevedibile e ripetitiva
Dante nel vestibolo dei nostri frammenti: Friedrich Hölderlin, Martin Heidegger, Thomas Mann, Luigi Pareyson, Furio Jesi, Maurice Blanchot, Karol Kérenyi, Walter Benjamin.
Leggi tuttoLa provenienza essenziale, il salto instauratore
La mente presaga, la visione onnisciente
«Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?»
Conversione e Rivelazione, Poesia e Filosofia
Primiloquium, la Parola che (av)viene prima
Origine “davanti a noi”, ritorno alle cose stesse, “là dove già siamo”
«Mare non notum», da Ovidio a Dante: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»
«Non Enea, non Paulo sono». E dunque?
Poesia come “stato di necessità”: la lingua “discordante”, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari”
«Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi»
«Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete»
La parola “generativa” contro la rappresentazione fintamente “creativa”, prevedibile e ripetitiva
Dante nel vestibolo dei nostri frammenti: Friedrich Hölderlin, Martin Heidegger, Thomas Mann, Luigi Pareyson, Furio Jesi, Maurice Blanchot, Karol Kérenyi, Walter Benjamin.
Espressione Dante Alighieri Apocalypsis cum figuris (tempo primo): Chi getta via la sapienza e la dottrina è infelice!
Il pozzo del passato: mito, origine, lingua, poesia
La provenienza essenziale, il salto instauratore
La mente presaga, la visione onnisciente
«Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?»
Conversione e Rivelazione, Poesia e Filosofia
Primiloquium, la Parola che (av)viene prima
Origine “davanti a noi”, ritorno alle cose stesse, “là dove già siamo”
«Mare non notum», da Ovidio a Dante: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»
«Non Enea, non Paulo sono». E dunque?
Poesia come “stato di necessità”: la lingua “discordante”, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari”
«Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi»
«Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete»
La parola “generativa” contro la rappresentazione fintamente “creativa”, prevedibile e ripetitiva
Dante nel vestibolo dei nostri frammenti: Friedrich Hölderlin, Martin Heidegger, Thomas Mann, Luigi Pareyson, Furio Jesi, Maurice Blanchot, Karol Kérenyi, Walter Benjamin.
Leggi tuttoLa provenienza essenziale, il salto instauratore
La mente presaga, la visione onnisciente
«Chi è costui che sanza morte / va per lo regno de la morta gente?»
Conversione e Rivelazione, Poesia e Filosofia
Primiloquium, la Parola che (av)viene prima
Origine “davanti a noi”, ritorno alle cose stesse, “là dove già siamo”
«Mare non notum», da Ovidio a Dante: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»
«Non Enea, non Paulo sono». E dunque?
Poesia come “stato di necessità”: la lingua “discordante”, “l’intrinseca mutevolezza dei volgari”
«Sembrano soli (i poeti), ma sempre hanno presagi»
«Cominciai dunque a dire: Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete»
La parola “generativa” contro la rappresentazione fintamente “creativa”, prevedibile e ripetitiva
Dante nel vestibolo dei nostri frammenti: Friedrich Hölderlin, Martin Heidegger, Thomas Mann, Luigi Pareyson, Furio Jesi, Maurice Blanchot, Karol Kérenyi, Walter Benjamin.